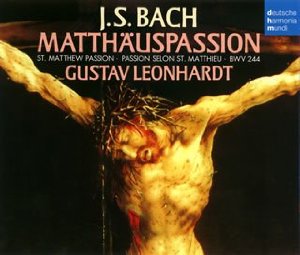Backstage: Il Teatro di Verdi in scena e DVD - Intervista di Operadisc a Elvio Giudici
Aggiunto il 21 Ottobre, 2012
 In Italia esistono due categorie di melomani: quelli che hanno letto “L’opera in CD e video” di Elvio Giudici e i bugiardi.
In Italia esistono due categorie di melomani: quelli che hanno letto “L’opera in CD e video” di Elvio Giudici e i bugiardi.
Lo diciamo volentieri e apertis verbis, a ovvio vantaggio di quelli che fanno finta di non averne mai sentito nemmeno parlare. In realtà, sappiamo benissimo che se ne parla, sempre e comunque.
Giulio Andreotti diceva: “Bene o male non importa, l’importante è che se ne parli”; e Giudici, per niente banale, con le sue parole ha sempre la capacità di far parlare di sé.
Ciò premesso, è innegabile il contributo che questo signore ha dato alla formazione culturale di noi tutti appassionati di teatro d’opera in musica.
Ha preso per mano quelli della mia generazione sin dagli Anni Settanta raccontandoci i dischi d’opera di cui ci nutrivamo quando non esisteva internet per scaricare gli spettacoli, quando non si parlava ancora nemmeno di VHS e quando uscire dai confini della propria città per vedere uno spettacolo d’opera era davvero un’impresa; e allora il disco era un modo per sopravvivere al provincialismo, vecchio problema di tutti i sedicenti appassionati che ancora lo vivono in varie forme, ivi compresa quella di rimanere attaccati ai propri totem senza nessuna apertura al mondo circostante.
Ai nostri occhi di appassionati obbiettivi e oggettivi gli vadano alcuni meriti fondamentali: rigore documentario, approccio storico, ricerca della teatralità come valore fondamentale, mai disgiunto da quell’amore profondo per la voce umana che lo ha sempre contraddistinto; tutti obbiettivi che anche noi di Operadisc abbiamo sempre condiviso, anche se con esiti non di rado diversi.
Parliamo volutamente di “teatro d’opera” per due motivi: prima di tutto perché nel nostro sito abbiamo sempre messo il teatro al centro dei nostri pensieri; e secondariamente perché il teatro, in particolare quello verdiano, è oggetto dell’ultimo libro di Giudici – “IL TEATRO DI VERDI IN SCENA E DVD” – in uscita il 9 novembre ancora per
i tipi de Il Saggiatore.
È per noi di Operadisc un grande onore che il grande critico abbia accettato di scambiare due chiacchiere amichevoli, per fare il punto della situazione sul suo modo di vedere e vivere il teatro d’opera in genere e quello verdiano in particolare, ancora una volta al centro del suo lavoro.
Lo incontriamo nella sua bella casa di Milano, che divide da sempre con Giancarlo Cerisola.
La casa è come ogni appassionato se la immagina: dischi e video dappertutto, praticamente il paradiso di ogni melomane. È emozionante scorrerne le copertine avendo in mente quello che lui ci ha raccontato su ognuno di questi titoli.
Anche nella conversazione, Elvio è come appare nei suoi scritti: un fiume in piena. Sorridente, ti travolge con la forza delle sue argomentazioni. Quando parte, è difficile stargli dietro.
Sappiamo del suo amore per il cinema, per cui iniziamo con una citazione cinematografica e cogliamo nel segno.
OPERADISC:
“Essere John Malkovich”. Come si diventa Elvio Giudici? Che percorso hai fatto per diventarlo?
GIUDICI:
Ma io credo di non essere “diventato” proprio niente: sono rimasto sempre Elvio, magari solo molto più vecchio e un po’ più pratico nell’organizzare un discorso sul teatro musicale rispetto a quando ho cominciato a scrivere sulla neonata rivista Musica trentacinque (gasp, 35!!) anni fa.
Se c’è una cosa che vorrei chiarire subito circa il “come si diventa”, è quella di non essermi mai ritenuto uno di quegli strani animali esotici noti come “maître-à-penser”: non foss’altro perché per somma fortuna io sono dotato d’un fortissimo istinto da bastian contrario.
Sicché a quei tipi lì avrei potuto sempre rivolgere la bella frase di Kipling “non siamo dello stesso sangue tu ed io”, nonostante quand’ero giovane fossero molti di più, molto più agguerriti, molto più riveriti, moltissimo più assolutisti, dunque spesso da seguire perché in genere
 portatori di pensiero utilissimo da conoscere: però talmente Evangelisti nel modo, da ribadirmi sempre più fermamente nelle mie posizioni agnostiche.
portatori di pensiero utilissimo da conoscere: però talmente Evangelisti nel modo, da ribadirmi sempre più fermamente nelle mie posizioni agnostiche.
Dunque ho cominciato a scrivere recensioni di dischi nel più puro spirito di quella rivista al suo nascere.
Un sacco di intellettuali musicali, all’epoca, snobbavano il disco perché, si sa, “la musica va ascoltata di presenza”, sentenza che m’è sempre parsa una variante della scoperta che l’acqua calda ha temperatura superiore alla fredda.
Sicché, l’idea di partenza era mettere insieme un gruppetto di appassionati di musica, affinché tutti scrivessero esattamente come se ci si parlasse tra noi in uno dei nostri salotti, cosa che d’altronde usavamo fare spesso.
Suppongo che fosse, allora, un po’ lo spirito col quale oggi si forma un gruppo in web. Solo che si trattava d’un gruppo molto ristretto, giusto quel filo snob necessario per rintuzzare i Soloni di cui sopra che ci guardavano all’inizio come dei poveracci ma dopo nemmeno tanto tempo (“posso ben dirlo adesso”, come Mimì) non mancarono di farsi avanti chiedendo a più riprese di collaborare.
Nessun darsi arie, sia chiaro; però è stato bello. La rivista, grazie agli sforzi di Umberto Masini che la dirigeva con dedizione incredibile; un po’ ai nostri che scrivevamo gratis (scusami, ma anche questo ha svolto una sua non piccola parte nella “tipologia del prodotto”, come s’usa dire); e molto, anche, grazie a una situazione epocale in cui si tendeva troppo a parlare dei Massimi Sistemi per preoccuparsi di quisquilie quali l’interpretazione: la rivista, insomma, andò. E noi finimmo col “farci un nome”, se davvero possiamo dir così.
Poi, nel ’95, Masini ebbe l’idea di metter su un numero speciale dedicato all’opera, con le recensioni delle uscite più importanti, che avrei dovuto organizzare io. Mi ci sono messo d’impegno: troppo d’impegno, il materiale cresceva eccedendo la semplice raccolta di pezzi già pubblicati, estamparlo avrebbe comportato un onere troppo gravoso per la rivista.
Da qui cauti passi verso l’editoria, nella quale si sparse la voce e Luca Formenton, proprietario del Saggiatore ma anche abbonato a Musica dai primi numeri, m’ha telefonato chiedendomi di essere lui il mio editore, senza neppure aver letto una riga di quello che sarebbe poi diventata la prima edizione del libro, perché ormai poteva dire di conoscermi anche senza avermi mai visto. C’incontrammo, andammo subito d’accordo, m’ha incoraggiato a finire il lavoro senza più preoccuparmi delle dimensioni. Cosa, questa, sempre pericolosissima trattandosi del sottoscritto. Io tendo un po’ a dilungarmi, ma sempre per via dell’assunto di partenza, del marchio DOC di Musica, se posso dir così: non è mai bello affermare una cosa, quasi pretendendo che “tanto basta la parola”, proprio perché il primo ad avere un moto da bastian contrario sarei io; preferisco diffondermi sul perché una tal cosa mi piace oppure no. Così, chi non è d’accordo ha tutte le pezze d’appoggio per motivare il suo dissenso: e almeno, ci sono gli argomenti per discutere.
Questo, ovviamente, al di là dei gusti personali che sono sempre e comunque insindacabili.
Ci sono autori che mi piacciono di più, altri di meno, altri niente del tutto, altri li considero compagni inscindibili del mio personale - e ormai lunghetto, ahinoi – percorso esistenziale: ma se parliamo di interpretazione, l’amare o no un certo settore musicale c’entra niente. Stessa cosa, se possibile anche più decisiva, per gli interpreti. Credo sia chiarissimo chi mi piace molto, chi meno, chi niente del tutto: però credo (credo, sia chiaro: sempre difficile guardarsi dal di fuori) d’aver anche sempre scritto “perché”
OPERADISC:
La recensione: arma o strumento?
GIUDICI:
Ma perbacco: strumento, solo strumento. Né arma né tantomeno consiglio per gli acquisti. Parere: motivato, se possibile. Magari drastico, masempre per amore di maggior chiarezza.
In questo, forse - ma con cautela – ci può essere una tal quale continuità tra me e Rodolfo (Celletti, ndr): poco o punto margine per l’ambiguità, per lo sfumato sia del “male, però c’è da dire…”, sia del “bravo, però…”. E semmai, io parto molto più spesso per la tangente, e quando m’entusiasmo lo faccio per davvero. Cerco anzi di farlo più spesso che posso: alla mia età, se non riuscissi più a entusiasmarmi per niente credo non metterei più piede in teatro e butterei via tutti i miei dischi (ci vorrebbero tanti sacchi della spazzatura, ho idea). In questo, Rodolfo era più circospetto; diceva che non bisognava mai lasciarsi andare troppo nella lode, sennò non ti leggono. Ho sempre sperato non fosse vero. Ma a questo proposito, voglio essere drastico: mi fanno sinceramente pena, quelli che (e sono tanti) si ritengono depositari del “verbo cellettiano”, del quale replicano pateticamente locuzioni e motti tranchant distribuendo insulti e derisioni da Basso Impero o da Grande Fratello, che è lo stesso. Con un lessico balbuziente in luogo della prosa di tutt’altra levatura dell’originale, e replicando punto per punto assiomi e idiosincrasie che hanno adesso quasi quarant’anni in più sul groppone. È cambiato quasi tutto, nel mondo e quindi anche nello spettacolo, nel modo di comunicare emozioni, insomma tutto: e loro sono ancora là (“lo strapotere delle case discografiche”, persino, o “prodotto da marketing”, Gesù che pena)
OPERADISC:
A tale proposito, permettici un inciso: si parla spesso di una continuità di tematiche e contenuti fra Rodolfo Celletti e Elvio Giudici?
GIUDICI:
Ecco, questa cosa è tornata fuori spesso: sono proprio contento di fare il punto.
Ma io, come ripeto, lo conoscevo da un sacco di tempo. Leggevo Discoteca dai primi numeri, e Celletti per il canto (NON per il teatro. Ma per il canto sì), al pari di Rattalino per il pianoforte, mi hanno semprefornito materia su cui riflettere: ricordo che all’epoca ero ancora al liceo, sicché avevo ancora un sacco di cose da imparare.
Così, leggevo i sacri tomi musicologici di allora, ma tanto anche di critica: cinema, prosa, musica. In quest’ultimo settore Discoteca svolgeva ruolo importante, quasi come il mitico Cinema nuovo di Aristarco. Ma altrettanto importanti erano gli articoli di Vigolo e Arbasino sul Mondo, una rivista a cui mio padre era abbonato e che pertanto ho avuto modo di leggere fin da quando ero alle medie, con vantaggio incalcolabile (credo non esista più, nell’editoria attuale, qualcosa che possa essere comparabile); il mio critico favorito, comunque, fu da subito - e sempre rimase - Fedele D’Amico sul Contemporaneo, la Nuova Rivista Italiana, poi L’Espresso. Perché forse più di tutti? Perché Lele D’Amico - marito di Suso Cecchi - amava il teatro, e gli interpreti amava valutarli partendo ANCHE dal dato teatrale.
Celletti, comunque.
Da quella sera in poi, ci siamo visti spesso. Anche a Martina. Quando io e Giancarlo ci andavamo, eravamo stavolta sempre nel suo albergo, e la mattina in piscina eravamo convocati alla corte di Lady Maria, la moglie, che ci informava cosa dovesse piacerci e cosa no nell’intero scibile umano. Qui è stata determinante la presenza di Giancarlo, infinitamente più diplomatico e ironico cazzeggiatore di me: ha evitato che dilagasse troppo vetriolo tra me (all’epoca piuttosto vivacello) e Madame, favorendo invece lunghissime chiacchierate specie notturne con Rodolfo. Parecchie albe, ricordo: lui tra l’altro soffriva d’insonnia, Giancarlo andava a dormire, ma a me non veniva sonno perché ti assicuro che parlare con lui era oltremodo stimolante.
E sì che c’erano parecchie cose, a dividerci. Lui fascistissimo, io di sinistra. Lui parecchio apodittico, io amante dei cavilli e dei “però…”. Ma era impossibile non essere affascinati dalla profonda cultura generale, da un certo suo modo d’istituirecollegamenti, di formulare definizioni fulminanti, d’una sua tutta particolare disponibilità – l’ora tardi, magari, indulge al relax … - ad accogliere i pareri d’uno che in definitiva poteva essere suo figlio ma su cui s’informava con tatto e con una ruvidezza financo affettuosa su certi aspetti del privato che voleva conoscere non per emettere giudizi bensì per chiarirsi le idee. E difatti se l’è chiarite, facendo poi considerazioni di particolare acume che non ho mai dimenticato. Anche perché era uno che di persone ne aveva conosciute tante, facendo il dirigente della Motta.
Continuità? E chi lo sa.
Come ripeto, tantissime erano le cose che ci dividevano, e di cui difatti discutevamo animatamente. Una, soprattutto: cosa si dovesse intendere per teatro musicale.
Piazzando le pezze d’appoggio della Callas, di Visconti, ancor più di De Lullo (uno dei grandi e scandalosamente dimenticati della cultura teatrale italiana, a parer mio che una volta di più ero bastian contrario perché viceversa è sempre stato il mio regista favorito), delle cronache di gente come la Jeritza o la Welitsch (Rodolfo ammise che pure a lui Leontyne Price aveva detto d’essere stata spinta a diventare cantante d’opera l’impressione suscitatale dalla Welitsch in Salome) o tante altre, io ribadivo che il teatro d’opera non poteva essere solo canto (ANCHE canto, beninteso. Però non SOLO canto) ma anche fraseggio, accento, chiaroscuri. E che per conseguenza recitazione, ovvero regia, diventavano sempre più importanti man mano che il teatro di prosa – ma anche il cinema – spostavano il concetto di creazione d’un carattere verso una modernità o almeno una diversità che non poteva essere ignorata dal palcoscenico d’opera.
Niente.
Il cantante DEVE stare fermo con la mano sul cuore, nei concertati il personaggio su cui esso fa perno deve fare due passi avanti (citava sempre il baritono che appunto deve porsi in evidenza a “è mio sangue, l’ho tradita”), il regista èsempre un falso pensatore anche – anzi, forse soprattutto - se si chiama Strehler o Visconti (De Lullo non lo conosceva proprio: alla prosa, lui non andava mai; compagno, ahimè, di quasi tutti i critici musicali d’allora. Ma anche di adesso), Puggelli veniva convocato a Martina solo perché accettava di far stare tutti al proscenio per lo più immobili.
Però amavamo entrambi il canto come linguaggio primario del teatro musicale.
E il linguaggio si basa sulla sintassi e prima ancora sulla grammatica. Io ero disposto a tollerare errori di sintassi (di grammatica no, mai. E non lo sono neppure adesso) ove fossero anacoluti, ovvero la sintassi fallosa fosse però creativa: lui sosteneva che fuori dalle regole non si crea niente. E l’alba poteva portare un maritozzo e un caffè, ma una soluzione no.
A un certo punto proprio non ne potevo più, di Martina e dei suoi non-spettacoli: ma le chiacchierate notturne con Rodolfo – che a Milano erano troppo difficili a farsi - erano per me troppo preziose perché ci rinunciassi.
Finì nell’88 per due ragioni in poco felice contemporaneità: l’infarto di Giancarlo e la conclusione del suo incarico di direttore del festival, per vari motivi anche squalliducci che non è il caso di rivangare (anche perché il seguito di Martina è tutto là da ascoltare; ove si riesca a reggerlo). Quasi subito ci perdemmo di vista.
C’è quindi stata, tale continuità? Io credo di no, perché il teatro musicale è per me entità troppo complessa e soprattutto multiforme per poterla circoscriverla solo alla produzione del suono come tendeva a fare Rodolfo, portando purtroppo tale convinzione sia nell’insegnamento del canto sia, e questo è ben più grave, nell’organizzazione d’un festival. Discutemmo, ricordo, anche di questo. Il bello è che tale “conflitto d’interessi” (allora il termine non era ancora stato inventato) lo ammetteva candidamente, liquidandolo però con un “me ne frego” di ahimè troppo infausta memoria storicaperché avessi voglia d’insistere.
No, continuità no: però qualcosa che s’avvicinava a un’amicizia tra due persone molto diverse per età, gusti, inclinazioni, modo di vivere, questo sì, c’era. Se significa creazione d’una continuità non saprei dire, forse lo puoi fare tu.
OPERADISC:
Opera genere teatrale: ce lo raccontavi anche nel libro che parla solo di esperienze audio, quando cercavi emozione e teatralità anche al solo ascolto. Meglio la voce che canta bene e non esprime nulla, o la voce che canta meno bene (non: male!) ma esprime il teatro?
GIUDICI:
Guarda: sono a tre quarti del guado d’un libro centrato per l’appunto su questo argomento. Non so se lo finirò, per ora esce solo il capitolo riguardante Verdi che la questione l’affronta pure, purtroppo trovandosi però di fronte il paradosso d’un uomo di teatro che assieme a Mozart ritengo essere il più geniale della storia, ma che – a differenza del Mozart moderno – è stato ed è reso in maniera ancora largamente deficitaria.
Ma prendiamo una manciata di casi scelti tra i più significativi, almeno per me: il Rigoletto di McVicar; la Traviata della Netrebko, la Violetta (non Traviata: solo Violetta) della Dessay; il Macbeth di Tcherniakov.
In tutti, anche se personalmente non ho voglia di tentare l’esperimento, sono abbastanza sicuro che se mettessi su il dvd a video spento, diverse magagne (attenzione, però: magagne, non orrorosi macigni) mi darebbero parecchio fastidio, quantunque l’analisi psicologica dei personaggi credo emergerebbe piuttosto nitidamente lo stesso. Ma se ascolti GUARDANDO… (ovvero se si fosse a teatro): per trovare emozioni analogamente sconvolgenti, dovrei riandare a memorie così antiche che preferisco non ripetere perché ogni volta mi sento più vecchietto.
È quando un grande interprete incontra un grande regista, capace di sfruttarne o sollecitarne talune particolarità – fisiche, vocali, sensitive; i fattoripossono essere molti, e spesso pure imprevedibili - che può esprimersi al meglio. E quando riesce ad esprimersi pienamente, a dare al personaggio tratti che sono solo suoi, allora l’opera diventa teatro. E allora continua a valer la pena andarci.
Ma facciamo un ulteriore passo in avanti. Ogni accento o sfumatura può, in presenza d’un regista intelligente, unirsi a un gesto, un atteggiamento, una relazione con altri personaggi nonché all’ambiente che l’impostazione dello spettacolo crea: e allora abbiamo una grande interpretazione teatrale.
Però l’interpretazione solo vocale, sarà l’età che mi fa ricordare tanti esempi e tantissimi ascolti, ma continua a interessarmi. Un po’ meno, adesso, l’ammetto. Ma certe cose, nel fondo della memoria ormai sono radicate. E ogni tanto (ma no, diciamolo: ogni spesso) rigalleggiano, ascoltando una Mattila che canta Verdi o Manon Lescaut, oppure una Voigt che fa Minnie, o una Gheorghiu che fa Mimì, una Gruberova che miagola e in Germania fa credere che quella roba lì sia la scrittura di Donizetti.
Mentre il passato sta ben giù nella memoria, presente sì ma al suo posto ben contestualizzato, quando ascolto una Bartoli dire cose del tutto nuove sulla Norma facendo capire che quei duetti non anticipano Aida-Amneris (per non dire Gioconda e Laura) bensì prolungano Semiramide-Arsace.
Ascoltare a tutto campo, insomma, lasciando da parte schemi e abitudini per aprirsi ad ogni possibile sollecitazione, significa a parer mip ascoltare l’opera oggi, partecipando al teatro di oggi: ma, possibilmente, badando il più possibile a conservare al linguaggio con cui per forza di cose continua a impiegare, le sue regole grammaticali. E massima cautela nel lavoro sulla sintassi: perché il discrimine che separa neologismo o scrittura creativa dalla vaccata, spesso è molto, molto, molto esile.
OPERADISC:
Qual è il ruolo delle regie oggi? Destrutturazione = tradimento?
GIUDICI:
Mamma mia, che domanda!! Per l’appunto, occorre un libro per cercare di rispondere adeguatamente…
In sintesi: il ruolo delle regie è quello che è sempre stato, o quanto meno sempre avrebbe dovuto essere da quando s’è riconosciuta l’esigenza d’una persona diversa dal semplice buttafuori che regola entrate e uscite in uno spettacolo fondato sui teloni dipinti.
Chiaro che esistono tanti tipi di regie quanti sono i registi. Ma soprattutto, che ogni epoca ha avuto un suo modo prevalente di fare regia. È soprattutto oggi, che il ventaglio di possibilità s’è spalancato: ma solo perché è stato preceduto da moltissimi tentativi, proposte, intuizioni, fallimenti, scoperte esaltanti. Tutte cose, badiamo bene perché questo è un punto essenziale, che rapidamente invecchiano. Quello che rompe gli schemi oggi, lo si rivede l’anno dopo ed è dato acquisito. Lo si rivede dieci anni dopo, ed è il cuore della tradizione. Lo si rivede vent’anni dopo, ed è frusto come Noè. Il che, attenzione, non significa AFFATTO che si debba tacciare quello spettacolo di “sopravvalutato”, “frutto di ideologia passatista” e altre scemenze degli avanguardisti a tutti i costi e a prescindere, che per me sono altrettanto esiziali di quelli che si producono in una standing ovation per Zeffirelli nonagenario in carrozzella alla Scala per la Bohème di qualche settimana fa. È semplicemente uno spettacolo che ha svolto la sua funzione, e che va pertanto consegnato là dove appartiene: alla storia, ovverosia al dvd nel migliore dei casi, ai racconti di chi c’era nel peggiore, alle foto di scena nel pessimo. E quando si decide di parlarne, occorre SEMPRE contestualizzarlo. Usare ancora e sempre il metodo comparativo: di qui quanto si faceva nella stragrande maggioranza dei casi, di là questo spettacolo che vi si è invece messo di traverso.
La mia idea di partenza è stata questa. Se poi ho saputo svolgerla, me lo dirai tu quando e se l’avrai letto.
Circa laseconda parte della domanda.
Credo che anche qui ci sia stato un percorso. Negli anni Settanta-Ottanta, moltissimi sono stati i casi della cosiddetta destrutturalizzazione. Konwitschny, Neuenfels, persino il primo Ronconi (il suo Orlando nelle piazze, fu un avvenimento epocale, non credere a quanti cercano pateticamente di smontarlo: quando una marea di ragazzi si entusiasma e battaglia contro i denigratori, sta pur sicuro che qualcosa è passato): ma anche moltissimi altri hanno introdotto la pratica di smontare una drammaturgia, e di rimontarla oppure sostituirla a partire da un’idea posta come fulcro dello spettacolo. Caso per caso, discuteremo dunque dapprima se quest’idea sia valida oppure no, poi se e in che misura la ristrutturazione (che è sempre necessaria, perché qualcosa occorre comunque raccontararla, a teatro) è avvenuta e soprattutto se davvero ci ha detto qualcosa non di genericamente NUOVO (bruttissimo termine, questo: se ne usa e abusa troppo), ma di utile a capire meglio un testo in particolare e il suo autore in generale.
Una pratica, questa, che è partita dal teatro di prosa, estendendosi in seguito all’opera.
In Germania, per un cumulo di ragioni storiche, sociali, ideologiche, questo è avvenuto quasi in contemporanea: altrove, è stato un processo assai più lungo e accidentato. Ma è avvenuto. Tanto avvenuto, da essere ormai storia sostanzialmente passata.
Ogni tanto, da noi qualcuno alza la voce sostenendo che “bisogna opporsi”, bisogna restar fermi nella nostra tradizione, bisogna… ma a me pare si torni al credere obbedire combattere. E la battaglia è già avvenuta. Al punto che è già cominciata UN’ALTRA battaglia.
Oggi, le punte registiche più avanzate hanno smesso di destrutturare (almeno in linea di massima: Wagner resiste, ma perché quel teatro è forse il più astratto e concettuale che esista, quindi aperto a ogni possibilità. Come la tragedia greca, in fondo). Non raccontano più UN’ALTRA storia, bensìla storia che s’è sempre conosciuta. Solo, che tutto quanto è avvenuto ha fatto sì che il regista di genio la racconti adesso in tutt’altro modo. La storia è quella, ma i personaggi no. Moltissimi particolari gestuali, di relazioni reciproche, di sfumature, fanno sì che la loro fisionomia risulti infinitamente più ricca. I destrutturalisti appaiono di colpo vecchi. Pensa a Neuenfels e ai topi del Lohengrin. Pensa, più in generale, alla Bayreuth di oggi dove per voler a tutti i costi stupire, provocare, far discutere (e dimenticare i cast scandalosi nonché, spesso, le direzioni mediocri), si rischia di mettere in un unico paiolo Herheim - che è un genio autentico - o Katharina - che qualcosa da dire ce l’ha e sa anche come dirla – con un mucchio di gente che crede d’essere non capita perché troppo d’avanguardia e invece li si capisce benissimo perché ormai sono stravecchi. E difatti, i registi DAVVERO geniali (a caso: Jones, McVicar, Holten, Tcherniakov; ma sono molti di più, basta fare qualche giretto qua e là per l’Europa) a Bayreuth non li hanno ancora chiamati, e probabilmente non li chiameranno mai.
Quelli che oggi fanno regia giovane, di adesso, moderna tanto per usare il solito termine generico, sono quelli che sempre e comunque raccontano. A teatro, si racconta coi personaggi: facendo recitare chi sta in scena in modo da delineare una fisionomia, farla evolvere a contatto con le altre e con l’ambiente in cui sta. Ecco perché, a mio parere, il regista anglosassone parte già avvantaggiato. Da sempre, ma proprio da sempre e in qualunque contesto, l’attore anglosassone batte tutti. Perché? Ma per le solite ragioni: SI STUDIA. E si elimina non solo chi non lo fa, ma anche chi non lo sa fare bene. Guardiamo un qualunque sceneggiato televisivo, se proprio non si va periodicamente a Londra dove si fa la prosa migliore del mondo: trovami UN SOLO attore che non reciti da padreterno, dall’essere o non essere alla cena è servita.
E il registaanglosassone cerca QUEL materiale, nel caso lavorandoci, plasmandolo, perfezionandolo. In qualunque regia di Jones o McVicar, l’ultimo dei coristi recita ed è un personaggio. Anche, per non dire soprattutto, laddove la storia è sostanzialmente quella raccontata dal libretto.
È questo, al momento, il tipo di teatro che più mi appassiona. Ci siamo arrivati a tappe, come in qualunque altro percorso culturale dove valgono le stesse regole di Darwin: percorso affascinante. E utile, utilissimo, a conoscersi
OPERADISC:
In Wagner il teatro ha visto una notevole evoluzione di linguaggio. Con Verdi non sembra sia successo lo stesso. Perché?
GIUDICI:
Verdi mette in scena l’Uomo, non l’Umanità. E dunque, le storie che racconta sono molto più concrete, più difficili da alterare senza rischiare di far saltare così tanto i meccanismi e le logiche interne, da perdere di vista la natura profonda dei personaggi. Sempre possibile – anzi utilissimo – schematizzare, togliere tutto per lasciare solo i personaggi. Come con Shakespeare. Rischiosissimo invece, quantunque stimolante com’è sempre il caso con le idee, raccontare tutta un’altra storia. Decker ha stilizzato Traviata portandola fuori da ogni contesto sociale definito: e ha fatto un capolavoro. Tcherniakov ha piazzato Macbeth in un Est di oggi, ma i meccanismi della scalata al potere restano gli stessi; e anzi risultano sorprendentemente più nitidi – perché terrificantemente più facili, quasi ci fosse una tragica inevitabilità delle cose - se applicati da gentucola comune e abbastanza laida. Altro capolavoro, tra i massimi del teatro di sempre. Lo stesso Tcherniakov ha raccontato un’altra e tutta diversa storia col Trovatore. Lo ha fatto benissimo come sempre, lavorando di bulino sui singoli: ma l’idea non “vampa in fiamma”, restando un’idea. Carina, intrigante persino: ma solo un’idea. Che puzza di trucco.
Non c’è insomma una ricetta valida sempre. Ma la ricetta puòfunzionare molto meglio se applicata su un’altra ricetta, quale in fondo è il teatro di Wagner. Con Verdi è come con Shakespeare: puoi cambiare tutto solo nel senso di togliere tutto, ogni cosa, per concentrarti di più sulle persone. Ma se trasformi le persone in idee o peggio ancora in simboli, e se le persone le fai diventare del tutto altre, i guai possono essere tanti.
Funziona invece straordinariamente bene leggere i libretti di Verdi. Perché non sono stati letti troppo bene, in linea di massima. Si continuano a leggere calembours sulla presunta incoerenza o peggio di Simone. Si continua a vedere Rigoletto come un povero padre disgraziato, anziché il cupo animatore della sentina d’ogni vizio che invece è, vero assassino della propria figlia. Ma ANCHE padre, onde la tragica dualità che ne fa figura scultorea solo se la si fa vedere, anziché nascondere perché disturba troppo. E Violetta. E l’umanità composita dei Vespri, che a Torino è venuta di colpo fuori in tutta la sua eterna attualità, benché alquanto sminuita dalla lingua italiana in luogo dell’obbligatorio francese. Il teatro di Verdi è forse il più rappresentato, come quello di Shakespeare: ma se questo è da qualche tempo che lo si è esplorato lungo direttive meno fruste, ricoprendone tensioni e logiche in tutto e per tutto attuali, per quello s’è appena cominciato. Ma anche qui, credo sia ormai una strada aperta, e senza ritorno. Non è dunque bello, continuare ad andare a teatro per cercare d’emozionarsi a un carattere anziché a una macchinetta per buttar fuori dei suoni?
OPERADISC:
Veniamo più specificatamente al tuo ultimo libro, che – lo ricordiamo – verrà presentato il 9 novembre. Quali sono le difficoltà legate al commentare o storicizzare un’arte fatta di immagini come la regia musicale?
GIUDICI:
Credo sia quella di liberarsi da diversi pregiudizi che quasi tutti crediamo di non avere ma molto spesso sbagliando, magari anche solo a livello disubconscio.
Ad esempio il rapporto che si ha con l’estero. Vero che lo sciovinismo sia una forma di autarchica provincialata, ma la sua totale assenza rischia spesso di diventare una forma di dipendenza esterofila forse più provinciale ancora.
Sicché ritengo occorra trovare (e non è impossibile, basta guardare pronti l’entusiasmo anziché al preventivo cipiglio) un equilibrio tra la massa di spettacoli passati che formano l’indispensabile tradizione – e che ogni paese ha diversa, per un cumulo di ragioni storiche, sociali, attitudinali nei confronti di questo o quel modo d’esprimersi – e il proliferare di proposte nuove. Il passo immediatamente successivo, com’è ovvio, è stabilire se una proposta nuova sia valida teatralmente; se dice qualcosa di nuovo sull’opera e sul suo autore, e perché; se, e in che misura, ha precedenti.
Come ben sai, l’assioma “Natura non facit saltus” è alla base della corretta teoria evolutiva. Secondo me, vale anche a teatro. Difficile, anzi per me impossibile, che il nuovo sorta già bell’e compiuto in ogni sua parte come Atena dal cranio di Zeus. Ed è pertanto affascinante (almeno per me, che per dirla con Arnalta “sembro delle Sibille il leggendario antico”) scoprire le diverse tappe di tale percorso.
Anche perché è l’unico modo per restituire la dovuta dignità a spettacoli a loro tempo innovativi e poi – com’è forse triste ma nondimeno sacrosanto – tacciati spesso di sopravvalutazione proprio perché citati fino alla nausea impiegandoli quale baluardo contro presunti orrori del presente. Senza ricordarsi (e Milano, in modo particolarissimo, ha memoria corta, ondivaga, spesso proprio truffaldina nel cambio di casacca tanto repentino da far arrossire non solo San Paolo ma anche il cavallo) quanto tali spettacoli, al loro nascere, avessero quasi sempre suscitato fiere opposizioni. Poi, si sa, tutti erano “in realtà” antifascisti e callasiani.
La corretta contestualizzazione, insomma, è secondo me la cosapiù difficile ma anche più indispensabile nel valutare le tappe trascorse della storia esecutiva del teatro musicale. Coi due termini ANCHE in questo caso del tutto paritetici
OPERADISC:
Secondo te, perché ancora oggi alcuni appassionati non credono all’importanza della regia in un allestimento d’opera?
GIUDICI:
Perché il più delle volte non frequentano il teatro di prosa, e spesso neppure il cinema. C’è chi si dichiara “appassionato” ma spesso la passione si confonde con l’integralismo. La Galli Curci faceva Gilda così e cosà, ergo la Damrau “non sa cantare”. La Muzio, la Sembrich, la Callas facevano Violetta così e cosà, ergo Natalie Dessay è un bluff sostenuto da quattro scalzacani di intellettuali. La Frida Leider era una grande Brünnhilde, ergo Nina Stemme non lo è. L’Alcina e l’Amina della Sutherland erano un caravanserraglio di bellurie vocali, ergo Cecilia Bartoli è una poveraccia che sta ancora lì solo perché c’è la Decca.
Coi registi è molto peggio, quantunque le basi ideologiche (oddìo, ideologiche…) siano identiche: nella didascalia c’è scritto che Rigoletto vive a Mantova, e una Mantova rinascimentale ha da vedersi; un’Aida senza Egitto è come la Carmen senza Spagna, anatema da rogo immediato; ambientare Don Giovanni nel Bronx? lapidate il regista.
Fa niente se poi proprio impostazioni siffatte inducono riflessioni decisive NON SOLO SCENICHE MA PROPRIO MUSICALI. La didascalia ha da avere identico valore della partitura. E secondo me questo significa rinunciare in partenza a ogni possibilità di teatro.
Le lettere di Verdi sono molto spesso citate a sproposito, cercando fargli dire soprattutto quel che fa comodo. Ma c’è quel passo (cito a memoria) “mi dici che la tal soprano canta come si cantava una volta; bene, sì, ma io vorrei invece che cantasse come si canterà da qui a trent’anni”; e ancora: “qui vorrei che l’artista servisse più il poeta del compositore” (cioè a dire siconcentrasse sulla recitazione anche a costo di venire a patti col canto). Cambiato qualcosa? Mi pare di no.
Vengo proprio oggi da Vienna, dove all’An der Wien è andato in scena un Trittico a mio avviso epocale, firmato da Damiano Michieletto per la regia e Paolo Fantin per le scene. Perché epocale? Perché non badare per nulla alle prescrizioni logistico-temporali sostituendole con rapporti interni basati sulla prevaricazione, sulla paternità/maternità delusa negata o incerta, non è proprio per nulla quella “trovatina” di cui sarebbe accusato da noi.
I due coniugi del Tabarro che affrontano ciascuno per proprio conto la devastazione indotta dalla morte d’un figlio. Il bambino di Angelica che non è morto ma vediamo comparire tenuto per mano dalla zia, che lo affida alla direttrice di non si sa bene se una prigione, casa di cura, luogo di rieducazione, luogo comunque regolato da violenza, anche fisica, agghiacciante; e alla fine mente dicendo che è morto per reagire alla violenza al bordo della pazzia di Angelica e anche per assicurarsi la definizione dell’asse ereditario. Lauretta incinta che mostra le stampate dell’ecografia all’ancora ignaro padre, spinto così ad assicurare “i quattrini di Buoso” per due giovinastri non si sa – ma si sospetta di sì – destinati a diventare copia conforme di Michele e Giorgetta. Bene: tutto questo, fa emergere con evidenza impressionante la VIOLENZA estrema di cui è intessuta non la storia come la si legge, ma come la si ascolta.
La regia non deve dar fastidio alla musica. Prima la musica poi le parole. Scemenze. Di tanto è più grande il teatro musicale, in quanto più nasce attorno a personaggi di cui traccia profili psicologici, loro evoluzione, loro rapporti specifici e – talora - con l’ambiente che li esprime. Le note debbono esserci, e sarebbe ben bizzarro sostenere il contrario. Ma le note debbono possedere un loro senso espressivo, e soprattutto oggi debbono pure avere un subito riconoscibileequivalente gestuale. Sennò non è teatro. È esercitazione vocale. Di livello universitario, magari. Ma Gesù, quanto possono essere noiosi, certi professori…
OPERADISC:
Quali sono, in sintesi, le differenze più evidenti fra i maggiori registi di oggi?
GIUDICI:
Impossibile riassumerle in due righe. Se uno è serio, intelligente, fantasioso, specie oggi ha a disposizione un ventaglio di possibilità dall’ampiezza enorme.
C’è chi ama destrutturare inventandosi una storia del tutto diversa attraverso la quale svolgere la tesi che a suo parere regge l’opera messa in scena: sarà bravo davvero, però, solo ove riesca poi a ri-strutturare tale storia nuova in un racconto ovunque leggibile. I quiz distraggono. Il regista ha a disposizione quaranta giorni per provare, aggiungere, sostituire, raffinare: noi una serata solamente in cui seguire quel che si vede e ascoltare quel che si sente.
Il Parsifal di Schlingensief era a suo modo geniale: ma aveva tanto materiale da riempire non uno ma sei spettacoli; e il tener dietro a tutte le suggestioni, i riferimenti, le allusioni, faceva sì che quando avevi sciolto i dubbi (o almeno ci se n’era convinti) t’accorgevi che Boulez era andato avanti e tu t’eri perso intere battute. Questo non va bene.
Inoltre, guardarsi dalla smania della drammaturgia nuova costi quel che costi e non importa in quale opera.
Il seguire un modulo espressivo tradizionale per ciò che concerne ambientazione e costumi, non implica affatto automaticamente uno spettacolo di Pier’Alli.
Sono spesso i personaggi, il come si presentano, il come vengono mossi entro uno spazio a sua volta modulato in un certo modo, a definire una storia. L’Adriana di McVicar, siamo sicuri sia roba vecchia solo perché primosettecentesca? Guardiamo meglio. L’aver accettato il coté grand’opéresco dandogli anzi il risalto reso possibile dagli spettacolari mezzi d’un palcoscenico moderno, siamo certi renda“banale” i Troiani di McVicar? Ma perché: l’impiego dello spazio, il modo di muoversi (o di NON muoversi) delle masse e dei singoli, frenesia gestuale oppure intrico di sguardi, insomma recitazione intesa all’anglosassone, non significa forse regia? Per me, anzi, è regia al più alto livello, quello che non invecchierà mai.
Proprio in questi mesi escono in dvd tre diverse Incoronazioni di Poppea.
Lo spettacolo di David Alden nacque nel 1997 a Monaco, nel quadro dell’esplosiva stagione barocca realizzata da quel genio che fu Peter Jonas, e fu una bomba che conservò parecchio della sua forza dirompente nel trasloco a Parigi. Filmata nel 2009 a Barcellona, lo stile optical art, la recitazione sempre sopra le righe, la frenesia d’accumulare gesti e situazioni smaccatamente allusive ad “altro” non è certo diventata insopportabile, perché l’intelligenza resta sempre intelligente: però sa non tanto di già visto, che vorrebbe dire poco, ma di già assimilato e digerito, sicché ADESSO profuma un po’ di artificio. Non ti dà più un pugno nello stomaco che ti costringa a porti di fronte a un sacco d’interrogativi, bensì solo un gentile – e soprattutto innocuo - buffetto.
Pizzi a Madrid è perfetto speculare di nonno Christie sul podio: intelligentissimo, coloratissimo, coltissimo. Ricrea con stile sommo un linguaggio ragionevolmente attribuibile all’epoca: sul piano speculativo, insomma, ti convince. Su quello teatrale, pensi ad altro dopo pochi minuti.
Da Oslo, lo spettacolo di Ole Tandberg (filmato tra parentesi in modo portentoso: ed è capitolo a parte ma non meno decisivo della regia su dvd) ti fa stramazzare già dopo qualche secondo, in perfetta unità d’intenti con la direzione oserei dire quasi jazzistica di De Marchi: sangue, violenza, prevaricazione, cinismo, sesso, ruotano e si sovrappongono con la frenesia nevrotica d’un balletto straniante e mortifero, nella totale assenza d’ogni riferimento di tempo o luogo. Solo persone. Veritàteatrale all’ennesima potenza.
Detto questo, nonostante le mie nettissime preferenze che cerco di non nascondere mai, non sarei propenso ad affermare che SI DEVE FARE SOLO E COMUNQUE COSI’.
Perché non c’è dubbio che l’eleganza di Pizzi, capace di dirci così tante cose sugli albori degli anni Settanta (e d’altronde, Pizzi fu lo scenografo dei Giovani; e il Pirandello, il Goldoni, il Patroni Griffi, lo Shakespeare, il D’Annunzio, il Cechov, il Pinter di quegli anni, piantarono anche grazie a lui riconosciute pietre miliari nella storia teatrale europea), oggi resta comunque un esercizio d’altissimo artigianato. L’iconoclastia figurativa e gestuale di Alden ha fatto storia, e le immagini barcellonesi ci fanno ancora capire benissimo il perché.
Solo, che gli spettacoli invecchiano.
Talora, più rapidamente delle persone: il che consola magari poco uno della mia età, ma se lo si accetta serenamente senza preoccuparsi troppo degli orologi notturni della Marescialla, credo si viva con più letizia. E con immutata voglia di andare a teatro. Magari non “Sempre per lodare le cose sante e belle” come dice la Noviziante, ma per essere disponibili ad entusiasmarsi ancora: questa, credo sia la cosa più importante
OPERADISC:
Ci sono specificità nella drammaturgia verdiana che rendono più semplice o più difficile il lavoro del regista?
GIUDICI:
Specificità no senz’altro, con simile statura teatrale. Maledizioni sì, molte. A cominciare dal grossolano equivoco del nazionalpopolare. Ogni incontro col pubblico di Riccardo Muti significava sentirsi ripetere la fregnaccia dannunziana del “pianse ed amò per tutti” e ogni volta mi alzavo e scappavo via: da cui cuore in mano, passione, il fuoco del Trovatore, le tre voci diverse per Violetta, il realismo confuso col verosimile, l’annacquamento sistematico d’ogni tratto sgradevole o persin laido in nome d’un buonismo di fondo e d’un supposto ideale etico da PrincipioMorale Superiore cui tantissimo ha contribuito nel dopoguerra l’estetica sinistrorsa del neorealismo. Remare contro questo paralizzante iradiddio è quasi altrettanto difficile dello sglassare lo strato zuccherino che avvolge la drammaturgia pucciniana.
Arduo. Ma lo si sta cominciando a fare, e con sempre maggiore decisione
OPERADISC:
Quando hai immaginato di scrivere questo libro, quali obbiettivi ti eri posto?
GIUDICI:
Di rendere conto, sia pure inevitabilmente a grandi o grandissime linee, del come e soprattutto del perché si sia passati dalle regie di Margherita Wallmann a quelle di David McVicar o Robert Carsen. Naturalmente, un conto è proporsi un obiettivo, tutt’altro è il raggiungerlo.
Però la mia età – aiutata da una memoria visiva che ho sempre avuto spiccata e fortunatamente è restata intatta - mi rende uno degli ultimi testimoni diretti di molti spettacoli dagli anni Cinquanta in poi: siano essi di prosa o lirici, che per me sono da sempre stati da porre su piano del tutto identico per quanto concerne il linguaggio TEATRALE con cui hanno a esprimersi. Quindi, ho creduto potesse essere utile aprire una personale galleria fotografica che per giunta non ho mai smesso di tenere aggiornata: da questa, può sortire uno spaccato di sessant’anni di vita teatrale che m’illudo possa essere non privo di qualche interesse
Alla fine scopriamo un altro aspetto intrigante e inedito di Elvio: l’amore per la cucina. In quattro e quattr’otto organizza un sugo di pistacchi e mandorle tritate per coprire le penne al kamut, buonissime, perfettamente al dente. Ne studiamo i gesti sapienti in cucina.
Alberto Mattioli, che ci telefona da Parigi mentre a tavola facciamo onore alla creazione di Elvio, esprime con garbo tutta la sua invidia…