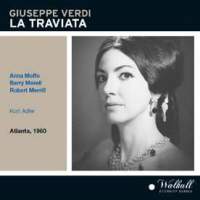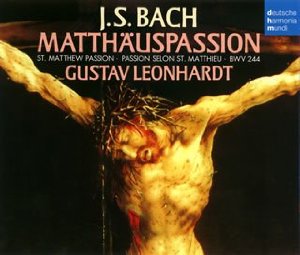Traviata
Aggiunto il 13 Agosto, 2011
Video:



|
Dopo la recente grande interpretazione di N. Dessay in Violetta ad Aix, giustamente il nostro sito è stato un po’ monopolizzato da questo notissimo titolo verdiano e questo ci fa riflettere anche in margine al thread sulla popolarità di alcune opere lungo il tempo. Possiamo dire che gli interpreti geniali fanno rivivere i capolavori e ne svelano i tratti più profondi e talvolta non detti. Oggi ammiriamo la Dessay in quest’opera e facciamo bene, come – per diverso motivo – abbiamo ammirato (e continuiamo a farlo attraverso le sue registrazioni) la Callas e stesso discorso andrebbe fatto per la Sutherland tanto per citare le grandi vocaliste del XX secolo.
Ma un caso a parte, mentre la Callas furoreggiava con titoli altisonanti, rappresenta anche la bella Anna Moffo che di voce ne possedeva più per qualità che quantità, ma la cui avvenenza ne ha fatto un must anche cinematografico. Di origini italiane, la Moffo debutta nel ’55 come Norina del donizettiano Don Pasquale per poi dedicarsi ad un repertorio lirico e lirico leggero nel quale poteva porre in evidenza la sua eleganza e signorilità. Ricordiamo qualche sua prova in tv come Madama Butterfly e Amina de La Sonnambula. In disco poi ha inciso anche una Luisa Miller e lo ha fatto con onore, ma – ci si potrebbe chiedere – sarebbe stata capace di eseguirla dal vivo? Analogo discorso (ma lì era già avanti) con una Thais e con L’amore dei tre Re con Domingo e Siepi. Una vita quella della Moffo vissuta nell’arte e che per l’arte si è spesa aggiungendo, dopo una pausa di lontananza dai palcoscenici, anche ruoli off limits come Tosca e Norma! Ma Violetta è un ruolo che le si addiceva come pochi e ricordiamo in merito il filmopera con Bonisolli ed il vecchio Bechi. Qui la Moffo poteva mettere in mostra la verve salottiera e fatua del I atto, la commozione del II e la drammaticità del III, oltre al suo indubbio fascino (alcuni primi piani dei suoi occhi sono memorabili). Le stesse avvenenza e bellezza della persona è testimoniata anche da una Lucia di Lammermoor con Kozma e Fioravanti più o meno della stessa epoca.
La presente registrazione ci permette di fissare una fotografia vocale della Moffo e ne mostra con certa realtà – non venendo distratti dalla figura – le luci e le ombre, specialmente se la si confronta con quella in studio incisa più o meno nello stesso periodo (diretta da Previtali e con Tucker per la RCA). Le prime senz’altro ascrivibili al timbro accattivante e alla signorilità del porgere, l’abilità della vocalizzazione (già ci si accorge nella frase «Ah se ciò è ver fuggitemi» e quel che segue) che, tuttavia, diviene – nonostante lo slancio – un tantino sommaria nell’impegnativo finale I dove è assente il mi bemolle, presente invece nella registrazione in studio. In questo, la Moffo è saggia perché gioca… in legittima difesa. Anche l’interpretazione non è da cestinare, ma essa si pone a confine nel discorso delle luci e delle ombre che facevamo precedentemente: commovente e umana. Le ombre invece sono imputabili alla mancanza di quello scavo della parola che altre interpreti (anche coeve) mostravano nello stesso ruolo, come non appare – neppure in controfigura – quella drammaticità di cui M. Callas si era resa modello. Faccio un paio di esempi: la risposta a Germont «Donna son io signore ed in mia casa» dà poco l’idea di persona offesa ed egualmente i tre diversi e fondamentali «È strano» di Violetta (dopo il duetto con Alfredo, dopo l’uscita di questi nel II atto e prima del breve delirio finale) sono sovrapponibili, quando in realtà non dovrebbe essere così. Meglio eseguita appare la frase, anch’essa ripetuta tre volte, «Ah perché venni incauta. Pietà gran Dio di me» alla festa di Flora. La carenza di drammaticità è evidente nell’esecuzione di «Così alla misera che un dì è caduta», ridotta ad una generica mestizia. Molto neutro, anche se elegante, il successivo «Dite alla giovane» ed egualmente poco perentorio appare il «Morrò la mia memoria», specie nella ripesa «Conosca il sacrifizio» ecc. ridotta ad una canzonetta (complice anche Adler). Intenso è invece l’«Amami Alfredo» ma qui l’orchestra poteva sostenere meglio. Molto bello l’avvio del concertato finale II della Moffo che intona in modo dolcissimo l’«Alfredo, Alfredo di questo cuore» e prosegue con un’esecuzione finissima, nonostante il cattivo pontificare di coro ed orchestra.
Inoltre in certi momenti, forse per simulare certa drammaticità, la Moffo si lascia andare a fraseggi che sanno un po’ troppo di verismo retrò (ad esempio: nella scena della borsa, rivolta ad Alfredo: «Ebbene l’AMO», oppure alla fine della lettura della lettera «È TARDI»). L’«Addio del passato» è liricissimo e concluso da un fiato interminabile e anche qui ovazione. Solo ben eseguito, ma senza lacerazione il «Gran Dio morir sì giovane…», mentre essendo di vocalità più distesa e di malinconiche tinte appare più riuscito l’«A me t’appressa amato Alfredo» con tutti i melismi ed assottigliamenti del caso.
Ne scaturisce una Violetta, eroina della quotidianità e vittima degli eventi senza quella sublimazione che, specie nel finale, ne riscatta i tratti. Tutto è svolto in modo dignitoso e se, è vero, le si può imputare la carenza di drammaticità, alla Moffo non si può riconoscere una felice raffigurazione del ruolo.
Morell è tutto sommato un buon Alfredo che si fa udire con piacevolezza nel brindisi, che sfoggia un timbro giovanile. Però l’esecuzione dei “bollenti spiriti” è meccanica e frettolosa. Inoltre il volume, non essendo molto, spesso è coperto dall’orchestra. Anche durante la partita a carte del II atto nonostante l’impegno la voce risulta un po’ lontana. Meglio la scena della borsa. Morell resta un po’ in ombra, pur eseguendo bene, nel «Parigi o cara».
Merrill inizia in tono reboante per poi dosare il suono ed offrirci un buon «Pura siccome un angelo». Incorre poi in un errore ripetendo la frase «ma pur tranquilla uditemi» omettendo l’incipit «È grave il sagrifizio». In seguito il personaggio si impone, ma un po’ a senso unico eliminando quell’aura di gentilezza e falso paternalismo che la situazione richiede, procedendo con volume alto, ma incongruo per il duetto. Buono il «Di Provenza» che, forse di tutta questa esecuzione, è il momento migliore. Il pubblico chiude con un’ovazione. Poco signorile, pur nell’asprezza del rimprovero, Merrill appare alla fine del II atto con il suo «Di sprezzo degno». Anche nella parte finale, mentre Violetta raccoglie le ultime forze per donare il ritratto ad Alfredo, Merrill torna ad essere reboante e fuori posto e con suoni non esenti da certa rozzezza.
La direzione di Adler è piuttosto sgraziata nel I atto con tratti pompier e clangori bandistici nei brani più noti (introduzione e l’accompagnamento del brindisi, l’accompagnamento al «Si ridesta in ciel l’aurora» è orrendo) con il rischio – specie per il brindisi – di soffocare i cantanti. Del resto l’orchestra è in primo piano, lasciando un po’ ai margini i solisti (la lettura della lettera al III atto è quasi inascoltabile!). Anche nelle battute di conversazione tra Alfredo e Violetta precedenti al duetto «Un dì felice eterea» si ha l’impressione di essere in un luna park, tanto l’orchestra è saltellante. Tirato via anche l’addio di Violetta ed Alfredo dopo la battuta, peraltro calante di suono, «Ebben che diavol fate» di Gastone.
Un po’ meglio il II atto (in cui è tagliata la cabaletta «O mio rimorso o infamia»), almeno nella scena Violetta-Germont, ma non ci sono particolarità esecutive da lasciare il segno, anche perché a tratti è meccanico, né caratterizza ed imprime mordente ad alcuni momenti chiave della vicenda (es. nell’«Amami Alfredo» abbiamo un mezzo deserto). Molto vivido poi l’accompagnamento dei matadori in casa di Flora che tuttavia poi degenera, ma ciò fa presa sul pubblico. Risulta velocissima la scena della borsa specie nella prima parte, a partire da «Invitato da me a seguirmi» fino a «Questa donna conoscete?».
Nel III atto il Preludio è accurato, ma se ne sono sentiti altri…. ed il resto dell’opera non presenta particolari attrattive sul piano orchestrale, per di più compaiono una serie di tagli a riprese di unisoni («Parigi o cara», «O mio sospiro e palpito…»). Brutta e pesante la chiusa dell’opera.
Tra i comprimari – nomi noti al pubblico del tempo e ai discofili – spicca la Stratas come Annina e nelle battute del III atto si nota una buona robustezza vocale. Pubblico, come ne Il Trovatore già recensito, incline ad applaudire a dismisura (la comparsa di Merrill nel II atto)
Luca Di Girolamo