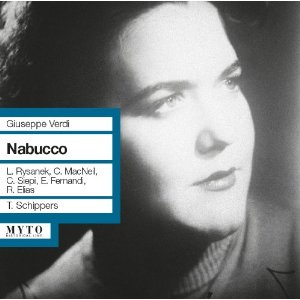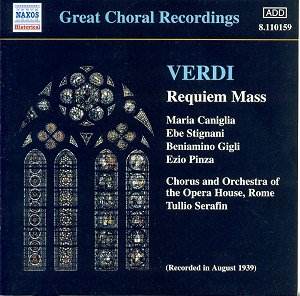Nabucco
Aggiunto il 09 Agosto, 2011
Video:

|
Peccato davvero! Così si potrebbe titolare una recensione di quest’edizione in cui in un teatro particolarmente prestigioso, un direttore di cartello e, a volte, vulcanico ed un cast molto interessante danno invece luogo ad un prodotto vicino al flop. Anzitutto una scorretta esecuzione per due motivi: i tagli feroci che amputano i da capo delle cabalette e dei concertati (specie il finale I in cui la baraonda è molto prossima e l’esecuzione è imbarazzante, oppure – addirittura!!! – nella parte finale del duetto del III atto «Deh perdona ad un padre che delira» manca completamente la parte di Abigaille «Esci! Invan mi chiedi pace») ed una bizzarra esecuzione del III atto che inizia dal fondo, ossia con «Va pensiero» e tutta la scena di Zaccaria con gli Ebrei (tracks 1-3) per poi riprendere con l’inno degli assiri ed il duetto Abigaille-Nabucco alla fine del quale il deposto re finisce in galera (tracks 4-8). Il IV atto poi riprende dalla galera («Son pur queste mie membra») e tutto è nell’ordine, ma è chiaro che la vicenda è svisata. Chissà quali ragioni ci sono dietro a questa anteposizione. Non è uno sbaglio di stampaggio di CD, in quanto controllando in rete ho trovato reclamizzata quest’edizione con il medesimo ordine dei tracks.
La direzione di Schippers è molto alterna: inizia bene con i primi accordi del Preludio molto morbidi, ma poi si rivela superficiale e questa impressione la si ritrova nei finali d’atto e in quelli delle scene in cui è un personaggio ad agire (brutta la chiusa della grande scena di Abigaille che inizia il II atto). Grinta sì, ma piuttosto combinata a superficialità soprattutto nei momenti più concitati della vicenda, mentre in quelli più lirici siamo su buoni livelli di morbidezza, anche se qui non di rado subentra la pesantezza (cf. l’accompagnamento del duetto «Oh di qual onta aggravasi»). Il Coro non si copre di gloria nell’intera opera, appare anche piuttosto fiacco nel «Va pensiero», ed evidenzia la dizione made in USA. Ma ciò che è più limitante in questa edizione sta nell’insieme di almeno 2 fattori che toccano i personaggi maggiori:
- al direttore che vorrebbe produrre qualcosa di vivido si affianca un baritono, come Mc Neil, che vanta sì una bella e morbida voce, ma non quel cipiglio guerriero che la parte – specie nei primi due atti e, in parte, nel IV – richiede e che l’orchestra a tratti sembra suggerire. Ne deriva che il «Tremin gli insani», così come ce lo propone Mc Neil, ci presenta modi che fanno ricordare più Rigoletto o Miller che consolano le rispettive figlie. È un Nabucco che canta bene, ma al bel suono unisce modi interpretativi fin troppo signorili: la stessa cabaletta del IV atto «O prodi miei», pur ben eseguita, non incita nessuno, né divampa, ad onta dell’acuto finale. Sono invece davvero belli alcuni momenti liricizzanti e tendenti all’introspezione: «Oh di qual onta aggravasi», oppure il «Dio di Giuda». Un Nabucco buono, ma non ideale.
- La Rysanek è una cantante per la quale non ho mai provato grandi entusiasmi (nemmeno per la sua tanto celebrata Lady Macbeth, personaggio spesso associato ad Abigaille in fatto di grinta, cattiveria e drammaticità), ma che era sulla carta l’attrattiva maggiore che mi ha spinto all’acquisto di quest’edizione, si rivela essere, almeno per me, l’elemento più deficitario del cast. Appare un pesce fuor d’acqua: grande declamatrice wagneriana e straussiana qui deve fare i conti con le agilità ed è negata: la cabaletta «Salgo già del trono aurato», specie nella parte finale, è disattesa. Poi gli acuti sono gridati e appaiono stridenti anche i passaggi in zona medio-acuta (il terzetto Abigaille-Fenena-Ismaele del I atto è un mezzo calvario), la dizione è, a tratti, non solo confusa ma indistinta. La voce mostra certa robustezza in centro (nonostante l’intonazione a tratti peregrina), ma in basso è intubata e lo stesso arduo «Ben io t’invenni» dell’inizio II atto, in cui avrebbe potuto far valere le sue carte in fatto di robustezza e drammaticità, è molto deludente (come del resto il suo ingresso nel I atto: «Guerrieri è preso il tempio» e quel che segue). Inoltre in certi momenti la Rysanek si inventa cadenze e cadenzine abbastanza sballate (la parte conclusiva di «Anch’io dischiuso un giorno»). Come la Callas a Napoli nel 1949, la Rysanek esegue (senza però il precedente brano «Esci! Invan mi chiedi pace») il sopracuto alla fine del duetto con il baritono nel III atto, ma la distanza tra lei e la Callas è abissale…. Per Abigaille (e non è una scoperta) non ci vuole soltanto il vocione, ma è un personaggio che, a tratti, vive di rimpianti e ripiegamenti che comportano momenti di finezza vocale. Nell’illustrare l’identità di questa eroina – non tanto cattiva, quanto sventurata (nata male e morta peggio, verrebbe fatto di dire…) e portata a reagire alla sventura con rivalsa irosa – la lettura della Scotto con Muti continua, a mio avviso, ad essere molto valida.
Restano Siepi, Fernandi e la Elias nei personaggi di contorno. Il basso milanese è veramente abile nel ritratto vocale di Zaccaria ed è la bella voce che conosciamo, grande Don Giovanni, ma esperto anche nei personaggi togati (o sacerdotali). Fernandi è generico, ma c’è da chiedersi anche quali reali possibilità offre Ismaele a chi lo canta, al di là di uno slancio esteriore, mentre la Elias tende ad ingrossare le linee di Fenena forse non accorgendosi che certi suoni in alto sono vicini al grido. Bene Franke come Abdallo e un comportamento simile alla Elias ci viene mostrato dalla Ordassy nei panni di Anna.
La resa è buona ed il pubblico è abbastanza educato nel manifestare i suoi consensi, ma dopo l’ascolto si resta con un rammarico: senz’altro poteva esser fatto di più e… meglio
Luca Di Girolamo