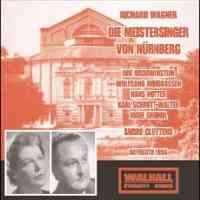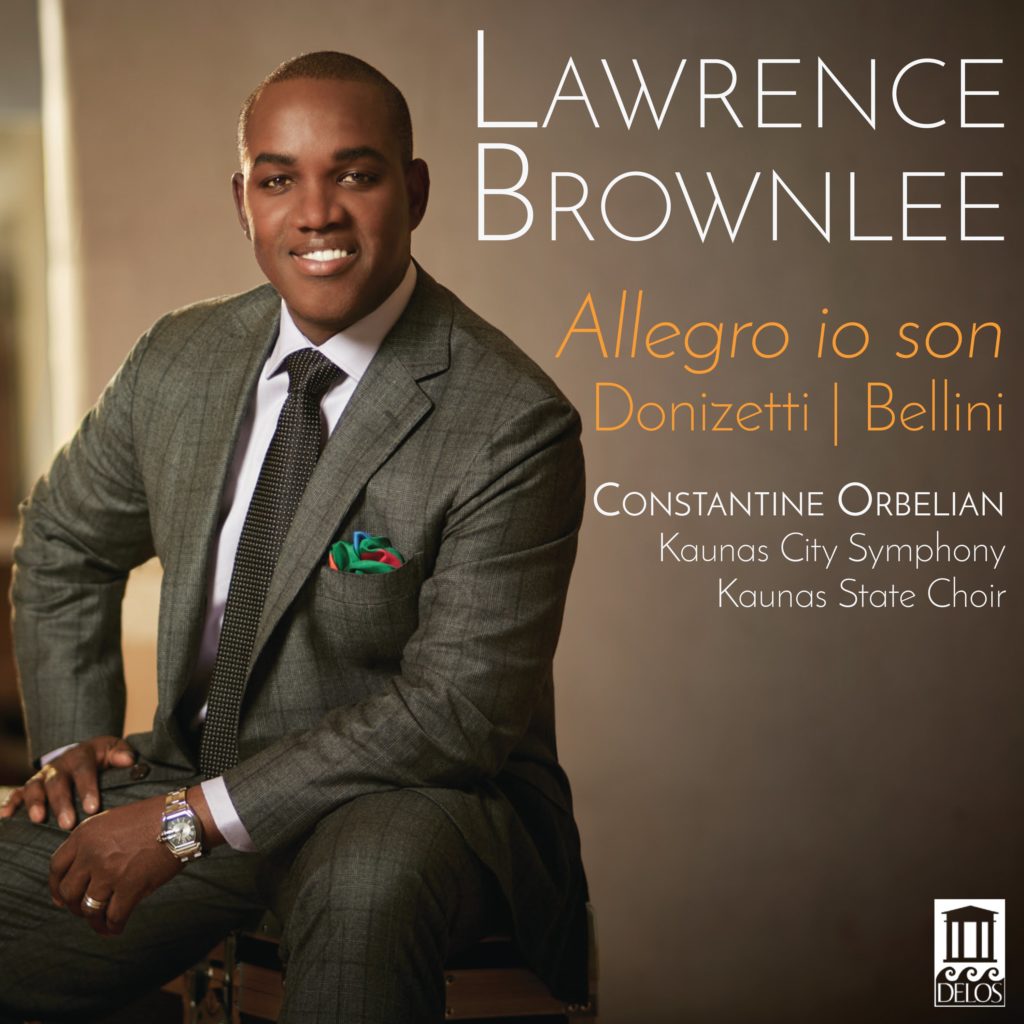Meistersinger
Aggiunto il 01 Luglio, 2011
Video:



|
Nel 1956 a Bayreuth Wieland si confrontò con la poetica dei Meistersinger ricavandone il solito spettacolo rivoluzionario, che tanto dispiacque agli spettatori affezionati ai clichè interpretativi tradizionali. Su Youtube rimane qualche frammento video ripreso alle prove che, ben lungi dal soddisfare le brame dell’appassionato, non fanno altro che incrementare la rabbia contro la scelta scellerata di non documentare meglio questi eventi.
Avendo avuto il privilegio di potermi recare a Bayreuth e proprio per i “Meistersinger” (2008, allestimento di Katharina Wagner), ho girato per negozi e bancarelle alla ricerca di un libro che raccogliesse foto degli allestimenti di Wieland. Alla mia domanda ho ricevuto cortesi ma inevitabili picche: nessuno si è fatto carico di un compito documentario così importante, il che fa specie considerando la portata rivoluzionaria di quegli allestimenti.
Tant’è. Bisogna accontentarsi di quel poco che c’è, ma è un vero peccato perché negli Anni Cinquanta del secolo scorso si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa di più per documentare la Storia che scorreva.
Fortunatamente, comunque, ci rimangono le testimonianze audio anche se, nella fattispecie, si tratta di un broadcast di veramente modesta qualità con notevoli distorsioni che, quanto a qualità della resa audio, fa rimpiangere – a stare alla sola prova del protagonista – la performance live di 7 anni prima a Monaco. Ignoro se altre etichette – come per esempio Music & Arts che ha distribuito questo live sino a un po’ di anni fa, e di fatto sostanzialmente introvabile – dispongano di registrazioni con suono migliore, ma questa non rende davvero un buon servizio ad una recita che, invece, si potrebbe collocare nei piani alti della discografia.
È chiaro che lo stile vocale è quello della Neue Bayreuth allora imperante: poche o punte concessioni a bellurie di tradizione vocalista, con ricorso a cantanti di ruolo nei grandi ruoli del Ring e al declamato più autenticamente wagneriano. In questo senso va letta, per esempio, la presenza di Gerhard Stolze, non solo grandissimo Mime (e questo non è strano: David è sempre stato interpretato dai grandi Mime), ma anche declamatore della più bell’acqua con piena padronanza di suoni resi aspri dal falsetto di cui Stolze era un magistrale utilizzatore.
Il risultato complessivo, in un’opera come questa che tenderebbe di suo al giulebbe, è di una singolare asciuttezza espressiva che non tende alla freddezza grazie alla bravura degli interpreti che puntano saggiamente al riserbo e all’accenno, piuttosto che al proclama.
Presenza magnetica e calamitante, ovviamente, è Hans Hotter che si veste dei panni di Sachs come già avevano fatto e faranno altri Wotan prima e dopo di lui, mettendo in campo come al solito la propria autorità morale temperata da una dolcezza d’espressione che sembrava animarlo sempre in questo tipo di personaggi.
Io sono fra coloro che si ostinano a sostenere che Hotter sia stato un interprete assolutamente ideale di questo ruolo. È probabile – come sostiene per esempio Giudici – che la tessitura lo mettesse alla frusta; ma è discutibile che la parte sia meglio padroneggiata da un baritono, a giudicare dal numero di bassi puri che l’hanno affrontata e tutti con notevole successo e senza particolari difficoltà: per restare ai più recenti, basterebbe pensare per esempio a Friederich Schorr, Otto Edelmann, Karl Ridderbusch, Theo Adam, Norman Bailey (quest’ultimo curiosamente anche in inglese, con Reginald Goodall), José Van Dam, James Morris, Franz Hawlata. Molti di costoro – giova sottolinearlo – sono stati anche grandi interpreti di Wotan, il che, a pensarci bene, è un aspetto discretamente inquietante.
Le linee generali del Sachs di Hotter sono ormai ben note: ampiezza quasi trucibalda di un’espressione che sembrerebbe quasi esagerata per il personaggio, se non fosse per il fatto che il genio del grande interprete la introflette e la piega alle esigenze assai più intime del ciabattino di Norimberga. L’omone enorme, forte come una roccia ed abituato a comandare, almeno per come lo vediamo di solito quando indossa le vesti del Signore dei Corvi, qui diventa quasi goffo alla presa con le baruffe dei sentimenti di due ragazzi, fra i quali ce n’è una che in via neanche troppo ipotetica potrebbe candidarsi anche al cuore del burbero protagonista. La voce e il carisma sono talmente straripanti da dare l’impressione di un transatlantico in uno stagno, ed è forse questo l’aspetto che desta maggior tenerezza. Un aspetto che avevo già riscontrato nella registrazione monacense del 1949 era il tono da “finto Wotan” con cui Hotter accoglie Eva (in quell’occasione, Annelies Kupper). Qui succede lo stesso, anche se il tono è sicuramente più carezzevole; e il colloquio riesce ad essere un po’ più variegato grazie alla non banale collaborazione di Gré Brouwenstijn, interprete molto più varia ed interessante della pur brava ma un po’ troppo floreale Kupper. Il terzo atto, in particolare, è un vero capolavoro: la costruzione del Preislied, mercé il contributo ispirato di Windgassen, è un vero capolavoro di cesello appena spruzzato di una giusta dose di bonarietà. E la perorazione finale sulla Pegnitz avrà certamente il fiatone di cui parla Giudici, ma anche un’autorità morale che non è mai stata neppure lontanamente sfiorata da nessun altro interprete.
Fa da contraltare a questa roccia di eloquenza il Beckmesser di Karl Schmitt-Walter: è bravo ma, specialista per specialista, quanto a mera qualità vocale, non si fa preferire a nessun altro interprete storico del ruolo, come Kusche o Kunz. Ciò che invece lo rende particolarmente interessante anche ai nostri giorni è, come nel già citato Stolze, l’uso sapiente del declamato, particolarmente indispensabile nel canto frastagliato di Beckmesser. In questa particolare ottica, tutta la prestazione è da incorniciare, ma in particolare tutta la puntuta diatriba del primo atto e il goffo tentativo di serenata del secondo atto, culminante in una baruffa che potrebbe essere eccellente se il direttore imponesse un ritmo appena più vivace.
Windgassen, il Siegfried di riferimento di quegli anni e di buona parte di quelli a venire, è abbastanza probabilenei panni del cavaliere sognante e (moderatamente) impetuoso. Gli manca forse un quid di aggressività in più per bilanciare quel minimo di leziosaggine che talora affiora nel suo canto, che quando fa Siegfried si scambia tranquillamente per naiveté e lo rende eccellente rispetto a chiunque altro, ma che quando si cimenta con Walther fa un po’ troppo “old style”. In più, in questa performance Windgassen suona più intonato rispetto ad altre occasioni.
La Brouwenstijn è stata una cantante molto più importante di quanto non pensi la critica italiana che, more solito, punta al suono rotondo e appoggiato sul fiato fregandosene altamente delle peculiari esigenze di questo repertorio. Gré Brouwenstijn non aveva nessun suono rotondo, essendo anzi la sua emissione molto più “matura” di quanto non consentisse la tradizione di questo personaggio, e talmente aguzza da dispiacere ai puristi del suono a tutti i costi. Con tutto questo, il suo personaggio è vivo e palpitante, ricco di sana femminilità e senso pratico; non è insomma la solita ragazzina linfatica, ma una giovane donna consapevole del proprio fascino.
Del David di Stolze abbiamo già parzialmente detto: non abbonda di “bei” suoni, ma è simpatico e domina alla perfeziona il declamato, sfogandosi spesso in un falsetto che magari inizialmente lascia un po’ interdetti, ma poi diventa quasi un accessorio indispensabile al personaggio.
Bene la von Milinkovic, pur senza punte di particolare interesse; bene Greindl, amichevole Pogner; e ottima secondo tradizione a Bayreuth la schiera dei Maestri.
Cluytens dirige in modo molto compassato e con tempi piuttosto faticosi per i cantanti già messi alla frusta dalla difficoltà di quest’opera