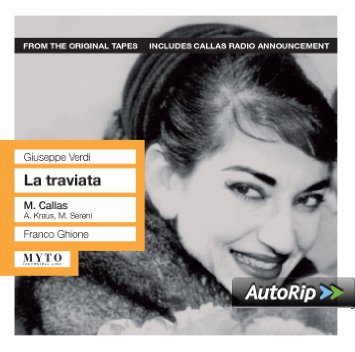Don Carlo
Aggiunto il 01 Febbraio, 2010
Dopo un live ipertradizionale del 1983 sempre dal Met (disponibile in dvd) con Domingo, Freni, Bumbry, Ghiaurov e Quilico padre, Levine sente il bisogno di ricapitolare le sue opinioni su un’opera come questa che gli è particolarmente congeniale.
Gli è adatta per temperamento: da grande direttore verdiano qual’egli è, Levine trova sempre il passo giusto in ogni situazione. E se appare financo scontato il ritmo pimpante che riesce ad imprimere al grande affresco dell’Autodafé, non minore per impatto emozionale è tutto il lungo incipit del monologo di Filippo (splendido, tra l’altro, il violoncello solista) in cui si avverte proprio la profonda riflessione del protagonista. Altrove, come nel terzetto del secondo atto, il tono passa dal fatuo salottiero a quello strettamente confidenziale con un trascolorare rapidissimo. I colori orchestrali sono vividi, cangianti come forse solo Solti e quasi nessun altro; e l’accompagnamento al canto è eccellente, come sempre con Levine. A ciò si aggiunga – come già evidenziato da Elvio Giudici – non solo la scelta dell’edizione in cinque atti (benché in italiano), ma anche la volontà di dire qualcosa di diverso sul fronte cast, mettendo insieme alcuni dei cantanti con cui aveva familiarità in quegli anni al Met, ma alcuni dei quali avevano scarso accesso alla sala di registrazione.
Prendiamo Aprile Millo. Nata nel 1958 a New York da due cantanti lirici. Dopo lo studio e la vittoria del primo premio al concorso internazionale di voci verdiane di Busseto, aveva debuttato il primo grande ruolo – Aida – nel 1980. A seguire tutto il resto – nel 1982 era già alla Scala in Ernani a sostituire Mirella Freni – che aveva definito in lei i contorni del soprano verdiano fin du siècle: voce ampia, corposa, ben sostenuta, di bel velluto, di ottimi acuti. L’interprete non è sempre stata all’altezza della beltade del mezzo vocale, ma insomma non era da buttar via: magari ogni tanto un po’ stereotipata, magari non era una di quelle cantanti per cui gli appassionati avrebbero fatto la fila di notte pur di assicurarsi un posto, ma insomma il suo bel perché ce l’aveva. Uso l’imperfetto perché purtroppo se ne sono un po’ perse le tracce, quanto meno nelle grandi produzioni; ma l’artista ritratta in questi dischi è ben più che interessante e merita un ascolto attento. La sua Elisabetta non è per nulla dimessa né penitente: è fiera ed orgogliosa e sa esattamente quello che vuole; nelle scene con Filippo se lo mangia senza nessun ritegno mentre con Carlo ha un tono sempre giusto, che sta fra il rimpianto per la felicità accarezzata e subito perduta, e la materna comprensione. La cantante è irreprensibile, praticamente perfetta per questo tipo di impegno: ottimo controllo del fiato, ben impostata secondo i canoni della più classica scuola italiana, emissione “alta”, nessuna difficoltà nel registro acuto. E, ovviamente, interprete pugnace, tanto che il “Tu che le vanità” manca un po’ di quel languido abbandono e di quella nostalgia che l’hanno meglio caratterizzato in bocca ad altre interpreti.
Michael Sylvester era, in quel periodo, uno dei tenori più utilizzati per tutte le parti da lirico spinto; nato nel 1951, la sua carriera è terminata nel 2001. Non è mai stato un vero e proprio “cavallo di razza” ma, nondimeno, il suo Carlo è uno dei migliori di tutta la discografia. Innanzitutto è molto ben cantato: ed è vero che questo è un ruolo fondamentalmente centralizzante, ma ha le sue belle difficoltà che hanno fatto impiccare più di un interprete. E poi è difficile trovare il colore giusto: melanconico senza essere lagnoso, fragile senza perdere di virilità, appassionato senza essere ossessivo. La lettura di Sylvester è estremamente sobria, pulita ed esente da lagnosità. Oltre a ciò, anche nel suo caso il canto appare di ottima scuola tradizionale.
Vladimir Chernov, baritono nato in Russia nel 1953, nel 1983 si era classificato secondo al concorso di Busseto. Per un bel po’ di tempo si è proposto come baritono verdiano, e ben se ne comprendono le ragioni ascoltando il suo canto bello, pulito, chiaro, ricco di nuances. Purtroppo a fronte di queste doti il Nostro manca un po’ di personalità: ritengo sia questa la ragione di un successo che è stato un po’ inferiore alle attese. Il riassunto di ciò è proprio in questo Rodrigo: è cantato molto bene, il suono è molto pulito, ma alla fine rimane in mano proprio pochino.
Discorso diametralmente opposto per Ferruccio Furlanetto: impostazione vocale spesso censurabile, ma personalità debordante. “Pur non basta”, come direbbe Germont padre: il suo Filippo alla fine non riesce ad essere completamente convincente e proprio per ragioni vocali: alla ricerca faticosa di un equilibrio continuo (ho ragione di pensare che non attraversasse un periodo di forma eccellente), i suoni sono talora spoggiati e il fraseggio scade nel triviale. Meglio, molto meglio il monologo in cui Furlanetto riesce a trovare un tono adeguato al momento di riflessione, anche se la sua non appare una lettura memorabile.
Più interessante l’Inquisitore di Sam Ramey che presta a questo personaggio solenne ma talvolta anche un po’ menagramo una voce chiara, limpida, squillante ma soprattutto giovanile, sana e più ricca di personalità rispetto a quella di Furlanetto. In tal modo, il grande duetto fra i due potenti è nettamente spostato dalla parte della Chiesa, già comunque destinata a soccombere.
Il sestetto dei protagonisti è completato dalla veterana Zajick. Personalmente non mi entusiasma. Grossa voce, salda e ben emessa, è tuttavia un po’ carente di armonici e manca singolarmente di sfumature. La Zajick poi, che non è mai stata una belcantista, si trova piuttosto a malpartito nei passi vocalizzati della canzone del velo, la cui esecuzione è piuttosto sciatta e ben poco interessante. Ma anche “O don fatale” in cui, a regola, ci si aspetterebbero le folgori, non è trascendentale.
Per il resto: Plishka appare poco interessato alle brevi battute del Frate/Carlo V mentre mi sembra ingiusto maltrattare la Voce dal Cielo di Kathleen Battle: non è una cantante di quelle da ricordare, siamo d’accordo, ma almeno qui non fa sentire cose invereconde.
Complessivamente un’edizione di notevole interesse per la voglia di dire qualcosa di diverso sul fronte vocale nello snodo cruciale dei primi Anni Novanta