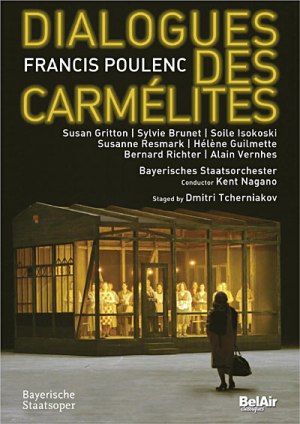Rosenkavalier
Aggiunto il 31 Maggio, 2007
Il 1976 fu decisamente un anno importante nei rapporti fra il Teatro alla Scala di Milano e il direttore più eccentrico degli ultimi trent’anni (a parte, si capisce, Sergiu Celibidache): l’Otello inaugurale e questo Rosenkavalier, testimoniato da una registrazione di buon (pur se non eccezionale) suono. E il vero protagonista è proprio lui, Carlos Kleiber, che dimostra come nell’Otello di avere un rapporto privilegiato con l’orchestra scaligera che, sotto la sua bacchetta, risuona scattante come un giaguaro e soprattutto sciorina un’iridescente varietà di colori, nuances e rubati che nulla hanno da invidiare a compagini più idiomatiche (col che si dimostra una volta di più che l’orchestra milanese non aveva proprio nulla da imparare da direttori che sarebbero venuti dopo con l’idea di cambiare drasticamente il modo di suonare).
Ma com’è la direzione di Kleiber?
Un capolavoro, né più né meno. Sonorità piene, dense, smaglianti, senza mai essere turgide. Il giusto grado di languore, senza mai scadere nel mieloso. Un rilievo appena accennato a quel valzer che torna più volte in sottofondo, quasi a proporsi come leitmotiv ma senza mai essere ossessivo: e questa è la vera chiave di volta di una lettura che sa essere nostalgica ma sempre col sorriso tenero ed affettuoso che si rivolge ad un ricordo inesprimibile. Nemmeno Karajan, il grande esegeta di quest’opera, si era spinto così in là nel dosarne alla perfezione tutti gli ingredienti, pur disponendo di cast virtualmente perfetti (forse più a Salisburgo che non nell’edizione in studio).
Sarebbe un esercizio inutile enumerare i momenti in cui Kleiber distilla autentica poesia: si va dall’inizio del primo atto, soffuso di dolce chiarore per il perfetto amalgama delle voci (perfettibili) delle protagoniste; al diabolico intersecarsi di piani sonori della matinèe della Marescialla; all’accompagnamento di Ochs, forse il personaggio che viene sviluppato maggiormente; e via via tutti gli altri episodi sino al sublime terzetto finale che raggiunge vette di tale purezza espressiva da trasportare ai confini del Paradiso il pubblico che, infatti, alla fine dell’opera fatica letteralmente a trattenere un entusiasmo strabordante, come succede solo alla Scala quando gli spettatori vengono presi per mano da personalità fuori del comune.
One man show, quindi? Sì e no: il cast è indiscutibilmente interessante, ma ben lungi dalla perfezione.
Il migliore in campo è Ridderbusch; che non avrà lo spirito viennese di Mayr, ma che dipinge un personaggio superbo, tronfio e vanesio quando occorre, fatuo come un vecchio cicisbeo di campagna, divertente e divertito, traboccante di simpatia e di calore umano. Di tutti gli interpreti in campo, è quello che meglio sembra comprendere non solo lo spirito dell’opera, ma anche la lettura di Kleiber, adattandosi come un giunco alla spinta propulsiva del direttore.
La discografia di quest’opera annovera diversi grandissimi interpreti del Bue di Lerchenau: da Mayr, a Weber, a Edelmann, sino a Moll e tanti altri, alcuni dei quali hanno saputo rendere perfettamente la joye de vivre dello spirito viennese. Ridderbusch però, gloriosamente decadente e ancora nel pieno di una superba organizzazione vocale che ne hanno fatto uno dei più grandi bassi di tutti i tempi, fa di questo personaggio un’icona della vita gioiosamente gustata e addirittura sbranata, senza curarsi tanto di travolgere altri esseri umani sul proprio cammino, ma tutto sommato senza eccessiva cattiveria, visto che ogni parola è condita da una sana dose di autoironia. E la voce nel 1976 è ancora onnipotente e in grado di far vibrare la sala del Piermarini!
Il resto del cast non è allo stesso livello, a cominciare dalla protagonista. Evelyn Lear è sulla carta una scelta azzeccata: donna brillante, charmante, cantante esperta e navigata, dotata anch’ella di una buona dose di autoironia che, in questo ruolo, è dote fondamentale. Non le fa difetto nemmeno quella vena pensosa e riflessiva che le permette di distaccarsi prontamente da un affetto che corre il rischio di farla soffrire eccessivamente: solo che, in lei, questo atteggiamento non ha niente di quell’abbandono languoroso tipicamente viennese che la Reining, la Schwarzkopf e la Della Casa sapevano profondere a piene mani: è anzi un atteggiamento un filo snob molto british che, pur essendo un punto di vista molto originale, si distacca notevolmente sia dallo spirito dell’opera in genere che dall’interpretazione veemente di Kleiber. Una prova quindi interessante, intelligente, ma piuttosto avulsa dal resto dell’esecuzione, ad ogni modo complessivamente preferibile ad altre performances più rinomate ma non così personali.
Brigitte Fassbaender ha notoriamente fatto di Octavian una personalissima icona; questa è una delle sue classiche performances in cui riesce ad essere veemente ed appassionata trovando sempre il giusto colore senza mai sbracare in un senso o nell’altro. Le preferiamo complessivamente altre interpreti, ma questa è solo una questione di gusti personali.
La Sophie della compianta Lucia Popp è un’altra grandissima, storica caratterizzazione; forse un po’ troppo pura ed un filo leziosa rispetto alle Malin Hartelius o alle Miah Persson di oggi ma, nel suo genere, godibilissima. La sua voce, nel Terzetto finale, è un tenue cristallo che si sposa magnificamente con le voci più adulte delle partners.
Senza particolari caratterizzazioni il Faninal di Wolansky, piuttosto terragno, mentre ottimo è il Cantante italiano di Savastano.
Le numerosissime parti di fianco sono affidate al meglio dei caratteristi italiani, fra i quali ci piace segnalare la bravissima Annina di Stefania Malagù, il Notaio di Morresi e la Duenna di Silvana Zanolli