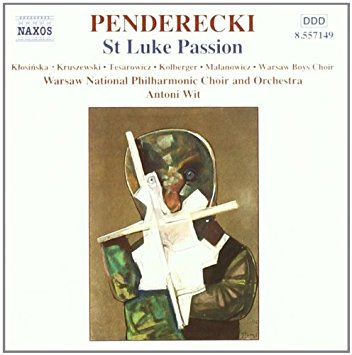Editoriale: Leyla delle maschere
Aggiunto il 13 Maggio, 2008
 Ho incrociato il nome di Leyla Gencer per la prima volta nel 1980.
Ho incrociato il nome di Leyla Gencer per la prima volta nel 1980.
Avevo 10 anni e da poco tempo avevo scoperto l’Opera, grazie a qualche vecchio 33 giri sopravvissuto in casa dai tempi del nonno.
I miei genitori, ragionevolmente sorpresi, vollero incoraggiarmi acquistando in edicola qualche titolo della serie “I gioielli della Lirica” della Longanesi.
Per chi non abbia la mia età, quella serie era composta di 80 dischi (ovviamente si parla di LP in vinile) ognuno ritagliato antologicamente su un’opera.
Oggi un’uscita del genere non farebbe molto effetto; allora fu un boom e non solo per i neofiti come me: era infatti la prima volta che venivano divulgati – e in scala vastissima – i leggendari “live” degli anni ‘50.
Per incredibile che possa sembrare ai più giovani lettori, fino agli anni 80 il mercato discografico non proponeva altro che i prodotti ufficiali; per fare un esempio, non c’era la possibilità di ascoltare l'Armida con la Callas, l’Orfeo con Karajan, il Ring con Krauss.
Certo, esistevano le reti di collezionisti che si scambiavano registrazioni su nastro effettuate privatamente dalla radio o a teatro, alimentando circuiti addirittura intercontinentali.
Talvolta queste fortunose registrazioni venivano anche messe su vinile: si trattava di edizioni a tiratura limitatissima, che in molti paesi erano fuorilegge perché violavano il diritto d’autore (da noi venivano chiamate col significativo nome di “edizioni pirata”).
Per trovarne traccia occorreva spingersi in negozietti specializzatissimi; io ne trovai uno a Parigi (“Papageno” si chiamava) a cui rivolgevo le mie ordinazioni per posta (posta cartacea, ovviamente, perché all’epoca non si parlava né di Internet, nè di e-mail).
Tutto questo traffico però era riservato a un pubblico estremamente ridotto. Gli altri (ossia i più) erano condannati a ciò che le case discografiche imponevano loro.
Negli anni ’80, come si diceva, tuttocambiò: il “live” entrava finalmente nel mercato e dalla porta principale, divenendo ufficiale a sua volta, legale e vendibile, pronto a travolgere i vecchi equilibri e a polverizzare, grazie a confronti a lungo negati, tanti miti di terracotta.
E’ su quei dischi, dai suoni talvolta confusi e lontani, che si nutrì la mia passione di piccolo operomane. Ed è sempre grazie a quei dischi che Leyla Gencer conobbe, proprio a partire dagli anni ’80, una rivincita sorprendente, che nessuno, forse nemmeno lei, aveva previsto.
Durante i suoi anni migliori alla Gencer non si erano interessati i produttori discografici e questo aveva fatto sì che il suo nome risultasse misconosciuto al grande pubblico.
Ebbene, il successo discografico dei suoi live fu tale che la critica dovette rimettere sul tappeto il suo caso e che la diva turca conobbe una sorta di glorificazione postuma.
Da piccolo “fan” che stavo diventando, ricordo l’emozione di trovare, negli scaffali dei negozi di dischi, ogni volta nuovi titoli che la ritraevano: La Francesca da Rimini e il Devereux per la Cetra, i Puritani e Rigoletto per la Foyer, la Lucia, il Trovatore, la Bolena, il Werther e infine il Macbeth per la Replica, il Boccanegra e la Battaglia di Legnano per la CLS, il Ballo in Maschera per Movimento Musica e ancora la Gerusalemme, la Beatrice di Tenda, la Bolena di Glyndebourne per la Melodram.
La Foyer fu la prima a pubblicare un cofanetto tutto dedicato a lei: si chiamava “Leyla Gencer in scena”.
Le note introduttive (che leggevo e rileggevo come se fossero un manoscritto antico) erano firmate da Giorgio Corapi. Significativamente iniziavano così:
“Tempi felici per gli estimatori di Leyla Gencer! Il periodo della “clandestinità” – quando (con notevole senso del gioco, bisogna riconoscere) traffici internazionali venivano attivati per il reperimento fortunoso di questa o quella registrazione su nastro – pare decisamente avviato altramonto. Ora abbiamo addirittura un cofanetto di due dischi, quei dischi per tanti anni negati a un pubblico che aveva tutti i diritti e tutte le ragioni di pretenderli”.
Questo nel 1981, proprio quando la “vera” Gencer stava accomiatandosi dal mondo del canto con una serie di concerti sofisticati e sorprendenti.
All'epoca non era facile nemmeno trovare informazioni biografiche su di lei. Nei dizionari di artisti, nelle enciclopedie musicali e nei who’s who talvolta non veniva nominata o al più gratificata di poche e frettolose righe.
Tutti citavano un articolo di Celletti (Discoteca 1973, con cronologia di Morino); quando finalmente ci misi le mani sopra vi trovai solo ovvietà e inesattezze.
Il “dictionnaire des interpretes” di Alain Paris del 1982 aveva l’onestà di ammettere il colpevole disinteressa che la critica internazionale le aveva riservato, ora smentito clamorosamente dal successo discografico: “Ses disques “live”, qui curieusement se multiplient, nous font découvrir à coté de quelle artiste d’exception nous sommes trop souvent passé”.
Nel 1984 ho vinto la mia ritrosia e le ho scritto una lettera: qualcuno mi aveva procurato il suo indirizzo di viale Majno. Ovviamente conservo con tenerezza la sua risposta: una fotografia con dedica e “tanti auguri per il futuro”. Nell’altro lato della foto mi scriveva (evidentemente rispondendo a mie assurde curiosità di tredicenne) “Data di nascita: 10 ottobre 1928 – coniugata, niente figli – cinque lingue”.
Nel 1986 le mie ricerche su di lei conobbero un punto fermo: uscì la biografia a cura di Franca Cella. Quel libro è semplicemente magnifico: lo è a livello critico anzitutto; lo è a livello documentario; e lo è per la bellezza della scrittura, dalle volute rigogliose e felicissime sintesi; e persino per il grazioso pudore con cui la Cella, che della Gencer era amica, dovette destreggiarsi tra il dire e il non dire, il timore di svelare angoli segreti escomode confidenze.
Ma soprattutto è un grande libro perché la Cella è riuscita a sistematizzare e storicizzare in percorsi di continuità e coerenze la carriera più informe, contraddittoria, incongrua (e per questo ricchissima) che si potesse avere.
Pochi mesi dopo, a 17 anni, incontrai Leyla Gencer davvero.
Eravamo in un paesino sperduto del veneto, Cavarzere, dove un energico barbiere del posto organizzava concerti-evento dedicati alla memoria di Tullio Serafin.
Venivano artisti da ogni dove: la Barbieri, la Stella… un anno conobbi persino la giovanissima Cecilia Batoli.
Nel 1987 ospite d’onore fu la Gencer. Essendo amico del barbiere, fui presentato alla mia Diva ed ebbi l’onore di sederle al fianco nella grande cena che seguì.
Alla mia sinistra mio padre partecipava di gusto ai lazzi sconvenienti di Fedora Barbieri; alla nostra destra mia madre e il marito della Gencer, Ibrahim, conversavano di banche, tassi di interesse e politiche economiche internazionali. Io, frattanto, parlavo alla Gencer… della Gencer, mentre lei mi ascoltava divertita.
Ogni tanto da puntiglioso ricercatore (per cui il dato storico è una cosa seria) mi permettevo di correggerla: “no Signora, non era il ’63, ma il ‘64”, “veramente nel Trovatore a Verona c’era Bergonzi” “ad essere precisi Kertesz la diresse nell’Angelo di Fuoco solo a Spoleto, non a Trieste”.
Da quella cena esaltante sono passati molti anni, più di venti.
Mi è capitato ancora, qualche volta, di vedere la Gencer, ma senza più avvicinarla; l’ultima è stata agli Arcimboldi per una Lucrezia Borgia. Soltanto in quell’occasione, depresso com’ero dalla prestazione del sopranino di turno, ho ceduto all’impulso di andare ad omaggiarla e a chiederle se ricordava la cena di Cavarzere di tanti anni prima.
Non se la ricordava. “Sa – si scusò – io ceno con tanta di quella gente!”
La si può capire, e poi vent’anni sono tanti.
Anche il mio modo di viveree ascoltare l'opera era molto cambiato nel frattempo; decisamente ridimensionato anche il mio fanatismo verso di lei.
E tuttavia mantengo, ancora oggi, una profonda ammirazione per la sua arte, che considero sempre rivelatrice.
Gli ultimi decenni della storia del canto si sono posti l’obbiettivo di spogliare il suono (anche quello operistico) della patina di artificiosità che la tradizione gli ha inflitto; e magari ridurlo alla sua essenza fisica, culturale, più pregnante.
La Gencer al contrario il suono lo adulterava in estremistici chiaroscuri, lo manipolava, lo sofisticava, lo copriva di incantevoli velluti o lo tendeva in striature aspre e dolorose.
Il suono era per lei un travestimento, un modo per mistificare le emozioni e i personaggi, per occultare la sua natura espressiva e vocale.
Per tutta la carriera si è cercata (forse e per fortuna senza trovarsi mai veramente). Si è trasformata, sperimentata e contraddetta. Non ha fatto che mettere e togliere maschere e in questo consisteva la sua instancabile, sfaccettatissima creatività.
E quando il suono, nelle sue infinite artefazioni, non bastava più a coprirla, allora intervenivano i manierismi dell’accento o del fraseggio, o la gestualità da altorilievo antico, gloriosamente primadonnesca.
Se di una cosa Leyla Gencer può considerarsi la “più grande” è proprio nella suprema civiltà dell’artifizio come sua personale risposta alla contraddizione.
Tutto in Leyla Gencer è contraddizione.
Lo è stato il repertorio, talmente incoerente da lasciare sconcertati; lo è stato il rapporto col pubblico: elitario e loggionistico insieme; lo è stata l’espressione artistica, con quella assurda mescolanza di ricercatezza ed eccesso.
Contraddittoria è stata l’audacia di trascinare la voce fra le montagne russe delle tessiture più disparate; o la pervicacia nel volerne trarre qualsiasi cosa: dalle zampate di petto alle filature celestiali, daichiaroscuri degni di una declamatrice ai picchettati netti come diamanti.
Brutta voce, si diceva…
Falso! E’ solo una delle sue maschere! La voce di suo era flessuosa, densa, timbrata, elastica, estesissima. Solo che vi si avvertiva sempre quell’eterno senso di disagio, che la rendeva così viva e personale, dovuto all’essere costantemente esplorata ai confini di sé.
Effettivamente, la Gencer non era tipo da proporsi al mondo con una verità semplice e lungamente replicabile, come – tanto per fare un esempio – fece una Price col suo “sound verdiano” o la Sutherland col suo belcantismo monocromatico e virtuosistico.
Al mondo la Gencer non poteva che offrire – a costo di non essere capita – la sua multiformità, le sue polisemie inquiete.
Istintiva sofista del canto, fantasiosa contraffattrice, non le importava “essere” ma “persuadere”, attimo per attimo, ruolo per ruolo, sfidando con insolenza quelli che non ci credono (fra cui …forse …talvolta lei stessa).
Anche teatralmente questa principessa ottomana - delle alchimie di colori e degli sguardi persi lontano – finiva per prediligere i contesti più fittizi e irreali, che meglio si adattavano alle sue maschere: è fra le cartapeste di un Medioevo romantico e improbabile, fra rocche e trovatori, o nelle corti rinascimentali di sapore scottiano che si muoveva con più naturalezza, con l’evidenza di una creatura operisticamente simbolica.
Se non la verità semplice e confortevole, quel che poteva offrire era tanto di più: ad esempio di rivelare la complessità del melodramma italiano non a dispetto, ma in virtù delle sue più irragionevoli convenzioni, delle figure retoriche, delle solite forme.
Ad esempio, si potrebbero dedicare pagine alla rivoluzione linguistica che la Gencer ha operato nel donizettiano Roberto Devereux (va ricordato che nessuna prima di lei era mai approdata ai ruoli Ronzi de Begnis, nemmeno la Callas), ma questo aspetto non basterebbe aspiegarne la grandezza.
A rendere storica la sua Elisabetta Turdor è ancora una volta (e più che mai) la maschera che è imposta al personaggio e che per la prima volta assume l’aspetto di una corona.
I metamorfici effetti chiaroscurali, le sofisticazioni sulla parola, il fraseggio dalla dinamica esasperata, insomma tutto il gioco di artifizi attuato dalla Gencer diviene qui lo specchio delle contraddizioni del personaggio.
Non regina, non donna, ma attrice dell’uno e dell’altro ruolo.
Dominatrice dominata, molto meno libera dei suoi sudditi, che dà la morte senza volerlo e vuol graziare senza poterlo, Elisabetta si schianta nell’impossibilità di comporre la multiformità del reale. Solo la Gencer, istintiva regina del fittizio, maestra di ambiguità, poteva portare a galla questo lato oscuro di Donizetti e di Cammarano.
Volete sapere quali sono stati gli ultimi personaggi teatrali di Leyla Gencer?
Qualche regina? Qualche maga? Qualche sacerdotessa?
Niente di tutto questo.
La Lady Billows dell’”Albert Herring” di Britten, vittoriana e tirannica moralista inglese, e la primadonna della “Prova di un’opera seria” di Gnecco.
Per la prima e unica volta la nostra diva ha indossato una maschera comica, con esplicito sberleffo alle tante maschere tragiche che l’avevano resa grande. E questo è stato il suo commiato, perfettamente coerente alla sua incoerenza.
Quanta malinconia suscitano certe sue più note colleghe, ridotte a sessant’anni a replicare le ennesime Lucie, Mimì o Aide tristemente incanutite. Per Leyla Gencer anche l’invecchiare, anche l’uscire di scena, anche il chiudere un capitolo di ben trentacinque anni non è altro che un sostituire la maschera.
Matteo Marazzi