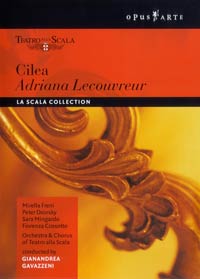Adriana Lecouvreur
Aggiunto il 18 Agosto, 2009
Alla fine degli Anni Ottanta la Scala non aveva ancora conosciuto il peggio del “mutismo” – inteso nel senso peggiore dell’autoreferenzialità che sconfina nel culto della personalità fortemente voluto dal Cigno di Molfetta che ne fu il padrone per vent’anni – ma si trovava lo stesso a dover fronteggiare situazioni non meno pesanti, come il provincialismo culturale, tara da cui non si è mai liberata, tanto che la vediamo ancora oggi.
Il provincialismo culturale è un fenomeno che porta a pensare di avere tutto il meglio possibile entro i patri confini, titoli ed interpreti: ed ecco quindi che alla Scala si allestisce un titolo minore della cosiddetta “Giovane scuola” e, anziché rinverdirlo proponendolo in un allestimento che ne esalti le modeste qualità musicali e drammatiche, si sceglie un vecchio direttore di repertorio, un tenore routinier buono per tutti gli usi (ce n’erano un bel po’ a disposizione in quegli anni) e due prime donne altrove bravissime ma che, in questo contesto specifico, non potrebbero essere più sbagliate di così. Si confeziona il tutto in uno spettacolo inesistente (tanto valeva proporre il tutto in una sala da concerto) e si ottiene un risultato che fa riflettere, perché – alla prova del pubblico – ottiene il massimo dei voti e la lode.
Perché?
Be’, è ovvio: perché il pubblico scaligero amava, e forse in fondo ama ancora, spettacoli di questa fatta. Si potrebbe stare a discettare pagine su pagine sui danni fatti da critiche egocentriche ed autoreferenziali che hanno portato in palmo di mano artisti che non avevano nessun titolo, ma sarebbe probabilmente tempo sprecato: alla fine ci sarà sempre qualcuno che rimpiange l’Adriana di Mirella e Fiorenza. E perché, dopotutto? Mancanza di validi paragoni? Sì, anche questo; ma soprattutto l’affetto per le “zie de noantri” che porteranno molti appassionati, ma anche alcuni addetti ai lavori, a rimpiangere quel particolare periodo fra gli Anni Sessanta e la fine degli Ottanta e a ricordarlo come una specie di età dell’oro dell’interpretazione (!) del teatro d’opera.
Prendiamo la Freni. D’accordo, parlarne male è come parlare male della mamma, ma proviamo a stare attaccati ai fatti. Nel 1989 ha 54 anni, un glorioso passato di soprano leggero-lirico alle spalle, una impostazione da vocalista orgogliosa e raggiante: che bisogno aveva di affrontare un ruolo così lontano dalla propria sensibilità?
Siamo d’accordo: a quel punto della sua carriera aveva lecitamente voglia di uscire dai soliti ambiti in cui il repertorio la confinava. Prudente com’è sempre stata, non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, eppure è stata abbastanza audace da tentare altre strade che non fossero le solite Mimì (che però ha avuto il torto di mantenere in repertorio anche dopo la menopausa). Inoltre, a quel punto la voce le si era inspessita abbastanza da permetterle di osare anche ruoli che non fossero le solite fanciulline un po’ lobotomizzate. Eppure Adriana le è distante le mille miglia.
Tanto per cominciare è un ruolo spesso declamatorio e lei, di formazione belcantista, è talmente lontana dalle basilari regole del declamato da trasformarne ogni passaggio in triviale parlato: e questo è un problema che ha sempre dovuto affrontare ogni volta che la scrittura scende al di sotto del rigo, con buona pace di chi dice che i suoi ruoli veristici sono affascinanti perché sono “sempre cantati”. Ma cantati dove? In che punto? Di grazia, c’è ancora qualcuno che, in pieno Terzo Millennio, sostiene che “declamare” sia una cosa diversa da “cantare”? Oppure che l’impostazione belcantista immascherata e flautata vada bene per tutti gli usi? Bene: questa “Adriana” taglia la testa al toro. Mirella, splendida vocalista, non è mai stata una declamatrice e qui lo si sente benissimo: ogni volta che deve declamare e colorire, inevitabilmente parla. Non lo sa fare. Elvio Giudici, da sempre innamorato dei dolci melismi della splendida cantante modenese, ha sempre ricordato che Mirella suonava “alto”, e questo perché la sua tecnica belcantista (non dimentichiamoci che è stata anche Elvira) la portava ad immascherare tutti i suoni. Ma il declamato per lei è sempre stato su un altro pianeta: ogni volta che si trovava di fronte ad un passaggio da declamare, in particolare in Verdi e nel Verismo, era costretta a parlare. Negarlo vuol dire quanto meno non conoscere la differenza fra declamato e parlato.
Inoltre, Adriana è un ruolo da grande tragedienne quasi sempre sopra le righe. Ci sono critici famosi da sempre appassionati della Freni in qualunque contesto, foss’anche la lettura dell’elenco del telefono: bene, possono dire quello che vogliono, ma Mirella non riforma la tradizione esecutiva di questo ruolo. Non può innanzitutto perché le manca totalmente quella sensualità di cui detti critici vogliono farle credito. Mirella è tante cose: affascinante, simpatica, spumeggiante, divertente; ma giammai sensuale. Ma non può nemmeno perché, da quella meravigliosa donna ricca di senso pratico che è, non ha nulla a che spartire con una tragedienne della Comèdie Française che recita sempre in tutto quello che fa e dice.
Ne consegue che questa è una prova largamente sbagliata, che pure riesce a raccogliere un’ovazione perché il pubblico scaligero l’ha quasi sempre amata con l’affetto che si deve ad un’amica che è in grado di raccontarci senza sussiego delle storie vecchie e passate di cottura come questa. Se oggi questo trionfo appare ampiamente immotivato dall’evidente mancanza di qualsiasi spessore drammaturgico e tecnico, ciò non toglie che sia come minimo un tributo dovuto alla carriera di una delle cantanti più importanti dell’Italia del Secondo Dopoguerra e, come tale, ha una sua ragione di essere.
Ma vogliamo parlare della Cossotto, allora? Anch’essa della classe 1935, quindi coetanea della sdora modenese, rispetto a lei appare persino più vecchia, mancandole totalmente il sense of humour e la simpatica bonomia della collega; e, a quel punto, purtroppo anche gran parte della voce, gestita evidentemente peggio rispetto alla modenese. Si prende terribilmente sul serio, madame Cossotto, abusando di terribili suoni poitrinés e svettando, appena può, con quegli acuti su cui ha costruito le ragioni di un successo che oggi vediamo assai meno rilevante di quello che all’epoca si pensava e che, in quegli anni di fine carriera, suonavamo appena un po’ meno perentori rispetto al passato. Questione di sfumature, comunque. Ho letto recentemente da qualche parte che la Cossotto gli acuti li prendeva “sul sorriso” ma, al di là di queste affermazioni da appassionati talebani, qui c’è assai poco da sorridere. Infagottata in un orribile costume settecentesco che non ne esalta per niente la linea, con un parruccone bianco che la invecchia oltre misura, la Cossotto fa la caricatura della Principessa di Bouillon, ricorrendo a smorfie e grimaces degne del cugino cattivo di Tito Gobbi: se lo Scarpia del baritono di Bassano del Grappa avesse potuto avere un contraltare femminile, questa Cossotto ne sarebbe la personificazione più affidabile. Il suo “Acerba voluttà” è staccato dal glorioso Gavazzeni con un tempo pimpante, ma da parte della Cossotto manca tutta le verità drammatica di un brano così celebre che, da sempre, è solo una palestra per la muscolarità vocale di mezzosoprani uterini che sono totalmente incapaci di far sentire femminilità rigogliosa e repressa e languido abbandono.
È logico che l’incontro-scontro fra le due primedonne porti a momenti di irresistibile ed involontaria comicità, anche per colpa della totale mancanza di un orientamento registico: fra la Freni che fa l’altezzosa sempre con il naso all’insù e la Cossotto che è la caricatura della virago raccontata da Charles Aznavour, quella “qu’a rien pour inspirer l’amour”.
Dicevamo dello spettacolo: è ripugnante. È terribile pensare che alla fine degli Anni Ottanta alla Scala si allestissero opere in questa maniera, specie considerando che nel resto d’Europa in quegli stessi anni si poteva vedere di molto meglio, ma siamo sempre costretti a tornare ai problemi della pretesa autarchia culturale. Qui, nella fattispecie, siamo al più elementare didascalismo e ai succedanei dei fondali dipinti di buona memoria. I cantanti vengono lasciati liberi di fare il poco o nulla che sanno fare per muoversi in scena e, purtroppo, nessuno dei presente appare capace di uscire dai soliti tre-quattro gesti da filodrammatica di provincia. Pietoso l’impianto scenografico di Bregni e di maniera i costumi della Spinatelli che, pure, avrebbe potuto fare qualcosa di diverso per slanciare un po’ qualche figura che ne avrebbe avuto gran bisogno.
Quanto al resto del cast, si segnala solo la prova di Gavazzi che riesce ad essere spiritoso e brillante nei panni di Chazeuil; e di una poco più che debuttante Mingardo in una delle parti di fianco.
Dvorsky è Maurizio di Sassonia; non ci fosse stato lui, avrebbero rispolverato di sicuro Merighi, Cupido oppure Aragall e, nota più nota meno, il prodotto non sarebbe cambiato. Dvorsky è simpatico, canta benino le proprie notine, con bella voce e discreto squillo, ma senza un minimo di sale né di spirito: del personaggio fatuo, vanesio, opportunista e salottiero raccontato da Colautti e Cilea qui non c’è nulla.
Cassis è anonimo e grigiastro: i suoi interventi passano del tutto inosservati. Già più simpatico Ivo Vinco, presenza come sempre tipica in ogni produzione in cui fosse scritturata la Consotto (consorte-Cossotto).
Gavazzeni riscuote un trionfo personale più che meritato: la sua concertazione è vivace, brillantissima, molto contrastata. L’orchestra della Scala, sotto la guida del suo anziano condottiero, riesce a tirar fuori un suono smaltato e prezioso che ben si fonde con quello del coro diretto, come al solito, in modo eccellente da Giulio Bertola.
Da stigmatizzare, infine, il pessimo assemblaggio della confezione che non riporta non solo un sia pur modesto booklet, ma nemmeno la data dello spettacolo, verosimilmente da dimenticare