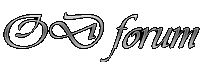Si è parlato parecchio, anche di recente, di direttori in possesso (o meno) di conoscenza ed attitudine al grande repertorio d'opera italiano. Nella generazione di coloro che stanno fra i trenta e i quarant'anni, ascolti ripetuti in questi anni (in un arco di autori che va dal belcanto al '900) mi portano ad affermare che, per "proprietà" di lettura e capacità tecnica unite ad un giusta dose di freschezza ed estro, Matteo Beltrami sia figura di spicco. Ne ho trovato conferma, nei giorni scorsi, in un fine settimana trascorso a Lubecca, nel quale la bellezza d'una città piena d'arte e di storia si è unita all'ascolto, al locale Teatro d'Opera, d'un Macbeth di Verdi per molti versi notevole, come spesso accade quando un allestimento nasce, in toto, dalla fervida collaborazione fra direttore e regista e cantanti duttili e disponibili ad un progetto non scontato.
La regia è di Alberto Triola, che firma un Macbeth "psicanalitico" assai attendibile (a parte qualche annotazione forse didascalica propria di chi ha molto da dire, e vuol dirlo) nel tema base della sterilità di Macbeth e del "senso di maternità" della Lady. In lui, la burbanza militare diviene fragilità quasi infantile nei duetti con la moglie. Nel personaggio di lei - ovviamente centralissimo, nella visione di Triola (e, del resto, in quella di Verdi) - la perversione delittuosa non è di prima mano, non esplicita salvo nell'idea registica di farle possedere Banco (tragica ironia: darà vita, in una scena del sonnambulismo trasformata in un parto agghiacciante, ad un figlio morto) ma frutto d'una "psicosi" cui concorrono sesso e desiderio di maternità. Una lady matronale e materna, che si esprime non tanto con la consueta, tagliente "cattiveria", ma con una dolcezza malata, psicotica. Una dolcezza che maschera il delitto. Malata di sesso (si porta a letto un giovane domestico) che nel marito è senza frutto, e desiderosa di procreare, fosse solo per "riprodurre" e proiettare le sue ansie di potere. Allora, ecco che sulla scena appaiono, ripetutamente, bambini (anche l'"apparizione" dei re del terz'atto, benissimo risolta è un corteo di infanti), levatrici (le streghe sono all'inizio domestiche al servizio di casa- Macbeth in un sordido scantinato, poi diventano suore-levatrici), e la Lady e i figuranti hanno spesso in mano vestitini bianchi da neonato e pannolini. Triola si serve in momenti-chiave della divisione della scena in due piani, sopra il luogo dei delitti, sotto lo scantinato (che prima diventa "caldaia" poi torna locale della servitù, per la scena del sonnambulismo-parto) . A questo progetto aderisce la Lady della brava Alessandra Rezza: vestita molto bene dai costumi di Manuel Pedretti, che ne esaltano la maternità-matronalità, dà vita ad un personaggio assolutamente attendibile nei gesti e nella voce assai bella (non è quella "soffocata" cui alludeva Verdi, ma qui il progetto è differente), duttile nelle agilità e ricca nelle dinamiche. L'emissione "di forza" degli acuti è particolare, quella "in dolcezza" (sonnambulismo) inappuntabile. Notevole prova vocale, scenica e d'intelligenza. Nella replica cui abbiamo assistito, il ruolo di Macbeth era sostenuto da Antonio Yang (alla "prima", da Gerard Quinn, di cui m'avevano detto bene): dotatissimo in volume di suono e pure ben inserito nel progetto registico, un potente-impotente nel quale convivono coraggio e fragilità. Invece, "Banco obliate" (pur se la "presenza fisica" ci sarebbe): il Banco di Martin Blasius è al di là di qualunque livello di guardia, sembra il doppiaggio italiano di Ollio nell'accento, ed emette boati. A posto gli altri.
Tutto lo spettacolo ha il suo "motore", e prende vita, dalla direzione di Matteo Beltrami. Che "crea" , in buca e sulla scena, un Macbeth mobilissimo nei tempi e nell'azione. Nella sua lettura, Beltrami ha trovato risposta volenterosa dal pur sparuto coro, e di totale dedizione da parte dell'ottima orchestra dei Lubecker Symphoniker: sicuri, duttili ed evidentemente avvinti dalla possibilità di suonare secondo una mobilità di fraseggio ed uno stile "italiano" che non gli è consueto, ma cui hanno ammirevolmente aderito. Se ne ha "spia" fin nel Preludio. La "figura" serpeggiante (odora già d'intrigo, di delitto) dei legni che apre l'opera è rapidissima, insinuante, ma termina in una pausa (già colma di terrore) dalla quale emerge, drammaticissima, la frase degli ottoni. Il Macbeth "di" Beltrami è già tutto qui, in queste note iniziali. Fremente, oppure agghiacciante nella voluta lentezza e nei silenzi, secondo quanto richiedano le azioni e gli stati d'animo. Beltrami "racconta" Macbeth , ne evoca tutto il "carico" di perversioni e umanità (ce n'è tanta, sia pur malata) grazie ad una mobilità di tempi che (in unità d'intenti con la messa in scena) non lascia sprecato un solo momento di un'opera che è forse la più "sperimentale" di tutto Verdi. Splendida ed originalissima la lettura del concertato finale atto I (forse il più bello, fra i tanti, magnifici, della produzione verdiana). L'inferno "si schiude", letteralmente, in un quasi-glissando d'orchestra. La tragedia, l'assassinio del Re, è denunciato, ma anche qui - nel delitto - la Lady si ammanta di una perversa dolcezza: e la frase "vi stampi sul volto l'impronta del primo uccisor" viene improvvisamente - è un virtuosisimo acrobatico chiesto ed ottenuto da Beltrami alla Rezza che risponde a perfezione - smorzata, assottigliata ed addolcita di colpo, con un esito espressivo (non scritto, ma "interpretato") da brivido per l'ascoltatore. Così pure, il "brindisi" è lo specchio di tutte le inquietudini: il cambio di tono della Lady, alla ripetizione, è agghiacciante: "nasca il diletto, muoia il DOLOR", là dove la parola è pronunciata e accentata (ancora duttilissima, la Rezza) con tutta l'acredine di lei per la fragilità di lui. Il fremito , e i silenzi: accade anche in "Patria Oppressa", il grande coro di dolore si chiude in un lunghissimo silenzio grazie al quale la frase "o figli, o figli miei" di Macduff pare davvero emergere da un abisso di dolore. E totalmente coerente con il progetto musicale e scenico è la scelta del finale-1847. Dalla battaglia che si quieta in orchestra, e dal silenzio, esce - dura, tragica, scandita parola per parola - l'ammissione di sconfitta del morente Macbeth ("mal per me che m'affidai...") seguita dai (rapidissimi) accordi finali: tutto è detto, tutto è compiuto, è finita. Il che, da un lato è di totale efficacia drammatica. Dall'altro grazia dall'ascolto della (ad avviso di chi scrive, e non solo) infelice marcetta della versione-1865.
Alla replica cui ho assistito (17 febbraio), pubblico attentissimo e un autentico successone, ovazione e lunghissimi applausi ritmati a Beltrami e ai due protagonisti. Altre quattro repliche, fra marzo, maggio e giugno.
marco vizzardelli
Macbeth, Matteo Beltrami, Lubecca
Moderatori: DocFlipperino, DottorMalatesta, Maugham
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Re: Macbeth, Matteo Beltrami, Lubecca
Caro Marco,
grazie dell'interessante recensione!
Una curiosità: Beltrami ha adottato l'edizione del 1847 in toto (quindi includendo "Trionfai sicuri alfine" al posto de "La luce langue", e "Vada in fiamme e in polve cada" alla fine del II atto al posto di "Ora di morte e di vendetta")? Se sì, sono state rese con qualche peculiarità registica?
Non ti nascondo che non sono molto favorevole alle versioni "contaminate" prendendo un po' dalla prima versione e un po' dalla seconda. Anche perché penso che l'edizione del 1865 debba essere considerata come quella definitiva (inclusa la marcetta finale, che peraltro è l'unico episodio di finale in forma di fuga (o fugato) insieme al Macbeth, anch'esso capolavoro verdiano tratto da Shakespeare). Ben vengano le esecuzioni della prima versione, ma che prima versione sia, non... una macedonia!!!
Un caro saluto,
DM
grazie dell'interessante recensione!
Una curiosità: Beltrami ha adottato l'edizione del 1847 in toto (quindi includendo "Trionfai sicuri alfine" al posto de "La luce langue", e "Vada in fiamme e in polve cada" alla fine del II atto al posto di "Ora di morte e di vendetta")? Se sì, sono state rese con qualche peculiarità registica?
Non ti nascondo che non sono molto favorevole alle versioni "contaminate" prendendo un po' dalla prima versione e un po' dalla seconda. Anche perché penso che l'edizione del 1865 debba essere considerata come quella definitiva (inclusa la marcetta finale, che peraltro è l'unico episodio di finale in forma di fuga (o fugato) insieme al Macbeth, anch'esso capolavoro verdiano tratto da Shakespeare). Ben vengano le esecuzioni della prima versione, ma che prima versione sia, non... una macedonia!!!
Un caro saluto,
DM
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Macbeth, Matteo Beltrami, Lubecca
Anche io non sono favorevole alle versioni contaminate o ai liberi assemblaggi fatti da questo o quel direttore: vale per Macbeth come per Tannhauser, di cui prediligo la versione di Dresda (anche se è dura rinunciare alla sensualissima musica del Baccanale), per Don Carlo(s), che preferisco in edizione italiana, per Boris, per Orfeo ed Euridice etc...
Matteo Mantica
"Fuor del mar ho un mare in seno"
"Fuor del mar ho un mare in seno"
-

teo.emme - Messaggi: 883
- Iscritto il: mar 06 apr 2010, 19:32
- Località: Crema
Re: Macbeth, Matteo Beltrami, Lubecca
Rispondo solo ora perché avevo poi spento il computer e non avevo letto le repliche. Personalmente, rispetto... il rispetto per le edizioni "pulite", come le invocano i precedenti interventi, ma non sono così assolutista. Credo di più alla presenza e all'attendibilità d'una "linea" interpretativa. Voglio dire: anche il celebre Macbeth scaligero Abbado-Strehler-Verrett ecc "contaminò", in qualche modo, le edizioni, ma fu tale la "verità" musicale e scenica di tutto quell'allestimento da farne un riferimento.
Anche in questo caso, Beltrami-direttore e Triola-regista hanno un'idea e un progetto interpretativo, per Macbeth, nel quale - a mio avviso - rientrano a perfezione, "tematicamente" ed espressivamente, sia il finale-1847 con l'ultimo monologo di Macbeth, sia, d'altra parte, "La luce langue" della Lady, che sarebbe stato assurdo eliminare dall'immagine scenica e musicale - che ho tentato di raccontare - data qui del personaggio-Lady: interiorizzata in una dolcezza malata, della quale proprio quell'aria è il momento più simbolico. Direi che, in linea di massima, come ascoltatore, non chiedo al direttore di essere un rigoroso ragioniere, ma, piuttosto, un interprete stimolante. Nel Macbeth firmato da Beltrami e Triola, mi è parso che la "contaminazione" (così come è stata chiamata) sia stata funzionale all'idea e al progetto interpretativo. E a questo punto mi sta bene. Proprio di recente, in una Lucia di Lammermoor per il Circuito Lombardo molto felice sotto l'aspetto della direzione pur problematica nell'avvicendarsi di cast differenti, Beltrami aveva "osato" affidare all'arpa la cadenza della "Pazzia". Una pazzia antifilologica? No: l'esito era talmente bello e "giusto" che.... è immaginabile Donizetti ringraziasse, di lassù. Quando il direttore "ha in mano" il lessico di un repertorio (e Beltrami lo ha, nell'arco dell'opera italiana) può farsi interprete. Anzi, a mio avviso - con tutto il buon senso e la consapevolezza possibili ma anche con un sano senso di "avventura" (la musica è tale! I Delman, i Bernstein ce l'hanno "detto" per una vita) - è bene che si faccia interprete.
marco vizzardelli
Anche in questo caso, Beltrami-direttore e Triola-regista hanno un'idea e un progetto interpretativo, per Macbeth, nel quale - a mio avviso - rientrano a perfezione, "tematicamente" ed espressivamente, sia il finale-1847 con l'ultimo monologo di Macbeth, sia, d'altra parte, "La luce langue" della Lady, che sarebbe stato assurdo eliminare dall'immagine scenica e musicale - che ho tentato di raccontare - data qui del personaggio-Lady: interiorizzata in una dolcezza malata, della quale proprio quell'aria è il momento più simbolico. Direi che, in linea di massima, come ascoltatore, non chiedo al direttore di essere un rigoroso ragioniere, ma, piuttosto, un interprete stimolante. Nel Macbeth firmato da Beltrami e Triola, mi è parso che la "contaminazione" (così come è stata chiamata) sia stata funzionale all'idea e al progetto interpretativo. E a questo punto mi sta bene. Proprio di recente, in una Lucia di Lammermoor per il Circuito Lombardo molto felice sotto l'aspetto della direzione pur problematica nell'avvicendarsi di cast differenti, Beltrami aveva "osato" affidare all'arpa la cadenza della "Pazzia". Una pazzia antifilologica? No: l'esito era talmente bello e "giusto" che.... è immaginabile Donizetti ringraziasse, di lassù. Quando il direttore "ha in mano" il lessico di un repertorio (e Beltrami lo ha, nell'arco dell'opera italiana) può farsi interprete. Anzi, a mio avviso - con tutto il buon senso e la consapevolezza possibili ma anche con un sano senso di "avventura" (la musica è tale! I Delman, i Bernstein ce l'hanno "detto" per una vita) - è bene che si faccia interprete.
marco vizzardelli
- vivelaboheme
- Messaggi: 292
- Iscritto il: ven 09 dic 2011, 20:08
Re: Macbeth, Matteo Beltrami, Lubecca
Scusate, non vorrei essermi spiegato male (cosa che mi capita spesso. Tra l´altro, rileggendomi devo riconoscere di trovarmi spesso pessimo dal punto di vista della sintassi: sará che per lo piú parlo in tedesco e scrivo in inglese… Bah! Vi chiedo scusa anche per questo).
Quando vado a teatro mi aspetto… teatro! Il teatro è la cosa principale, cosí sarei propenso ad accettare contaminazioni e persino alterazioni testuali o tagli purché giustificati e “riabilitati” in una prospettiva teatrale vera. Chiaro che mai accetterei un CD con il Macbeth di Verdi presentato in un mix delle due versioni, ma non mi straccerei le vesti se lo stesso mix fosse giustificato da una prospettiva registica convincente e avvincente. L´opera a teatro non è solo musica, è anche drammaturgia, lavoro sui personaggi… regia! Altrimenti me ne resterei a casa ad ascoltar dischi!!! E personalmente non considero necessariamente il regista come figura subordinata a compositore e librettista. Una visione gerarchica, il compositore viene primo, poi il librettista, poi i cantanti, poi il regista, poi il costumista, poi… che volete voi, è una visione che francamente non condivido del tutto. Il regista è (o dovrebbe, se di vera regia si parla) dialogare da pari a pari con l´opera che è chiamato a rappresentare. Forse talora è accettabile accettare che il regista sia un vero e proprio creatore (o co-creatore o co-autore, come volete), non un mero esecutore, un interprete o un illustratore.
Ciao,
DM
P.S.: per la pazzia di Lucia sarebbe bello poter sentire qualche volta anche la Glasharmonica (oltre che l´arpa!!!)
Quando vado a teatro mi aspetto… teatro! Il teatro è la cosa principale, cosí sarei propenso ad accettare contaminazioni e persino alterazioni testuali o tagli purché giustificati e “riabilitati” in una prospettiva teatrale vera. Chiaro che mai accetterei un CD con il Macbeth di Verdi presentato in un mix delle due versioni, ma non mi straccerei le vesti se lo stesso mix fosse giustificato da una prospettiva registica convincente e avvincente. L´opera a teatro non è solo musica, è anche drammaturgia, lavoro sui personaggi… regia! Altrimenti me ne resterei a casa ad ascoltar dischi!!! E personalmente non considero necessariamente il regista come figura subordinata a compositore e librettista. Una visione gerarchica, il compositore viene primo, poi il librettista, poi i cantanti, poi il regista, poi il costumista, poi… che volete voi, è una visione che francamente non condivido del tutto. Il regista è (o dovrebbe, se di vera regia si parla) dialogare da pari a pari con l´opera che è chiamato a rappresentare. Forse talora è accettabile accettare che il regista sia un vero e proprio creatore (o co-creatore o co-autore, come volete), non un mero esecutore, un interprete o un illustratore.
Ciao,
DM
P.S.: per la pazzia di Lucia sarebbe bello poter sentire qualche volta anche la Glasharmonica (oltre che l´arpa!!!)
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Macbeth, Matteo Beltrami, Lubecca
Vedasi la straordinaria Lucia "firmata" da Thomas Schippers, nella quale la Pazzia - con un filo di voce, ma con quale "espressione"!, della Sills, unita alla glassharmonica - dà vita ad un "momento" musicale memorabile.
marco vizzardelli
marco vizzardelli
- vivelaboheme
- Messaggi: 292
- Iscritto il: ven 09 dic 2011, 20:08
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti