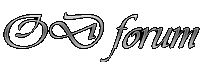Ho messo una recensione a uno dei restauri di Roberto Scandurra.
La trovate qui
nuovi articoli in home
Moderatori: DocFlipperino, DottorMalatesta, Maugham
Re: nuovi articoli in home
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: nuovi articoli in home
Conoscevo questa Carmen da una vecchia edizione Fabbri. Alcuni filmati un po' sfocati sono interessanti per capire quale recitazione fosse associata al canto di Del Monaco e della Simionato:
Mario Del Monaco - Carmen Tokyo 1959 "Flower Song"
G. Simionato & M. del Monaco "Final Scene" Carmen
Alcuni siti riportano questa locandina:
Nino Verchi (conductor)
Giulietta Simionato (Carmen)
Mario Del Monaco (Don Jose)
Gabriella Tucci (Micaela)
Sipio Colombo (Escamillo)
Santa Chissari (Frasquita)
Anna Di Stasio (Mercedes)
Paolo Montarsolo (Zuniga)
Mariano Caruso (Remendado)
Arturo La Porta (Dancairo)
NHK Symphony Orchestra
19 February 1959, Tokyo
Mario Del Monaco - Carmen Tokyo 1959 "Flower Song"
G. Simionato & M. del Monaco "Final Scene" Carmen
Alcuni siti riportano questa locandina:
Nino Verchi (conductor)
Giulietta Simionato (Carmen)
Mario Del Monaco (Don Jose)
Gabriella Tucci (Micaela)
Sipio Colombo (Escamillo)
Santa Chissari (Frasquita)
Anna Di Stasio (Mercedes)
Paolo Montarsolo (Zuniga)
Mariano Caruso (Remendado)
Arturo La Porta (Dancairo)
NHK Symphony Orchestra
19 February 1959, Tokyo
Enrico B.
- Enrico
- Messaggi: 1019
- Iscritto il: mar 17 nov 2009, 17:34
Re: nuovi articoli in home
Alcuni filmati un po' sfocati sono interessanti per capire quale recitazione fosse associata al canto di Del Monaco e della Simionato
==================================================
Una recitazione ed un canto, a mio avviso, molto datati (anche per l'uso dell'italiano) e per me inaccettabili. Scusate, ma mi dissocio da tanti plausi.
Saluti, Luca.
==================================================
Una recitazione ed un canto, a mio avviso, molto datati (anche per l'uso dell'italiano) e per me inaccettabili. Scusate, ma mi dissocio da tanti plausi.
Saluti, Luca.
- Luca
- Messaggi: 1184
- Iscritto il: ven 06 apr 2007, 0:25
- Località: Roma
Re: nuovi articoli in home
Eh! eh! tra le mie produzioni ho messo anche queste selezioni di Carmen in video, (Mosca e Tokyo riunite in unico DVD) restaurate appunto su DVD in HI-FI Stereo:
Su Youtube da tempo ho messo questo esempio, confrontate con quanto postato sopra.
Peraltro per Youtube ho dovuto comprimere il video (e di conseguenza l'audio), la la differenza con il video originale dal suono piatto e con un soffio del nastro insopportabile è EVIDENTE!!
La selezione di Carmen del Bolshoi di Mosca sempre del 1959, è molto più vasta, con Cast diverso, una vera rarità, Carmen era la compianta Irina Arckipova che canta in Russo come tutti gli altri, mentre Del Monaco in Italiano, le cronache dell'epoca raccontano che ci furono interruzioni della recita a scena aperto dopo l'aria del fiore interpretata da Del Monaco in modo superlativo assoluto, circa 30 minuti di applausi, nel filmato se ne vedono alcuni minuti. A fine recita Marione fu portato in trionfo dal pubblico che sembrava impazzito, successe solo per un altro cantante nella storia del Bolshoi: Fiodor Scialiapin.
Questo cofanetto l'ho impreziosito con un piccolo Booklet con la recensione della serata scritta da Elisabetta Romagnolo per questa occasione.
Avrei dovuto inserire questo libretto anche nella versione integrale che ho pure restaurato (solo audio su due CD), ma le dimensioni presisposte per il solo DVD non lo consentono.
Saluti
Roberto
Su Youtube da tempo ho messo questo esempio, confrontate con quanto postato sopra.
Peraltro per Youtube ho dovuto comprimere il video (e di conseguenza l'audio), la la differenza con il video originale dal suono piatto e con un soffio del nastro insopportabile è EVIDENTE!!
La selezione di Carmen del Bolshoi di Mosca sempre del 1959, è molto più vasta, con Cast diverso, una vera rarità, Carmen era la compianta Irina Arckipova che canta in Russo come tutti gli altri, mentre Del Monaco in Italiano, le cronache dell'epoca raccontano che ci furono interruzioni della recita a scena aperto dopo l'aria del fiore interpretata da Del Monaco in modo superlativo assoluto, circa 30 minuti di applausi, nel filmato se ne vedono alcuni minuti. A fine recita Marione fu portato in trionfo dal pubblico che sembrava impazzito, successe solo per un altro cantante nella storia del Bolshoi: Fiodor Scialiapin.
Questo cofanetto l'ho impreziosito con un piccolo Booklet con la recensione della serata scritta da Elisabetta Romagnolo per questa occasione.
Avrei dovuto inserire questo libretto anche nella versione integrale che ho pure restaurato (solo audio su due CD), ma le dimensioni presisposte per il solo DVD non lo consentono.
Saluti
Roberto
Roberto
-

Manrico - Messaggi: 101
- Iscritto il: mar 10 apr 2007, 18:44
- Località: Roma
Re: nuovi articoli in home
Una piccola selezione (Medley) l'ho inserita, invece, solo sul mio sito, la pagina è questa:
http://www.mariodelmonaco.net/medley_carmen_mosca.html
http://www.mariodelmonaco.net/medley_carmen_mosca.html
Roberto
-

Manrico - Messaggi: 101
- Iscritto il: mar 10 apr 2007, 18:44
- Località: Roma
Re: nuovi articoli in home
Oltre al ricordo che Alberto Mattioli ha dedicato alla morte di Joan Sutherland (in altra sezione del forum è aperta una discussione), c'è in home la recensione del recente dvd di Carmen con Elina Garanca e Roberto Alagna.
Seguiteci!
Seguiteci!
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: nuovi articoli in home
Dopo un po' di tempo di assenza ritornano in home le recensioni discografiche di Operadisc.
Stavolta ci siamo occupati del pucciniano Trittico diretto da Maazel per la Sony. Le abbiamo splittate in tre parti: Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi.
Buona lettura a tutti!
Stavolta ci siamo occupati del pucciniano Trittico diretto da Maazel per la Sony. Le abbiamo splittate in tre parti: Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi.
Buona lettura a tutti!
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: nuovi articoli in home
Ciao Pietro, ottime recensioni! Ti segnalo che nella recensione della Suor Angelica c'è un refuso: tra i pregi hai indicato Wixell.
(O forse è una malignità voluta )
)
(O forse è una malignità voluta
-

Alberich - Messaggi: 693
- Iscritto il: gio 12 apr 2007, 19:09
Re: nuovi articoli in home
Alberich ha scritto:Ciao Pietro, ottime recensioni! Ti segnalo che nella recensione della Suor Angelica c'è un refuso: tra i pregi hai indicato Wixell.
(O forse è una malignità voluta)
Ooops!
Grazie...
Corretto!
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: nuovi articoli in home
C'e un altro, ben piu' clamoroso refuso, solo tre stelle nonostante Gobbi!!! 

Il suo Schicchi e' davvero memorabile, ma di livello superiore continuo a trovare il suo Michele (mi riferisco al Trittico Emi).

Il suo Schicchi e' davvero memorabile, ma di livello superiore continuo a trovare il suo Michele (mi riferisco al Trittico Emi).
Nemmeno noi siamo d'accordo con il gobbo, ma il gobbo è essenziale! Guai se non ci fosse!
-

VGobbi - Messaggi: 2455
- Iscritto il: gio 05 apr 2007, 20:49
- Località: Verano Brianza
Re: nuovi articoli in home
In home c'è la nostra recensione del disco di Marcelo Alvarez dedicato alle grandi arie verdiane
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: nuovi articoli in home
Interessante la recensione su Alvarez, poco verdiano e sono d'accordo.
Mi viene in mente una sua bella esecuzione qualche anno fa in Lucrezia Borgia (2002), con la Devia, dove era a suo agio e la voce diventava anche molto bella con mezze voci e ottime sfumature.
Stavo rileggendo queste pagine e nuovamente mi sono meravigliato per il termine usato da Luca e da altri: “datato”, forse dimenticate che la maggioranza delle Opere sono TUTTE datate, l'Opera nasce nel lontano 1573 con Giulio Caccini e Jacopo Peri, anche se la prima vera Opera risale al 1607, cioè l'Orfeo di Claudio Monteverdi.
Nell'Opera, ripeto, tutto è datato, oggi, spesso, le rappresentazioni, quando si cerca di farle in modo più moderno con nuovi allestimenti che stravolgono completamente il dettato degli autori, fanno rizzare i capelli (per chi ancora li ha!!).
Cantare le opere secondo il dettato degli autori non può in alcun modo essere considerato “datato”.
Per quanto riguarda la “Carmen”, ovviamente è sempre meglio l'originale in francese, ma gli adattamenti in italiano sono interessanti per chi (italiano), desidera capire meglio l'opera stessa.
La Carmen, inoltre, si è sempre prestata a tagli e/o esecuzioni integrali, particolare fu la versione del Bolshoi nel 1959.
Una curiosità: Mario Del Monaco che la cantava in entrambe le lingue, in base al luogo e alle richieste del teatro di turno, quando si trovò a Mosca nella celebre versione del Bolshoi, il direttore Alexander Melik-Pashaev, che si trovò di fronte il cast che cantava in russo e solo Del Monaco in Italiano, desiderava aprire una pagina che il tenore conosceva solo nella versione integrale francese, così ecco spiegato il motivo per cui all'improvviso il nostro passa dall'italiano al francese, per venire incontro al desiderio del direttore, per anni mi ero chiesto il perché di questa “anomalia”, poi qualcuno finalmente mi ha spiegato l'arcano.
Mi viene in mente una sua bella esecuzione qualche anno fa in Lucrezia Borgia (2002), con la Devia, dove era a suo agio e la voce diventava anche molto bella con mezze voci e ottime sfumature.
Stavo rileggendo queste pagine e nuovamente mi sono meravigliato per il termine usato da Luca e da altri: “datato”, forse dimenticate che la maggioranza delle Opere sono TUTTE datate, l'Opera nasce nel lontano 1573 con Giulio Caccini e Jacopo Peri, anche se la prima vera Opera risale al 1607, cioè l'Orfeo di Claudio Monteverdi.
Nell'Opera, ripeto, tutto è datato, oggi, spesso, le rappresentazioni, quando si cerca di farle in modo più moderno con nuovi allestimenti che stravolgono completamente il dettato degli autori, fanno rizzare i capelli (per chi ancora li ha!!).
Cantare le opere secondo il dettato degli autori non può in alcun modo essere considerato “datato”.
Per quanto riguarda la “Carmen”, ovviamente è sempre meglio l'originale in francese, ma gli adattamenti in italiano sono interessanti per chi (italiano), desidera capire meglio l'opera stessa.
La Carmen, inoltre, si è sempre prestata a tagli e/o esecuzioni integrali, particolare fu la versione del Bolshoi nel 1959.
Una curiosità: Mario Del Monaco che la cantava in entrambe le lingue, in base al luogo e alle richieste del teatro di turno, quando si trovò a Mosca nella celebre versione del Bolshoi, il direttore Alexander Melik-Pashaev, che si trovò di fronte il cast che cantava in russo e solo Del Monaco in Italiano, desiderava aprire una pagina che il tenore conosceva solo nella versione integrale francese, così ecco spiegato il motivo per cui all'improvviso il nostro passa dall'italiano al francese, per venire incontro al desiderio del direttore, per anni mi ero chiesto il perché di questa “anomalia”, poi qualcuno finalmente mi ha spiegato l'arcano.
Roberto
-

Manrico - Messaggi: 101
- Iscritto il: mar 10 apr 2007, 18:44
- Località: Roma
Re: nuovi articoli in home
Posso dirlo?
L'ultimo editoriale non m'e' piaciuto punto.
Ceronetti ha scritto un articolo pessimo, a mio parere, ma la vostra risposta sfiora l'insulto personale.
Un saluto
L'ultimo editoriale non m'e' piaciuto punto.
Ceronetti ha scritto un articolo pessimo, a mio parere, ma la vostra risposta sfiora l'insulto personale.
Un saluto
-

Alberich - Messaggi: 693
- Iscritto il: gio 12 apr 2007, 19:09
Re: nuovi articoli in home
Alberich ha scritto:Posso dirlo?
L'ultimo editoriale non m'e' piaciuto punto.
Ceronetti ha scritto un articolo pessimo, a mio parere, ma la vostra risposta sfiora l'insulto personale.
Un saluto
Ci mancherebbe Alberich! È assolutamente tuo diritto contestare ciò che viene scritto. Non siamo in Bulgaria: chi scrive, sa che si espone alle critiche altrui. È normale e giusto. Io per esempio mi sento offeso da articoli come quello di Ceronetti che pretende tautologicamente di dare a tutti la sua chiave di lettura, ma è questione di punti di vista. Grazie comunque come sempre!
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Articolo Ceronetti
Premesso che ovviamente condivido il contenuto dell'articolo di Pietro e Matteo (un po' meno la foto scelta in stile Tg4  ), devo dire che il tono con cui si esprime Ceronetti mi pare, alla lettura integrale dell'articolo, un po' diverso da come viene presentato nella risposta del nostro sito.
), devo dire che il tono con cui si esprime Ceronetti mi pare, alla lettura integrale dell'articolo, un po' diverso da come viene presentato nella risposta del nostro sito.
Chi legge di tanto in tanto Ceronetti ne conosce la penna tutt'altro che impositiva in termini di chiavi di lettura e tutt'altro che demagogica, anzi spesso scomoda e controcorrente. (Non per caso rimane sempre confinato in una colonna che temo leggano in quattro gatti vista la complessità di stile e contenuti con cui si esprime.)
Il tono generale dell'articolo in questione mi sembra poi chiaramente provocatorio e funzionale a una tesi che non mi sembra esattamente quella confutata da Pietro e Mat.
Anzi, mi sembra che Ceronetti sia molto lucido nell'evidenziare le attuali condizioni agonizzanti dell'opera in Italia. Ovviamente lo fa non da melomane, e - soprattutto - non da melomane che viaggia e che ha uno sguardo ad ampio raggio sulla situazione internazionale.
Tutto il sarcasmo sulla Scala, sulla muffa che intacca l'attuale sistema italiano, pullulante di case d'opera sottoutilizzate, sperpero indicibile di risorse economiche, mi sembra più che giusto, coraggiosamente controcorrente rispetto alle solite lagne stataliste e assistenzialiste sul Fus che invece leggiamo e sentiamo in ogni dove.
E soprattutto mi sembra, quello di Ceronetti, un discorso utile a smuovere qualche certezza proprio in quella classe "intellettuale" che, malgrado le lagnanze, è stata ed è maledettamente complice del tracollo dell'opera in Italia.
Ceronetti, inoltre, mi pare non abbia quasi nulla di tutto quello che generalmente si vuole etichettare, in tono dispregiativo, come "intellettualismo di sinistra". E non sono nemmeno sicuro che lui stesso si ritenga un uomo "di sinistra".
Il fatto che parli senza avere un minimo di prospettiva allargata, il fatto che manchi la pars construens del discorso mi sembrano semmai i veri limiti del suo articolo.
Ma di verità, seppur con accenti iperbolici e provocatori, secondo me ne dice parecchie. Compreso l'interrogativo finale.
Mi sembra giusto riportare qui l'articolo di Ceronetti così che ci si possa fare un'idea esauriente del dibattito.
La Stampa, 15.12.2010
GUIDO CERONETTI
Questa forma di teatro, il melodramma, l’Opera lirica, ha concluso il suo arco a metà del secolo scorso; è destinata a perdersi, è ormai un puro evento d’obbligo, ma di scarso significato. La musica invece è eterna, il teatro è eterno (di eternità per noi misurabili, che non valgono in aeternum). Ma anche nella musica per carnefici di lager c’è un soffio di eternità che vince il male; anche negli allestimenti di disperazione del Gulag c’è il soffio di eternità del teatro. Questo solo conta.
Il cartellone della Scala è, sia pure bellissimo, già un animale impagliato. Anche gli altri cartelloni... Che bisogno c’è di una stagione d’Opera al Regio di Torino? Di quelle voraci cavallette musicali dell’Arena di Verona? Non chiamiamo «cultura» un evento turistico estivo, costosamente mondano, con pizza finale di mezzanotte! La Fenice ha voluto morire, gioiello dell’epoca rivoluzionaria; ma era dal suo nome destinata a risorgere: potrà vivere di concerti. Si potrebbe lasciar vivere il Regio di Parma, dare una mano al festival rossiniano di Pesaro: Verdi e Rossini bastano, sono glorie, ricordi, e un Figaro qua e uno là fanno circensi di allegria.
Ma se con un bilancio divoratore della Scala la saggezza dello Stato (mai ci fosse) potesse restaurare degnamente Pompei, non esiterei un momento a dar tutto agli scavi e a proteggerli dall’incuria e dalla sporcizia. Un altro teatro d’Opera restaurato, anzi rifatto con genialità ammirevole è il Carlo Felice di Genova, ma con spesa molto minore può ospitare qualsiasi altro degno spettacolo.
L’Opera, come il cinema, vixit. Il suo illanguidimento progressivo è inevitabile.
Uno sprecasoldi di genio fu il più grande dei registi che lavorarono alla Scala. Non è nei miei ricordi, ero troppo giovane, ma credo alle testimonianze: una data memorabile fu quando Visconti, il 28 maggio 1955, creò con Maria Callas e Carlo Maria Giulini la sua versione della Traviata. Ce l’ho tuttora, per intero, nel vinile. La Callas fu la Voce dell’Opera della sua epoca, purtroppo obbligata allo stupro dell’imbecillità dei libretti, di cui non se ne salva uno solo. Per poter tollerare Traviata (che fin dal titolo contiene un’idiozia moralistica) bisogna non sapere nulla della trama, essere giapponesi o kazaki digiuni completamente di locuzioni italiane. Quello sciagurato Francesco Maria Piave! La stupidità concentrata nelle parole dell’Andante del vecchio Germont con l’esultante finale di Dio che esaudisce il suo voto di criminale ruffiano: è vero che la musica riscatta tutto, ma genialità e soldi per simili nefandezze fumettistiche sono ali imbrattate di petrolio.
Vixit, l’Opera, trionfalmente, nel secolo XIX; con Puccini e Boito, o Pizzetti, rantola; con Menotti è uno zombi. Bayreuth non avrebbe dovuto sopravvivere a Goebbels.
Nel XVIII l’Opera è puro svago, il suo passo è leggero. Ma l’Ottocento è sotto un segno progressivamente cupo, la moda è costrittiva e triste, il mistero musicale soccombe al tempo ed è inutile nascondercelo, il trionfo operistico è sempre più il dispiegarsi funesto del piacere per mezzo della sofferenza, richiama stuoli di sadomasochisti, le ideologie, l’antisemitismo, il marxismo, il wagnerismo, il freudismo, sono caserme in marcia. Nella Tetralogia non è tanto il Quattro a prevalere, ma la tetra-ggine che la ravvolge nel termine italiano. Quale cultura, se non necrofila, può rappresentare la ripresa, a costi vertiginosi, di una massiccia sequela di colpi in testa come La Valchiria? I capi nazisti, uno più sadomasochista dell’altro, celebravano con l’Opera wagneriana un culto di Kalì travestito da pellegrini cristiani e un Venerdì Santo delle regioni infere. Quell’immenso Incantesimo del Parsifal uccide letteralmente le nostre limitate capacità di liberare, di riscattare l’anima dalle sommersioni nella materia.
Il pubblico che va alla Scala la sera del 7 dicembre ad immobilizzarsi durante quattro o cinque ore, è impossibile immaginarlo spinto da motivi di elevazione spirituale (uso il vecchio termine del pensiero assassinato, col quale sguazzo meglio che se dico culturale). I motivi sono di vanità pura, esibizione di scollature e pettinature, significare presenza. E per questo i violini si agitano, le grandi bacchette sollevano ondate... Ma sulle facce la noia stampa, in un crescendo di afflizioni, le sue impronte d’irresistibile sbadiglio.
Tutto falso, tutto vento che ha fame.
Immancabili, sempre, le dimostrazioni politiche di chi viene apposta per lavorare all’esterno con le urla e i cartelli... Stavolta la materia infiammabile era desunta da disagi di congiuntura... o di università... ci sono poche varianti... ma la novità è stata l’assunzione da parte di un grande Direttore come Barenboim, prima dello spettacolo, della retorica piagnistea dei tagli alle sovvenzioni di Stato. Non mi pare sia stato di buon gusto recitare l’articolo Nove in presenza di Napolitano che la Carta la sa a memoria, più disposto dal suo palco ad applaudire la noia sgorgante dalla scena che a subire l’incongruità di un articolo che l’Italia aggira, frega, irride dal 1947.
Non è certo stato un gesto di cortesia, da parte del Maestro! E temo l’abbia fatto per fingere solidarietà con la piazza e di beccarsi così un’ovazione del tutto separata dai propri meriti di grande artista. Il pubblico pinguino e delle schiene nude sarebbe stato lui degno di applauso, se fosse rimasto in composto glaciale silenzio. Indigesta sempre è la verità.
È amaro pensarlo ma: se la Scala chiude, che male c’è?
Chi legge di tanto in tanto Ceronetti ne conosce la penna tutt'altro che impositiva in termini di chiavi di lettura e tutt'altro che demagogica, anzi spesso scomoda e controcorrente. (Non per caso rimane sempre confinato in una colonna che temo leggano in quattro gatti vista la complessità di stile e contenuti con cui si esprime.)
Il tono generale dell'articolo in questione mi sembra poi chiaramente provocatorio e funzionale a una tesi che non mi sembra esattamente quella confutata da Pietro e Mat.
Anzi, mi sembra che Ceronetti sia molto lucido nell'evidenziare le attuali condizioni agonizzanti dell'opera in Italia. Ovviamente lo fa non da melomane, e - soprattutto - non da melomane che viaggia e che ha uno sguardo ad ampio raggio sulla situazione internazionale.
Tutto il sarcasmo sulla Scala, sulla muffa che intacca l'attuale sistema italiano, pullulante di case d'opera sottoutilizzate, sperpero indicibile di risorse economiche, mi sembra più che giusto, coraggiosamente controcorrente rispetto alle solite lagne stataliste e assistenzialiste sul Fus che invece leggiamo e sentiamo in ogni dove.
E soprattutto mi sembra, quello di Ceronetti, un discorso utile a smuovere qualche certezza proprio in quella classe "intellettuale" che, malgrado le lagnanze, è stata ed è maledettamente complice del tracollo dell'opera in Italia.
Ceronetti, inoltre, mi pare non abbia quasi nulla di tutto quello che generalmente si vuole etichettare, in tono dispregiativo, come "intellettualismo di sinistra". E non sono nemmeno sicuro che lui stesso si ritenga un uomo "di sinistra".
Il fatto che parli senza avere un minimo di prospettiva allargata, il fatto che manchi la pars construens del discorso mi sembrano semmai i veri limiti del suo articolo.
Ma di verità, seppur con accenti iperbolici e provocatori, secondo me ne dice parecchie. Compreso l'interrogativo finale.
Mi sembra giusto riportare qui l'articolo di Ceronetti così che ci si possa fare un'idea esauriente del dibattito.
La Stampa, 15.12.2010
GUIDO CERONETTI
Questa forma di teatro, il melodramma, l’Opera lirica, ha concluso il suo arco a metà del secolo scorso; è destinata a perdersi, è ormai un puro evento d’obbligo, ma di scarso significato. La musica invece è eterna, il teatro è eterno (di eternità per noi misurabili, che non valgono in aeternum). Ma anche nella musica per carnefici di lager c’è un soffio di eternità che vince il male; anche negli allestimenti di disperazione del Gulag c’è il soffio di eternità del teatro. Questo solo conta.
Il cartellone della Scala è, sia pure bellissimo, già un animale impagliato. Anche gli altri cartelloni... Che bisogno c’è di una stagione d’Opera al Regio di Torino? Di quelle voraci cavallette musicali dell’Arena di Verona? Non chiamiamo «cultura» un evento turistico estivo, costosamente mondano, con pizza finale di mezzanotte! La Fenice ha voluto morire, gioiello dell’epoca rivoluzionaria; ma era dal suo nome destinata a risorgere: potrà vivere di concerti. Si potrebbe lasciar vivere il Regio di Parma, dare una mano al festival rossiniano di Pesaro: Verdi e Rossini bastano, sono glorie, ricordi, e un Figaro qua e uno là fanno circensi di allegria.
Ma se con un bilancio divoratore della Scala la saggezza dello Stato (mai ci fosse) potesse restaurare degnamente Pompei, non esiterei un momento a dar tutto agli scavi e a proteggerli dall’incuria e dalla sporcizia. Un altro teatro d’Opera restaurato, anzi rifatto con genialità ammirevole è il Carlo Felice di Genova, ma con spesa molto minore può ospitare qualsiasi altro degno spettacolo.
L’Opera, come il cinema, vixit. Il suo illanguidimento progressivo è inevitabile.
Uno sprecasoldi di genio fu il più grande dei registi che lavorarono alla Scala. Non è nei miei ricordi, ero troppo giovane, ma credo alle testimonianze: una data memorabile fu quando Visconti, il 28 maggio 1955, creò con Maria Callas e Carlo Maria Giulini la sua versione della Traviata. Ce l’ho tuttora, per intero, nel vinile. La Callas fu la Voce dell’Opera della sua epoca, purtroppo obbligata allo stupro dell’imbecillità dei libretti, di cui non se ne salva uno solo. Per poter tollerare Traviata (che fin dal titolo contiene un’idiozia moralistica) bisogna non sapere nulla della trama, essere giapponesi o kazaki digiuni completamente di locuzioni italiane. Quello sciagurato Francesco Maria Piave! La stupidità concentrata nelle parole dell’Andante del vecchio Germont con l’esultante finale di Dio che esaudisce il suo voto di criminale ruffiano: è vero che la musica riscatta tutto, ma genialità e soldi per simili nefandezze fumettistiche sono ali imbrattate di petrolio.
Vixit, l’Opera, trionfalmente, nel secolo XIX; con Puccini e Boito, o Pizzetti, rantola; con Menotti è uno zombi. Bayreuth non avrebbe dovuto sopravvivere a Goebbels.
Nel XVIII l’Opera è puro svago, il suo passo è leggero. Ma l’Ottocento è sotto un segno progressivamente cupo, la moda è costrittiva e triste, il mistero musicale soccombe al tempo ed è inutile nascondercelo, il trionfo operistico è sempre più il dispiegarsi funesto del piacere per mezzo della sofferenza, richiama stuoli di sadomasochisti, le ideologie, l’antisemitismo, il marxismo, il wagnerismo, il freudismo, sono caserme in marcia. Nella Tetralogia non è tanto il Quattro a prevalere, ma la tetra-ggine che la ravvolge nel termine italiano. Quale cultura, se non necrofila, può rappresentare la ripresa, a costi vertiginosi, di una massiccia sequela di colpi in testa come La Valchiria? I capi nazisti, uno più sadomasochista dell’altro, celebravano con l’Opera wagneriana un culto di Kalì travestito da pellegrini cristiani e un Venerdì Santo delle regioni infere. Quell’immenso Incantesimo del Parsifal uccide letteralmente le nostre limitate capacità di liberare, di riscattare l’anima dalle sommersioni nella materia.
Il pubblico che va alla Scala la sera del 7 dicembre ad immobilizzarsi durante quattro o cinque ore, è impossibile immaginarlo spinto da motivi di elevazione spirituale (uso il vecchio termine del pensiero assassinato, col quale sguazzo meglio che se dico culturale). I motivi sono di vanità pura, esibizione di scollature e pettinature, significare presenza. E per questo i violini si agitano, le grandi bacchette sollevano ondate... Ma sulle facce la noia stampa, in un crescendo di afflizioni, le sue impronte d’irresistibile sbadiglio.
Tutto falso, tutto vento che ha fame.
Immancabili, sempre, le dimostrazioni politiche di chi viene apposta per lavorare all’esterno con le urla e i cartelli... Stavolta la materia infiammabile era desunta da disagi di congiuntura... o di università... ci sono poche varianti... ma la novità è stata l’assunzione da parte di un grande Direttore come Barenboim, prima dello spettacolo, della retorica piagnistea dei tagli alle sovvenzioni di Stato. Non mi pare sia stato di buon gusto recitare l’articolo Nove in presenza di Napolitano che la Carta la sa a memoria, più disposto dal suo palco ad applaudire la noia sgorgante dalla scena che a subire l’incongruità di un articolo che l’Italia aggira, frega, irride dal 1947.
Non è certo stato un gesto di cortesia, da parte del Maestro! E temo l’abbia fatto per fingere solidarietà con la piazza e di beccarsi così un’ovazione del tutto separata dai propri meriti di grande artista. Il pubblico pinguino e delle schiene nude sarebbe stato lui degno di applauso, se fosse rimasto in composto glaciale silenzio. Indigesta sempre è la verità.
È amaro pensarlo ma: se la Scala chiude, che male c’è?
Ich habe eine italienische Technik von meiner Mutter bekommen.
Astrid Varnay
Astrid Varnay
-

Riccardo - Messaggi: 608
- Iscritto il: mer 23 mag 2007, 19:39
Torna a Il salotto di operadisc
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti