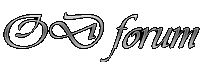da MatMarazzi » gio 16 apr 2009, 11:14
da MatMarazzi » gio 16 apr 2009, 11:14
In attesa che Pietro scriva la sua recensione, dico anche io la mia opinione.
Premetto che secondo me le recite di una stessa produzione possono essere molto diverse: un piccolo scazzo tra interpreti dietro le quinte, un mal di testa della primadonna che si estende con code di nervosismo a tutti i colleghi, mille infinitesime ragioni fanno sì che una recita possa essere modesta e quella dopo esplosiva di idee, colori, fantasia, gioia di fare musica e teatro.
Evidentemente è questo che è successo tra la mia recita e quella di Maugham, di cui conosco la sconfinata sensibilità ed esperienza d’ascolto e con cui mi trovo talora in disaccordo sul significato delle cose, mai sul valore.
La mia recita è stata fenomenale: la più incredibile Tosca che abbia mai visto, la più emozionante, trascinante, appassionante (e con la Magee impavida che scaglia una lama un po’ faticosamente estratta ma non di meno audace e scintillante).
In linea di massima molte delle osservazioni di Maugham sono state vere per la mia recita e certe prese di posizione anche condivisibili, ma se il risultato finale è così diverso, se l’emozione che se ne riporta così straordinaria, vuol dire che nell’aria qualcosa di diverso c’era.
Su Kaufmann tutto quello che ha detto Maugham si è ripetuto pari pari nella mia recita.
Un Cavaradossi unico, da primato storico, per la sublime qualità del canto, l’uso diabolico delle mezze voci, la sensualità fragile, abbandonata, adolescente della sua recitazione, l’acuto svettante e facilissimo, il fascino vellutato del timbro, il rigore ritmico, il senso di ogni parola.
Eppure (stenterete a crederci) le uniche perplessità raccolte dai numerosi Wanderer presenti (più di trenta) riguardavano lui.
Per carità, intendiamoci. Tutti hanno riconosciuto l’eccezionalità di un Cavaradossi di questo livello, ma l’impatto della regia di Carsen e soprattutto dello Scarpia folgorante di Hampson hanno fatto passare come in secondo piano lo sconvolgente Cavaradossi del tenore tedesco.
Un po’ come – mutatis mutandis – avveniva alla Fille du Regiment viennese/londinese: Florez è in testa a tutte le classifiche dei Tonio passati e presenti, è il Tonio “storico”, eppure in quell’allestimento si ricorderà la Dessay e la regia di Pelly. Lui finiva per sembrare solo un componente (e nemmeno il principale) di grandissimo lusso.
Questo è l’effetto che a molti soci ha fatto Kaufmann, la cui funzione ha finito per essere una questione di “pulizia”, più che di reinvenzione del personaggio.
Puliamo Cavaradossi dalle gigionate, dalle gaglioffate, dalle stupidaggini della tradizione; rimettiamo a posto le note, il loro valore, il loro senso; evitiamo le smargiassate dei Cavaradossi scimmioni che in “E lucean le stelle” si strappano i peli del petto e li tirano sulle signore in platea!
Ok, giusto! Noi vecchi habitués dell’opera, che di questi Cavaradossi ne conosciamo a migliaia abbiamo provato una sorta di sollievo balsamico al canto intelligente e sfumato di Kaufmann, ma il pubblico “moderno”, quello che va a teatro oggi per le regie di Carsen e che ascolta Puccini molto meno di Handel e Wagner, e che dei Di Stefano e dei Del Monaco conosce appena il nome ha potuto vedere in lui solo un personaggio abbastanza prevedibile nella sua dolcezza malinconica e un po’ infantile, leggermente univoca.
Per percepire la rivoluzione di Kaufmann come Cavaradossi occorre essere conoscitori della tradizione operistica: il personaggio, pur bellissimo e seducente, non bastava.
Anche perché il suo medium dal velluto superbo, ma in genere non ricchissimo di metallo, faticava a relazionarsi con un’orchestra spesso esageratamente turgida.
Insomma sì, grandissimo, il migliore che abbia sentito, di portata storica, però non mi stupisce che la palma d’onore se la sia presa Thomas Hamspon, che non è affatto perfetto, ma che ha imposto un personaggio di dimensioni e grandezza semplicemente allucinante, che ha stregato il pubblico dalla sua prima apparizione e che ha disegnato lo Scarpia più originale e aggettante che abbia mai visto a teatro.
Come dicevo, sono ultracerto che nella recita vista da Maugham Hampson non fosse in forma, o avesse le scatole girate per qualche ragione: nella mia nessuna papera (qualche “i” al posto di una “e” a cui ben altri – Terfel in testa – mi hanno abituato). In compenso una declamazione aspra e serrata, spesso sopra le righe, in chiave Fischer-Dieskau, con ricorso all’urlo, questo sì, ma da grande attore (“aprite le porte che n’oda i lamenti”). Avendo visto Hampson dal vivo varie volte, ho dovuto riconoscere che il suo canto comincia a indurirsi: mi aspettavo una gran messe di pianissimi e sussurri “parlanti” (di cui ancora era generoso nel 2006 in Don Giovanni) e invece mi sono ritrovato una dinamica piuttosto appiattita sul forte: il primo vero pianissimo è stato su “ebben”.
Anche lui però, bisogna ammettere, doveva far fronte a un’orchestra che lasciava poco spazio a sussurri e delicatezze. In questo senso posso capire la sorpresa di chi si aspettava uno Scarpia tutto malia e classe vocale: il lavorio sulla nota (dei Warren/Mitropulos, dei Taddei/Karajan, dei Fischer Dieskau/Maazel, dei Ramey/Sinopoli) non albergava in questo barone dal canto magniloquente e sferzante, e tuttavia il personaggio che ne è uscito, il suo impatto fragoroso, non mi fa rimpiangere in nulla i grandi artisti sunnominati.
Anche perché, vorrei chiarire, la sua declamazione, così come la sua recitazione non era in nulla paragonabile a quella dei Gobbi, dei Carroli o dei Raimondi.
E’ vero: Hugh Grant invecchiato. L’immagine di Maugham rende a meraviglia.
Il gesto aulico e sofisticato, la naturalezza del “divo”, l’infinitesimo gioco di sguardi, di sorrisi, di compiacimento da dandy d’altissima classe, un carisma abbacinante che illuminava ogni singolo gesto di rifrazioni originalissime, conferivano al suo barone un fascino a dir poco unico.
Non cattiveria, non brama di potere, non sensualità animalesca, ma difesa di uno “status” dalla rivoluzione di Tosca, con cui lotta (più che sedurla o violentarla) per la difesa di un ruolo.
E qui entriamo nella singolarità della regia di Carsen.
Ha ragionassimo Marco quando dice che altre regie di Carsen erano tecnicamente più impressionanti. In questa c’era scarso virtuosismo, ma una riflessione sul rapporto “arte”-“finzione” che rappresenta la fase più creativa del percorso di Carsen.
Ho fatto il conto: questa Tosca è stata la mia ventottesima regia dal vivo di Robert Carsen (senza contare gli spettacoli che ho visto in ripresa), dal 1991 a oggi.
E posso inserirla in una specie di filone che comprende i Racconti di Hoffman alla Bastille e il Capriccio al Palais Garnier: ossia il filone degli spettacoli in cui Carsen riflette sul corto circuito fra verità della finzione teatrale e illusorietà della vita reale.
Le tre scene rappresentavano parti dell’edificio teatrale.
Le prime due esterne alle “teatralità” stessa
Il primo atto si svolge in una platea con le poltroncine rivolte a un sipario interno, rosso (tipico di Carsen l’effetto strepitoso della fine dell’atto, con il sipario “finto” che si alza – inizia la “loro” rappresentazione - mentre si abbassa quello “vero”, il nostro).
Il secondo atto si svolge dietro le quinte, in una qualsiasi sala prove, con ufficio del dirigente “Scarpia”. Per entrambi gli atti sono onnipresenti i programmi di sala, con sopra scritto – in grande evidenza – “TOSCA”.
Solo il terzo atto si spalanca grandioso non su spazi “interni” del teatro, ma sul vero “palcoscenico”, come uno specchio: il palco è il palco, ma davanti a noi si apre l’orrenda oscurità del boccascena visto dalla parte degli attori.
In quel buio orrendo, indecifrabile c’è la “realtà vera”, ci siamo “noi”, il pubblico.
Maugham afferma che al centro della regia c’è il “divismo” di Tosca. Io non la vedo così.
Al centro c’è il disperato tentativo del “personaggio” di fuggire pirandellianamente dai confini del fittizio, di abbandonare tutto e di diventare qualcos’altro, non più diva prigioniera del teatro, ma donna, nella realtà.
Scarpia non è più l’aguzzino, il satiro, il poliziotto: Scarpia è il direttore del teatro.
E’ per questo che appare dall’alto, fra due colonne, come un Deus ex machina al primo atto.
Colui che impone la sua volontà ai personaggi: colui che “cambia” il quadro della Maddalena (da bionda come l’aveva voluta Cavaradossi a mora); colui che farà a pezzi lo stesso dipinto (“io ti ho fatto, io ti distruggo”), colui che “tortura” il personaggio, gli impone le sue logiche, vuole tenerlo avvinto; è per questo che il suo ufficio è nei camerini di un teatro. E’ per questo che fuma una sigaretta mentre sulla parete del teatro è scritto a caratteri cubitali “VIETATO FUMARE” (in italiano).
Il regime che esercita non è più quello dello stato poliziesco, ma dell’uomo che impone ai personaggi di restare tali, di restare solo personaggi, al servizio del teatro.
Tosca si ribella, si afferma e alla fine lo sopraffà: anche se lui, morendo sotto di lei, come un amante, continua a baciarla, ad accarezzarle il volto: Tosca è la sua creatura.
Nell’ultimo atto Cavaradossi è solo, meravigliosamente solo, fino alla sua grande aria: non ci sono pastorelli, panorami o altro; solo lui l’attore, anzi il personaggio, che fissa rapito il vuoto nero e sublime della platea. Lui, a differenza di Tosca, sa che il suo mondo è quello, che non potrà mai fuggire: il suo esistere è legato al teatro, fuori dal teatro non c’è posto per Cavaradossi, per i suoi impeti rivoluzionari, per i suoi struggenti ricordi di baci e carezze.
Kaufmann si sdrai su quel palcoscenico vuoto che è la sua casa, il suo mondo.
E quando Tosca gli parla di “fughe per il mare” lui piange, perché sa che dal teatro il personaggio non può fuggire.
Quando Tosca al finale capisce che il suo sogno di fuga è impossibile, che il suo essere Diva o personaggio è confinato allo spazio teatrale, allora si suiciderà… ma sarà libera.
Aureolata da un occhio di bue, si avvicina all’orrendo, nero boccascena e si butta al di là del proscenio, nel buio del pubblico, nel nulla della “realtà”, quella realtà in cui né lei, né Cavaradossi, né alcun personaggio ha veramente diritto d’asilo.
“Mai Tosca alla scena più tragica fu”.
Un salutone,
Mat