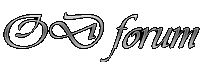CRONACHE DA AIX (2011)
Ogni teatro ha il suo pubblico e ogni pubblico ha le sue scorie.
Alla Scaka, per esempio, tutti applaudono convinti una regia e un'esecuzione davvero forti e moderne se si tratta della Morte a Venezia o della Lady Macbeth di Mszensk.
Perché in questi casi l'italiano medio non si sente difensore d'alcunché: nessun imperativo morale gli impone di "proteggere" (scusate se rido) Britten o Sostakovic.
E così, in questi casi, il pubblico fa quello che dovrebbe fare sempre: forte (lo dico senza alcuna ironia) della propria ignoranza di Britten e Sostakovic, si limita ad andare a teatro, lasciarsi prendere per mano e divertirsi di fronte al "bello" che viene loro mostrato.
Ma con Verdi e Donizetti no!
Lì un brutto demonio, travestito di sedicente "conoscenza" del repertorio e delle tradizioni, lì l'arrogante convinzione di essere venuti a teatro, aver speso dei soldi non per divertirsi, non per ascoltare un'espressione di musica e teatro, ma per proteggere le proprie tranquillizzanti certezze di vecchi minacciati dall'avanzare dei giovani... spinge il nostro pubblico a tapparsi occhie e orecchie e a porsi di traverso (almeno sperare di farlo) a ogni deviazione, ogni "mancanza di rispetto"...
A Aix-en-Provence (benché il suo pubblico sia fra i più illuminati, internazionali e colti) la situazione è la stessa.
E' un pubblico felice di ogni novità, di ogni scoperta, di ogni sperimentazione... è un pubblico che divora 4 secoli di musica senza farsi mai intimidire, è un pubblico abituato sempre al meglio e sempre all'avanguardia!
Eppure... quando si tratta di Mozart (l'autore "classico" di Aix fin dai tempi di Dussurget) allora diventa esattamente come il sapientone loggionista nostrano, che fischia "a prescindere", che si scandalizza.
Ne ha fatto le spese, lo scorso anno, il direttore del festival, il bravissimo Bernard Foccroulle che ha visto i "vecchi credenti mozartiani" insorgere di fronte a un Don Giovanni semplicemente geniale, con una regia-capalavoro firmata da Cerniakov e un'esecuzione musicale dal taglio filologico e arricchita da alcune delle maggiori personalità vocali del nostro tempo (Schovus, la Petersen, la Opalais, Kelelsen).
L'esperienza insegna, e così quest'anno... su Mozart il festival ha operato un programmatico e radicale dietro-front.
Un Clemenza di Tito all'insegna del vecchio (musicalmente) e del rassicurante (teatralmente).
"Vi dò quello che volete" pareva dirci il Festival. "Vi do il Mozart già visto e già sentito; cerchiamo almeno di farlo bene".
Già... perché anche fare "il vecchio" (questo vale per Mozart a Aix o per Verdi da noi) non è detto che significhi "fare il brutto".
Almeno in teoria non dovrebbe essere così...
Si può fare una bella seduta spiritica col passato (come piace ai "vecchi credenti" e sdentati loggionisti) e la si può fare bene.
Sulla carta infatti questa Clemenza era obbiettivamnete attraente: tutti i principi su cui era progettata erano vecchi eppure di luminoso livello.
A partire dal direttore: un mito come Colin Davis (ottantacinque anni) con la sua orchestra, la London Symphony, entrambi fermi a un Mozart come lo si faceva nei primi anni 70 (e già allora accusato di essere la variante inglese del già vecchio Mozart viennese).
E non di meno si tratta di un mitico direttore e una mitica orchestra, a cui si deve rispetto.
Al suo fianco un regista giovane a all'avanguardia, ok, come Mc Vicar, ma anche uno che non ha paura di sfidare l'intellettualismo europeo, non attratto da riletture sconvolgenti, che preferisce dedicarsi alla poesia e alla forza diretta, semplice del gesto e dell'umanità dei personaggi (e che quindi piace ai tradizionalisti, tanto da essere accusato di zeffirellismo a Salisburgo - accusa assai inguista per altro - e risultare amatissimo persino al Met).
Infine un cast tranquillizzante, tutto improntato al "già visto", senza alcuna sorpresa.
Un rossiniano d'america (Kunde) in Tito, un'inglese figlia della Baker (la Connoly) in Sesto, un soprano lirico tipicamente all'italiana che più generico non si può (come oggi va di moda: basta pensare a quanto scorrazzano per il mondo in Elettra e Vitellia le varie Mei, Frittoli,Remigio, Cedolins) come la Giannattasio in Vitellia.
Dato che io appartengo a quei fortunati ascoltatori che a teatro non cercano nè il "nuovo", nè il "vecchio", ma semplicemente il bello, ero convinto che - con simili nomi - mi sarei comunque goduto un bello spettacolo.
In tutta onestà, così non è stato.
Anzi, dopo aver fatto le pulci a un Naso ben altrimenti spettacolare e brillante, sono costretto ad ammettere che questa Clemenza è stata un vero flop.
Anzitutto, pollice verso su Mc Vicar.
Regia pessima, slentata, priva di idee, caratterizzata da gestualità totalmente pizziana (unica eccezione il drammatico confronto tra Sesto e Tito, sola vera perla della serata, dove era possibile riconoscere finalmente la scioltezza e modernità della gestualità mcvicariana).
Un'ambientazione (napoleonica) che faceva ridere i polli, anche perché - una volta vestiti i personaggi da primo ottocento e infagottato Kunde di bianco, tanto da renderlo ancora più ridicolo in scena - nulla è stato fatto.
Un incendio del Campidoglio che, lo dico sul serio, il nostro buon vecchio pizzi avrebbe realizzato mille volte meglio: due finestre illuminate di rosso e fumo finto che aleggiava in scena. Una fissità gestuale e illuministica da produrre vera sonnolenza.
Un finale (con le guardie che si avventano su Vitellia) banalissimo e depressivo.
Che diavolo è successo al genio di Mc Vicar? Per come la vedo io è semplice: distrutto dall'incredibile lavoro svolto sui Meistersinger a Glyndebourne, ha tenuto le forze per l'Anna Bolena al Met. E che questa povera Clemenza per vecchi vada a farsi benedire....
Mi spiace soprattutto per lui: un grosso neo nella sua folgorante carriera.
Davis non merita altrettanti rimproveri: lui ha fatto quello che ci si aspettava.
Ha fatto un Mozart esattamente identico a quelli che incideva quaranta anni fa.
Morbido, vellutato, accurato, ma senza alcuna disposizione tragica, senza alcuno strappo narrativo, senza alcuna intensità poetica, talmente omogeneo e raccolto da favorire sonni profondi.
Lo conoscevo bene, non mi aspettavo niente di diverso: anzi era proprio questa nobile vetustà che in teoria mi attirava (e la perfezione degli accompagnamenti, l'equilibrio straordinario con gli strumenti obbligati). Purtroppo però la Clemenza è opera particolarmente bisognosa di esuberanza.
Il buon Boehm era un ciclone paragonato a questo stanco e demotivato baronetto.
Infine il cast.
Per non sconvolgere nessuno, oggi sono due le strade per Tito: quella degli inglesi coloristi (sulla linea dei Langridge e Rolfe-Johnson: e infatti inizialmente era stato scritturato Ainsley) o quella dei Rossiniani d'America (sulla linea dell'inarrivabile Ford).
Alla fine è stata scelta questa seconda: Kunde, che vocalmente - come avevo scritto nell'articolo a lui dedicato - è totalmente a suo agio come tessitura e tecnica; il suo colorismo gli permette di lavorare benissimo sui recitativi (fin dove almeno lo spinge il suo non profondissimo istinto espressivo) e di dare un bello sbalzo alle arie.
Ogni tanto qualche segno di senilità lo si avverte, ma ben poca roba di fronte a un canto che comunque - in questo repertorio - è ancora trionfale.
Semmai il limite sta nel canto di agilità, che non è davvero più sicuro come un tempo.
Resta il problema della sua scarsissima credibilità scenica: come attore il Kunde di oggi funziona solo in personaggi estremi e rabbiosi (il baritenore nozzariano). In quelli nobili sembra un orsacchiotto imbronciato e maldestro, tanto da scivolare su un gradino e non saper gestire gli assurdi costumi (non disegnati per lui).
Ed è lui che più di tutti avrebbe avuto bisogno dell'aiuto di Mc Vicar, che - se ispirato - fa recitare anche i sassi.
Infatti, laddove il lavoro c'è stato (mi riferisco al secondo atto), Kunde è riuscito a dare vera emozione al suo personaggio, con soluzioni anche sceniche estremamente sciolte, moderne, commoventi.
Il pubblico gli ha riservato un accoglienza fredda, forse un filino troppo fredda rispetto comunque a ciò che di buono il suo Tito aveva.
Male, senza speranza, la Giannattasio in Vitellia, accolta con freddezza anche maggiore.
Vocalmente, scenicamente, tecnicamente inadeguata è il meno che si possa dire.
Un Vitellia in minatura, che si atteggia a gran diva senza esserlo, priva di carisma scenico (il suo zampettare in scena forzava la tenerezza) tirata sugli acuti, tiratissima sui gravi, evidentemente piazzata in un ruolo completamente sbagliato per lei.
Attenzione: errori come questi si pagano.
La gioia del pubblico si è riversata, come era prevedibile, solo sulla Connoly, trionfatrice indiscussa della serata, la vittoria del "canto inglese" su quello americano e italiano.
Attrice consumatissima, musicista in piena regola, sorprendentemente capace di esprimere la gioventù idealistica e disperata del personaggio, è l'unica che ha saputo trarre dalla noia generale gli stimoli per un'interpretazione di altissima classe e tormentata emotività.
Gli altri membri del cast non meritano menzione, con l'eccezione dell'Annio della bravissima Anna Stephany, un nome da tenere a mente.
IL pubblico ha dormito molto ieri sera (mentre era attentissimo e coinvoltissimo al Don Giovanni).
In compenso ha applaudito (senza isteria) alla fine; mentre al Don Giovanni aveva fischiato e contestato.
In questo senso l'obbiettivo è stato raggiunto.
Salutoni provenzali.
Matteo Marazzi
La Clemenza di Tito (Mozart)
Moderatori: DocFlipperino, DottorMalatesta, Maugham
15 messaggi
• Pagina 1 di 1
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Interessante, davvero interessante. Alcuni spettatori italiani potrebbero fare una gita in Provenza per uno spettacolo così.
L'unico aspetto della tua recensione che mi spiazza un po' è quello che dici su Carmen Giannattasio. Che - lo so bene - non è un fulmine di guerra, non è la DiDonato, ma si mangia la Ganassi (per esempio) e ha tutte le potenzialità per diventare un'ottima protagonista dei ruoli Colbran:
...e non solo:
L'unico aspetto della tua recensione che mi spiazza un po' è quello che dici su Carmen Giannattasio. Che - lo so bene - non è un fulmine di guerra, non è la DiDonato, ma si mangia la Ganassi (per esempio) e ha tutte le potenzialità per diventare un'ottima protagonista dei ruoli Colbran:
...e non solo:
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Caro Pietro,
tu mi conosci abbastanza per sapere che per me non esistono i cantanti buoni e quelli cattivi.
Esistono i cantanti impegnati nei ruoli giusti per loro e quelli impegnati nei ruoli sbagliati.
La Giannattasio è, come tutti, artista dotata di pregi e di difetti.
Vitellia è il ruolo che ci vuole per non valorizzarne i pregi e metterne alla berlina i difetti.
Intanto vocalmente, se si soffre - come la Giannattasio e lo dimostra benissimo anche nei brani di Parisina e Elena che hai postato - di un registro grave afono e sgradevole, tutto si dovrebbe cantare fuorché Vitellia.
Pensa che all'epoca dei settantotto giri, le uniche cantanti che incidevano "NOn più di fiori vaghe catene" - dove si deve fraseggiare agli abissi della voce femminile - erano mezzosoprani e contralti.
Ma anche il settore acuto di Vitellia (in cui apparentemente la Giannattasio è più a suo agio) la mette in gravi difficoltà.
Nel repertorio romantico-italiano l'uso degli acuti ha già una specie di significato emotivo (in Donizetti è già un lampo di rivolta, un grido di disperazione; già in Bellini era così: pensa a "non tremare o perfido" o "né fra voi si trova").
La Giannattasio (come i lirici italiani della sua stirpe) se la cava se deve "sparare" un acuto in questo senso; ma Mozart non è così.
In lui gli acuti (se e quando ci sono) sono una semplice parte del flusso melodico; sono inseriti in linee musicali omogenee; se li spari vai in crisi.
E puntualmente la Giannattasio è andata in crisi in "Vengo, aspettate", che sarebbe uno dei momenti di teatro più grandioso che Mozart abbia scritto, uno di quelli in cui anche i sedani fanno bella figura.
Ieri sera invece avevamo una Vitellia impietrita scenicamente e per di più tiratissima sugli acuti (non parliamo del re, vero e proprio "squeeck" delle migliori occasioni).
Ancora una volta, non è in gioco la bravura o meno della cantante, ma l'inconciliabilità delle sue caratteristiche rispetto al personaggio e alla sua scrittura.
Infine c'è il discorso della personalità: Vitellia è un personaggio che non sta in piedi senza il carisma della protagonista.
Figlia di imperatori, cospiratrice, manipolatrice, seduttrice, non la si può affidare a una cantante che di carisma manca e (peggio) cerca di surrogarlo con affettazioni comique da Joan Collins in Dinasty. La drammaturgia dell'intera opera vacilla...
Anche questo non è un difetto in assoluto: si può essere grandissimi intepreti anche se (come dice Butterfly) si è "avvezzi alle piccole cose".
Il guaio è quando a CioCioSan si impone di fare l'Imperatrice del Giappone.
Salutoni,
Mat
tu mi conosci abbastanza per sapere che per me non esistono i cantanti buoni e quelli cattivi.
Esistono i cantanti impegnati nei ruoli giusti per loro e quelli impegnati nei ruoli sbagliati.
La Giannattasio è, come tutti, artista dotata di pregi e di difetti.
Vitellia è il ruolo che ci vuole per non valorizzarne i pregi e metterne alla berlina i difetti.
Intanto vocalmente, se si soffre - come la Giannattasio e lo dimostra benissimo anche nei brani di Parisina e Elena che hai postato - di un registro grave afono e sgradevole, tutto si dovrebbe cantare fuorché Vitellia.
Pensa che all'epoca dei settantotto giri, le uniche cantanti che incidevano "NOn più di fiori vaghe catene" - dove si deve fraseggiare agli abissi della voce femminile - erano mezzosoprani e contralti.
Ma anche il settore acuto di Vitellia (in cui apparentemente la Giannattasio è più a suo agio) la mette in gravi difficoltà.
Nel repertorio romantico-italiano l'uso degli acuti ha già una specie di significato emotivo (in Donizetti è già un lampo di rivolta, un grido di disperazione; già in Bellini era così: pensa a "non tremare o perfido" o "né fra voi si trova").
La Giannattasio (come i lirici italiani della sua stirpe) se la cava se deve "sparare" un acuto in questo senso; ma Mozart non è così.
In lui gli acuti (se e quando ci sono) sono una semplice parte del flusso melodico; sono inseriti in linee musicali omogenee; se li spari vai in crisi.
E puntualmente la Giannattasio è andata in crisi in "Vengo, aspettate", che sarebbe uno dei momenti di teatro più grandioso che Mozart abbia scritto, uno di quelli in cui anche i sedani fanno bella figura.
Ieri sera invece avevamo una Vitellia impietrita scenicamente e per di più tiratissima sugli acuti (non parliamo del re, vero e proprio "squeeck" delle migliori occasioni).
Ancora una volta, non è in gioco la bravura o meno della cantante, ma l'inconciliabilità delle sue caratteristiche rispetto al personaggio e alla sua scrittura.
Infine c'è il discorso della personalità: Vitellia è un personaggio che non sta in piedi senza il carisma della protagonista.
Figlia di imperatori, cospiratrice, manipolatrice, seduttrice, non la si può affidare a una cantante che di carisma manca e (peggio) cerca di surrogarlo con affettazioni comique da Joan Collins in Dinasty. La drammaturgia dell'intera opera vacilla...
Anche questo non è un difetto in assoluto: si può essere grandissimi intepreti anche se (come dice Butterfly) si è "avvezzi alle piccole cose".
Il guaio è quando a CioCioSan si impone di fare l'Imperatrice del Giappone.
Salutoni,
Mat
-

MatMarazzi - Messaggi: 3182
- Iscritto il: gio 05 apr 2007, 12:34
- Località: Ferrara
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Interessante e anche pungente la tua recensione. Due nomi mi colpiscono su tutti.
McVicar è un mito per me, il suo nome su ogni dvd che sto per acquistare è una garanzia; tra i tanti sono una grande fan del suo Fluto Magico al Covent Garden. Non riesco a credere che si sia banalizzato!
Kunde l'ho ascoltai un paio di anni fa a Napoli proprio in Tito. Premetto che non ho mai amato quest'opera mozartiana; comunque la sua presenza era un netto stacco rispetto agli altri interpreti. Pensai però che il ruolo gli fosse inadatto e che fosse più portato per un genere verdiano (come mi ha confermato nei Vespri) che non nel classico Mozart, riservato alle voci più agili e delicate. Data tuttavia la presenza centrale e imponente del personaggio, il suo Tito deciso e vigoroso non è comunque da buttare
McVicar è un mito per me, il suo nome su ogni dvd che sto per acquistare è una garanzia; tra i tanti sono una grande fan del suo Fluto Magico al Covent Garden. Non riesco a credere che si sia banalizzato!
Kunde l'ho ascoltai un paio di anni fa a Napoli proprio in Tito. Premetto che non ho mai amato quest'opera mozartiana; comunque la sua presenza era un netto stacco rispetto agli altri interpreti. Pensai però che il ruolo gli fosse inadatto e che fosse più portato per un genere verdiano (come mi ha confermato nei Vespri) che non nel classico Mozart, riservato alle voci più agili e delicate. Data tuttavia la presenza centrale e imponente del personaggio, il suo Tito deciso e vigoroso non è comunque da buttare
- FloriaTosca
- Messaggi: 27
- Iscritto il: ven 18 mar 2011, 16:33
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
FloriaTosca ha scritto:McVicar è un mito per me, il suo nome su ogni dvd che sto per acquistare è una garanzia; tra i tanti sono una grande fan del suo Fluto Magico al Covent Garden. Non riesco a credere che si sia banalizzato!
Anche noi siamo grandi ammiratori di McVicar. Purtroppo non è la prima volta che gli succede, anzi gli capita con una fastidiosa frequenza.
Il Don CArlos di Francoforte è stata un'occasione sprecata, e anche il Trovatore al Met è stato letteralmente buttato via.
Io mi sono fatto un'idea: McVicar deve essere un tipo pacifico,
Quando in un teatro percepisce che le "stranezze" (almeno per un certo autore o repertorio) non sono gradite, lui reagisce così: lasciando gli spettacoli a se stessi; fate un po' come vi pare, purché mi paghiate il mio cachet!
Come dargli torto?
Kunde l'ho ascoltai un paio di anni fa a Napoli proprio in Tito. Premetto che non ho mai amato quest'opera mozartiana; comunque la sua presenza era un netto stacco rispetto agli altri interpreti. Pensai però che il ruolo gli fosse inadatto e che fosse più portato per un genere verdiano (come mi ha confermato nei Vespri) che non nel classico Mozart, riservato alle voci più agili e delicate. Data tuttavia la presenza centrale e imponente del personaggio, il suo Tito deciso e vigoroso non è comunque da buttare
Nemmeno io credo che sia da buttare.
E aggiungo che, a differenza tua, io non credo che Kunde non sia adatto al Mozart serio. Anzi, proprio Ford (e prima di lui, solo in parte, Blake) ci aveva dimostrato che i Rossiniani d'America, proprio perché abituati a incarnare personaggi che discendono da loro, ovvero gli eroi seri di Rossini e del protoromanticismo italiano, sono vocalmente e tecnicamente indicati ad affrontare questo repertorio.
Personalmente ho molte più perplessità su Kunde in Verdi, o per lo meno in certo Verdi (sicuramente i Vespri).
Il problema della presenza scenica è un altro ancora: Kunde è un attore limitatissimo e convenzionalissimo, spesso persino un po' buffo (lo era anche da giovane, me lo ricordo in una Stuarda a Bologna dei primi anni '90). Questo non toglie che come tutti gli attori-cantanti, se il personaggio possiede particolari affinità col suo carattere e la sua sensibilità (questo avveniva un tempo coi ruoli Rubini e oggi con quelli Nozzari) la sua mimica e la sua gestualità divengono più sciolte, più autentiche, meno buffe.
Altrimenti dovrebbe essere guidato da un vero regista d'attori! Peccato perché in questo caso l'aveva trovato: era McVicar.
Salutoni,
Mat
-

MatMarazzi - Messaggi: 3182
- Iscritto il: gio 05 apr 2007, 12:34
- Località: Ferrara
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
il Trovatore al Met è stato letteralmente buttato via
Ma era nato a Chicago dove, mi dicono fonti degne di fede, era bellissimo...
Questo - ce lo siamo già detto - è il problema delle riprese di spettacoli di registi che lavorano DAVVERO sulla recitazione: o li rimontano loro (o qualcuno che sappia lavorare come loro) o non rendono.
Ciao GM
AM
PS: ad Aix c'era il solito caldo insopportabile?
Twitter: @MattioliAlberto
- mattioli
- Messaggi: 1100
- Iscritto il: mer 09 dic 2009, 19:09
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
mattioli ha scritto:Ma era nato a Chicago dove, mi dicono fonti degne di fede, era bellissimo...
Questo - ce lo siamo già detto - è il problema delle riprese di spettacoli di registi che lavorano DAVVERO sulla recitazione: o li rimontano loro (o qualcuno che sappia lavorare come loro) o non rendono.
Vero. Ma questo è perfettamente in sintonia con la critica di "pacificità" che ho mosso a McVicar (il quale per inciso ha rimontato personalmente lo spettacolo al Met).
Quando trova l'artista che ci crede, si impegna a fondo.
Altrimenti lo lascia al suo destino.
In una recente intervista, raccontava di una ripresa del suo celebre Rigoletto al Covent Garden, con artisti diversi da quelli della creazione.
Lui stesso dichiarava che con la Netrebko si era divertito molto, perché era pronta a rispondere con entusiasmo a ogni sollecitazione.
Con Nucci invece niente da fare: "ho sempre fatto Rigoletto così e continuerò a farlo così"
Un altro regista avrebbe dovuto protestarlo; invece McVicar dichiara amabilmente di avergli risposto di far un po' quel che credeva.
Secondo me, il problema di McVicar è che non punta i piedi, specie quando ha a che fare con artisti poco recettivi.
In fondo, come dicevamo, chi glielo fa fare?
ad Aix c'era il solito caldo insopportabile?
A Aix non c'era affatto caldo insopportabile: clima meraviglioso, soleggiato ma fresco, massimo 25 gradi. Addirittura l'ultima sera (quella di Traviata) non è mancata qualche nube minacciosa.
Tu sei stato a Aix dieci anni fa, hai avuto caldo allora e da quell'esperienza hai tratto una legge universale!
A Aix fa sempre caldo!
Un po' il rimprovero che i matematici rivolgevano ai primi fisici alcuni secoli fa: "Voi siete quelli per cui tutti i numeri sono numeri primi: infatti uno è un numero primo, due è un numero primo, tre è un numero primo, quattro è un errore sperimentale e cinque è un numero primo".
SAlutoni,
Mat
-

MatMarazzi - Messaggi: 3182
- Iscritto il: gio 05 apr 2007, 12:34
- Località: Ferrara
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Qualcuno ha visto la Clemenza di Tito di Monaco (dal vivo o in streaming)?
DM
DM
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Io l'ho ascoltata per radio la scorsa settimana. Mi è dispiaciuto non vederla in streaming: la Opolais buca lo schermo anche solo nel trailer.
Nel complesso l'ho trovata molto buona, con una direzione di Petrenko davvero elettrizzante: per la prima volta ho apprezzato veramente quest'opera. Forse Petrenko dovrebbe dedicarsi più a Mozart che a Wagner, visto il Ring dell'anno scorso.
Fantastica la Opolais, anche se l'ho trovata inizialmente sotto tono (specialmente nel "Vengo...aspettate").
Quello veramente sotto tono però mi è sembrato Toby Spence, slentato e con qualche problema in acuto.
Ovviamente sono solo impressioni avute per radio, magari qualcuno l'ha vista e ci dirà di più.
Nel complesso l'ho trovata molto buona, con una direzione di Petrenko davvero elettrizzante: per la prima volta ho apprezzato veramente quest'opera. Forse Petrenko dovrebbe dedicarsi più a Mozart che a Wagner, visto il Ring dell'anno scorso.
Fantastica la Opolais, anche se l'ho trovata inizialmente sotto tono (specialmente nel "Vengo...aspettate").
Quello veramente sotto tono però mi è sembrato Toby Spence, slentato e con qualche problema in acuto.
Ovviamente sono solo impressioni avute per radio, magari qualcuno l'ha vista e ci dirà di più.
-

reysfilip - Messaggi: 450
- Iscritto il: sab 09 feb 2013, 11:49
- Località: Firenze/Pisa
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
reysfilip ha scritto:Io l'ho ascoltata per radio la scorsa settimana.
Bravo!
Mi è dispiaciuto non vederla in streaming: la Opolais buca lo schermo anche solo nel trailer.
Vero!
reysfilip ha scritto:Nel complesso l'ho trovata molto buona, con una direzione di Petrenko davvero elettrizzante: per la prima volta ho apprezzato veramente quest'opera.
Io invece amo particolarmente la Clemenza. Consoci l´edizione diretta da Jacobs? Per me fu una vera rivelazione!!!
DM
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Riapro questo thread perché in questi giorni mi sto massacrando di Clemenza.
Le cose sono partite da una generica riscoperta del simbolismo massonico di Mozart (che ovviamente non riguarda solo il Zauberfloete) e così mi sono (inizialmente) costretto a risentirmi quest'opera.
Che è meravigliosa.
Credo che raramente il divino Amadè abbia scritto musica tanto bella, ricca e complessa. Mi pento terribilmente di non averla mai approfondita per colpa di una pessima rappresentazione cui assistei alla Scala durante il Ventennio.
Ma non è mai troppo tardi.
Tra l'altro, ho un bel po' di incisioni. In questo momento mi sto godendo quella bellissima e molto teatrale di Harnoncourt, con uno splendido cast, a cominciare da un bravissimo Langridge (qui sono un po' in disaccordo con il mio amico Elvio Giudici che - si sa - non ama particolarmente gli interpreti mozartiani britannici).
Voi cosa ne dite?
Le cose sono partite da una generica riscoperta del simbolismo massonico di Mozart (che ovviamente non riguarda solo il Zauberfloete) e così mi sono (inizialmente) costretto a risentirmi quest'opera.
Che è meravigliosa.
Credo che raramente il divino Amadè abbia scritto musica tanto bella, ricca e complessa. Mi pento terribilmente di non averla mai approfondita per colpa di una pessima rappresentazione cui assistei alla Scala durante il Ventennio.
Ma non è mai troppo tardi.
Tra l'altro, ho un bel po' di incisioni. In questo momento mi sto godendo quella bellissima e molto teatrale di Harnoncourt, con uno splendido cast, a cominciare da un bravissimo Langridge (qui sono un po' in disaccordo con il mio amico Elvio Giudici che - si sa - non ama particolarmente gli interpreti mozartiani britannici).
Voi cosa ne dite?
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
Mi piace moltissimo La Clemenza di Tito: trovo modernissima quella sua ambiguità dovuta ad una formale adesione ai canoni dell'opera seria, ma stravolti dall'interno e rivoluzionati completamente (peraltro è molto interessante confrontare il genio mozartiano e altri due autori alle prese con lo stesso libretto - Galuppi e Gluck, di cui è appena uscita la nuovissima edizione integrale in ben 4 cd - e notare le scelte in ordine al testo e soprattutto quello che riesce a cavare dal convenzionale melodramma metastasiano). Ne ho molte edizioni anch'io: mi piace molto quella di Hogwood, quella di Jacobs (pur con eccessi nei recitativi) è forse il suo miglior risultato in ambito mozartiano e poi il classico per eccellenza, ossia Kertesz. Come ho già detto, poi, ho una predilezione per il Mozart di Bohm...purtroppo i cantanti sono deludenti (soprattutto Schreier). Vidi anch'io l'edizione mutiana e ne rimasi affascinato: uno dei suoi Mozart migliori.
Matteo Mantica
"Fuor del mar ho un mare in seno"
"Fuor del mar ho un mare in seno"
-

teo.emme - Messaggi: 883
- Iscritto il: mar 06 apr 2010, 19:32
- Località: Crema
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
quella di Jacobs (pur con eccessi nei recitativi)
Rispetto a cosa?
AM
Twitter: @MattioliAlberto
- mattioli
- Messaggi: 1100
- Iscritto il: mer 09 dic 2009, 19:09
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
vittoriomascherpa ha scritto:pbagnoli ha scritto:...una pessima rappresentazione cui assistei alla Scala durante il Ventennio...
Pensa che per me quella fu una delle due migliori performance mozartiane di Muti (con la cooperazione d'uno splendido Winbergh, seppure di timbro cosí particolare)
A me toccò Morino. Questo il cast:
TITO VESPASIANO
GIUSEPPE MORINO Tenore
VITELLIA
CHRISTINE WEIDINGER Soprano
SERVILIA
NUCCIA FOCILE Soprano
SESTO
ANN MURRAY Mezzosoprano
ANNIO
NICOLETTA CURIEL Mezzosoprano
PUBLIO
GIOVANNI FURLANETTO Basso
Non so: forse ero giovane io, forse l'allestimento non fu entusiasmante, se non sbaglio non c'era nemmeno Muti ma qualche maestro sostituto. Fatto sta che ne uscii annoiato a morte e segnato pesantemente dalla pessima esperienza.
Adesso mi sto rifacendo!
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: La Clemenza di Tito (Mozart)
mattioli ha scritto:quella di Jacobs (pur con eccessi nei recitativi)
Rispetto a cosa?
AM
Li trovo troppo "ricchi", nel senso che il pur bravissimo Paronuzzi accompagna i recitativi in modo molto creativo, tanto da appesantirli talvolta
Matteo Mantica
"Fuor del mar ho un mare in seno"
"Fuor del mar ho un mare in seno"
-

teo.emme - Messaggi: 883
- Iscritto il: mar 06 apr 2010, 19:32
- Località: Crema
15 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti