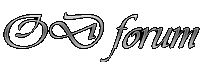Brutti questi Vespri? Assolutamente no. Diciamo che personalmente sono un po' a livello quando si apre il sipario e mi vedo ricostruito il solito teatro con i soliti palchi (in questo caso l'Opéra del 1855) e il solito palcoscenico visto di taglio. In questo caso in teatro si rappresenta la solita lotta tra creativi (i siciliani che stanno sul palco, ovvero gli artisti) e i filistei (i francesi, rozzi e brutali che rappresentano il pubblico). Il corto circuito si viene a creare quando Monfort (pubblico) stupra una ballerina (artista) e dallo stupro nasce Henri (nè carne nè pesce). Dal fattaccio il macchinone vespresco si mette in moto con i suoi schematismi drammaturgici (che Herheim non mostra di voler risolvere nè attenuare) e con buoni, a volte ottimi e spettacolari momenti di scenotecnica applicati a una regia (in quanto direzione d'attori) piuttosto elementare. Inoltre c'è anche qui il sogno ( nel quarto atto) che serve a trarsi d'impaccio quando la drammaturgia diventa sempre più stringente.
Pappano dirige magnificamente. Un Verdi esplosivo per colori, cantabilità entusiasmo. Le voci sono sempre sorrette e valorizzate. I tempi sono azzeccati in una commistione perfetta di fantasia e alto artigianato. Bravissimo.
Volle è stato, per me, la grande sorpresa di questi Vepres. Un Monfort di grande presenza sia scenica che vocale. Un canto sulle prime roccioso e monocromatico che, all'occorrenza, riesce a stemperarsi in colori e accenti di immensa malinconia. L'aria del terzo atto è stata meravigliosa e soprattutto sorvegliatissima nella linea musicale nel ritmo. Volle non si canta mai addosso. Bravissimo anche lui.
Hymel svetta nella parte di Henri. Il settore sovracuto e brillante, e, quando non è del tutto brillante, almeno è spavaldo. Era la prima e certe note (quisquillie) non proprio perfettamente a fuoco erano imputabili all'emozione.
Schrott ha una spettacolare (e piacionesca) presenza scenica. Qui Procida è un ottocentesco maestro di ballo, alla Degas, torturato e seviziato dal pubblico-francese in quanto figura speculare della frigidissima Hélen. Forse nelle repliche migliorerà, ma alla prima non ha fatto una grande figura. Linea vocale così, un tanto al chilo, sfumature fatte senza un preciso riferimento al testo e al significato di quanto si andava esprimendo, ritmica a fisarmonica.
Resta l'Haroutunian. Chiamata a sostituire la Poplovskaya (già di per se un errore di cast madornale) ha arrancato stritolata dall'emozione per i cinque atti. Persone fidate mi avevano detto meraviglie della sua Elisabetta e quindi mi aspettavo almeno una canto corretto. E invece niente. Gravi gonfiati, centri discreti e di buon colore (come ne sentiamo molti, intendiamoci) e acuti faticosi, tremendi se emessi a mezzavoce. Senso della frase, della recitazione, della parola tirante a zero. Ma era entrata alla generale e quindi non si poteva poi pretendere troppo. Il pubblico londinese è stato gelido: neanche un misero clap dopo le sue arie. Nemmeno un tentativo di applauso. Ed è una sensazione, a mio parere, più tremenda che una gragnuola di fischi e di buuu. Si mormora che soffrisse di una laringite esplosa nel corso dell'opera.
Dicono che la Poplovskaya ritorni per le prossime repliche.
"Pop" pops in again!
WSM