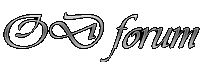Che li facciano a Bayreuth!
Di conseguenza quest'anno hanno trionfato i furbi.
La palma spetta senza dubbio al furbissimo (e geniale) Stephan Herheim.
Nietzche aveva colto nel segno quando, in "Al di là del bene e del male", scrisse che i Meistersinger esprimono esattamente le genti tedesche che appartengono all'altro ieri, sono proiettate nel dopodomani e non hanno alcun presente.
Herheim ha capito l'antifona.
Il dopodomani dei Meistersinger (svasticamente parlando) è ancora ingombrante e, soprattutto, stravisto. Il presente -come dice Nietzche e come ha dimostrato Guth nel suo deludente allestimento contemporaneo- non esiste. Conviene concentrarsi quindi sull'altroieri, dimensione dello spirito più tranquilla e più adatta a una celebrazione festivaliera. Bisogna però aggiornarsi; allora -e qui sta la furbesca genialata- infiliamo questo "altroieri" dentro una cornice altamente simbolica così lo "stravisto" diventa "voluto" e il "tradizionale" diventa "scelto" e non "subìto".
Wagner -ci dice Herheim- è un padre della patria e i Meistersinger sono un totem dell'identità nazionale tedesca. Tutta l'opera diventa quindi la fotografia di un gioioso raptus creativo wagneriano in cui Sachs e Wagner e Beckmesser e forse Herheim sono tutt'uno. Un momento creativo così gioioso dove anche il terribile Wahn (che comunque Wagner considerava parte integrante di qualunque atto creativo) perde ogni terribilità se privato di ogni conflitto e raccontato come un'innocua follia da cartone animato dei fratelli Grimm (altri padri della patria e della lingua).
Impacchettati dentro un konzept da prima elementare (che infatti hanno capito tutti, ma proprio tutti, anche i blogghettari più ottusi e reazionari), scenograficamente costruiti con un insolito sfarzo e una strabiliante tecnologia di solito destinata al musical, questi tradizionalissimi Meistersinger hanno trovato un loro perchè. Come tutte le cartoline Liebig leggermente riviste hanno messo d'accordo tutti. I progressisti si sono sentiti coinvolti da uno spettacolo tutto sommato nuovo ma pieno di innocue tradizioni e i coservatori si sono sentiti coinvolti da uno spettacolo tradizionale ma pieno di innocue novità.
Non a caso anche il tradizionalissimo Gelb ha comprato questi tradizionalissimi Meistersinger per il tradizionalissimo pubblico del Met e per le tradizionalissime proiezioni in HD nei cinema di tutto il mondo.
Non c'è niente di male, intendiamoci. Lo spettacolo è visivamente molto bello e merita di essere visto. Dal vivo è stata per me un'esperienza scenotecnica esaltante.
Mi stupisce solo che pochi, davvero pochi, abbiano sottolineato la genericità di certe soluzioni sceniche, la scarsa cura riservata alla recitazione dei singoli e il senso di stasi che permeava molti momenti. Non lo nego: due o tre trovate erano interessanti, il finale bello e ruffiano faceva esplodere la platea, le carabattole sceniche erano tantissime e bellissime... bene, tutto questo non è riuscito a riempire il vuoto di questo allestimento per me sostanzialmente freddo e soprattutto ammantato di un giustificazionismo quantomai fastidioso.
"Hier gilt's der Kunst" sembrano dirci, parafrasando Siegfried, sia Herheim che Pereira. L'ombra nera di Mordor, il Wahn che distrugge l'equilibrio di una Nurnberg simbolo di un quiete e di un ordine ( il "Tag" tristaniano?), il Wahn che è anche depressione e vuoto dell'anima (Jones a Cardiff ma anche McVicar), il Wahn che è anche lo stordente profumo di gelsomino in una notte estiva dove il buio sembra non venire mai, il Wahn che è rinuncia a un qualcosa di vitale (la rinuncia di Sachs che è anche la rinuncia di Alberich, di Elsa, di Siegmund, di Brunnhilde e di Tristan e di Marke)... tutto questo rimaneva ben nascosto dentro questo lussuosissimo giocattolone dove le antiche caccole Sachs-Beckmesser sono state rispolverate tutte, ma proprio tutte, con magistrale furbizia. E' stato divertente (e istruttivo) vedere quelli che fino all'altro ieri ironizzavano su Otto Schenck e Wolfgang Wagner (senza mai aver messo piede a Bayreuth o a Monaco) cascare nella rete, ipnotizzati come il bravissimo Pogner-Zeppenfeld di questa edizione, e scandire "ge-nia-le" con entusiasmante e ingenuo candore. Ha diretto Gatti in maniera spigolosa e contrastata ricordando il Solti dei giorni peggiori. Del cast il migliore era Werba. Volle è stato un Sachs a forti tinte, un po' troppo sopra le righe, sovraccarico e -riascoltate i due monologhi- per niente aiutato da Gatti. Nel secondo addirittura sfasato ritmicamente. C'è la registrazione che lo testimonia. Alla mia recita, un po' meglio.
Il secondo furbo -ma molto, molto meno capace rispetto ad Herheim- è stato Michieletto.
Che non è uno sprovveduto, assolutamente. Ha un certo talento nel capire quali siano le tendenze drammaturgiche più accreditate del momento, sa circondarsi di bravi collaboratori, si capisce che ha visto una sacco di teatro e giurerei che ama profondamente l'opera. Lo si capisce dalla compunta serietà dei suoi approcci e perchè non appartiene, fortunatamente, alla schiera dei cosiddetti Innovatori che, per risolvere certi passi "melodrammatici" che nel melodramma ci sono
E quindi abbiamo un Falstaff ambientato nella casa di riposo per artisti voluta da Verdi a Milano.
Se leggiamo un bignamino verdiano possiamo anche pensare che sia giusto, dopotutto è un'opera crepuscolare, scritta da un vecchio, pensata per dei vecchi, malinconica, autunnale, a finecorsa...
Come ci si aspettava ecco la solita scenografia iperrealistica, la musica che comincia in ritardo rispetto all'azione scenica (ormai lo fanno tutti), tulle trasparenti per i trapassi di registro e l'onnipresente, onnipotente, ubiquitario e universalmente usato "sogno del protagonista", utilissima foglia di fico e al contempo facile scappatoia per giustificare vuoti d'ispirazione. Un vecchio cantante "sogna" il Falstaff. Come è successo per la Frau di Loy, anche qui troviamo un'idea iniziale che non è nè buona nè cattiva, ma che non può essere giudicata semplicemente perchè non viene sviluppata. Dopo il colpo d'occhio inziale ti aspetti che ogni elemento, ogni apparizione, ogni gesto trovino una loro giustificazione e ci appaiano finalmente significanti e, soprattutto, necessari in questa ambientazione nuova e non convenzionale.
E invece niente.
Parte il solito Falstaff dove le comari si muovono aggraziate e a passo di danza (la Cedolins, tremenda!!!) attorno al corpaccione del protagonista che continua a fare il Falstaff goloso e laido degli anni cinquanta (il mangione!) mentre Fenton e Nannetta vengono doppiati da una tenera coppia di anziani che sembrano usciti da una trasmissione di Paolo Limiti. Bardolfo e Pistola fanno i buffoni come hanno sempre fatto, Ford nel monologo delle corna fa le corna, quando le comari vogliono specificare un concetto fanno il tarallo con indice e pollice... Davvero non riesco a capire come coloro che -giustamente- hanno accusato Jones e Wernicke di eccedere in caccole possano passare sotto silenzio questo campionario di smorfie, di broncetti, di gesti esagerati, di baccani... Giustamente anche Michieletto ha i suoi fan...

Cast "difficile", con un Maestri, nella mia sera, un bel po' fuori forma. Mehta era come se non ci fosse.
Il terzo furbo, furbissimo, è stato Stein.
Permettetemi la sfrontatezza, ma forse lui è stato il più furbo di tutti. Ha intascato il cachet per una regia... senza fare la regia. Vi giuro che ad apertura di sipario mi sembrava di essere tornato agli anni Settanta.
Che dolce malinconia... il coro dei boscaioli fermi a raccogliere i bacchettini tutti rivolti verso il pubblico, Don Carlo che entra seguito da un occhio di bue e si mette a sedere su una pigna di tronchi... nell'auto-da-fè il coro che entra metà da destra e metà da sinistra si incontrano in mezzo alla palcoscenico con fare stupito e poi, sulla tonica, come soldatini si girano tutti schierati in fila per attaccare il "Spuntato ecco il dì"... Che dolce malinconia! E c'erano persone che per vedere questo allestimento avevano pagato anche 500 euro. E critici che hanno parlato dell'asciuttezza drammaturgica di Stein.
Pappano conosce questa partitura anche capovolta ed è stata l'unica ragione di interesse in questa produzione. Kaufmann era davvero in difficoltà. Lo abbiamo sempre detto: Kaufmann non è un tenore buono a tutti gli usi. Purtroppo si è convinto del contrario e, dopo l'imbarazzante Manrico di Monaco, ha deciso di continuare sulla strada verdiana e ci ha consegnato questo Infante generico, faticoso negli acuti, dalla linea spezzata, spezzata da prese di fiato continue. In certi momenti se chiudevi gli occhi ti sembrava di sentire Bonisolli. Gli altri, se possibile, sono stati ancora meno interessanti con un Salminen capace di tutto. Anche di un duetto con l'Inquisitore (Halfvarson) degno di una parodia alla Mel Brooks. Certo che se paghi 500 euro ed hai dovuto corrompere qualcuno per avere un biglietto (come è capitato ad alcuni conoscenti per questo Don Carlo) allora devi dire per forza che è stato bello. Anzi bellissimo.
Resta lei.
Anzi Lei. La regina di tutte le furbe.
Il genio primadonnesco allo stato puro. Cecilia Bartoli e la sua Normafuorinorma.
L'evento era di quelli telefonatissimi.
Interviste dappertutto, manifesti ovunque, pigne di cd da firmare , giustificazioni musicologicamente infondate (la Norma della Malibran), chiacchiere fintodrammaturgiche (Norma donna del popolo), isterismi di fan venuti da mezzo mondo (Norma della "Ceci"!), idiozie cinematografare (Norma alla Rossellini), e via di questo passo. I biglietti -ovviamente al mercato nero- hanno raggiunto cifre da capogiro (si parla anche di 1000 euro per un posto di platea) e nella mia sera l'Haus fur Mozart ha ospitato il più ricco e vistoso gerontocomio che il frullo festivaliero potesse produrre. Una bomba nel foyer e sarebbe sparita la metà dei principali contribuenti delle casse austriache.
Pereira ci aveva anche messo del suo.
Fuori, in una galvanizzante teoria che arrivava fino ad Herbert von Karajan Platz, il boss aveva schierato una cinquantina di lucidissime Audi nuove di zecca (sponsor del Festival) che aspettavano, con tanto di autisti bellissimi e aitanti, alcuni straricchissimi patron del festival che, assieme al biglietto per la Normafuorinorma, avevano comprato anche il transfert con cui fuggire nella notte che prometteva tempesta.
Tempesta che, all'interno del teatro, non c'è stata. A parte un tuono così potente che ha fatto partile le emergenze di sala.
Com'è stata la Norma della Bartoli?
Interessante in alcuni momenti (Teneri figli), fuori stile in altri (Ah bello a me ritorna...), faticosa in certi appuntamenti fissi (Casta Diva), timbricamente monotona e quindi un po' noiosina nei recitativi (tutto quel soffiare), meravigliosa (questo senza mezzi termini) nel finale, e applauditissima tipo rockstar ai ringraziamenti.
E' stata una grande Norma?
Nello specifico penso di no e, per quel che mi riguarda, non ho una gran voglia di riascoltarla.
In assoluto invece ritengo che l'operazione abbia una sua ragione d'esistere. Non fosse altro che per provare a togliere Norma dalla secche callasiane in cui -vista l'autorevolezza del modello- ancora si dibatte.
Non si scappa; tutte le Norme del dopocallas hanno comunque declinato il taglio callasiano (leggi eloquio altero e dignitoso, sacralità sovrumana e iscritta nella pietra, Matteo felicemente parlava di "piedistallo") allontandosene negli intenti (vedi Suthrland e Caballè) ma di fatto rientrandoci senza proporre delle valide alternative. Bravissime, intendiamoci, ma, con tutto il rispetto, "genialmente derivative".
Al di là della valutazione del risultato, almeno la Bartoli ha provato a percorrere un'altra strada.
Certo, l'ha fatto da furba, inventandosi, di fatto, una Norma che non esiste (lei dice quella della Malibran, noi che è quella solita senza acuti e in certi passi abbassata) e costruendo un personaggio dal taglio realistico (anzi, neorealistico) che con Norma ha poco da spartire. Però ci ha provato e certe pagine, ad esempio il finale, hanno trovato un altro significato teatrale ed espressivo. Nè migliore nè peggiore di quanto siamo abituati ad ascoltare, ma diverso.
Purtroppo l'allestimento di Leiser e Courier rientrava nei parametri e nella scuola Loy/Michieletto. Ambientazione originale (la Roma dell'occupazione nazista) risolta solo scenograficamente. Una palestra di una scuola dove si riunivano i partigiani. Poi, dai che ti dai, alla fine tutti si muovevano, passo più passo meno, come nelle Norme che abbiamo sempre visto. E al "guerra! guerra!" il coro faceva il catenone come nell'antico allestimento di Ceroli.
La Bartoli con indosso il vestitino della sora Cecioni e un coltellaccio da ragù tipo Cianciulli prometteva, da ogni angolo di Salisburgo, sfracelli teatrali ed emozioni sceniche al calor bianco. Ne sono arrivate poche, ma valeva lo stesso la pena esserci.
Anche se vi garantisco che io ho pagato il biglietto solo 80 euro.
E meno male!

WSM