Arrivo buon ultimo a dire la mia.
Anche perché mi sono beccato l'ultimissima recita non solo della produzione, ma anche della stagione (e a causa di ciò mi sono pure dovuto sciroppare il patetico pistolotto finale del direttore del teatro, un presenzialista insopportabile dai lunghi capelli, che - con tutta la compagnia schierata sul palco - ha ripetuto in tre lingue vari encomi a se stesso, al lavoro di squadra della Monnaie, in cui tutti si vogliono bene, nonché varie geremiadi sul pericolo che si tolgano fondi alla cultura e sulla necessità di foraggiare i teatri ...e il suo stipendio. Pareva di essere precipitati a una recita scolastica).
Il vantaggio dell'ultima recita è che tutti gli artisti sono estremamente rilassati.
Infatti i cantanti sono stati sensibilmente migliori rispetto al video della prima.
A questo proposito vorrei un po' temperare le espressioni scandalizzate dei confratelli che mi hanno preceduto.
In astratto i cinque cantanti erano tutti validissimi professionisti; il problema è che sono abbastanza refrattari alle prerogative del canto Verdiano, alle specificità tecniche e stilistiche che in esso abbiamo scoperto.
Detto questo però i cinque non erano i "primi venuti". Non è un cast da periferia italiana o tedesca.
Sono comunque forti personalità e nomi importanti del panorama attuale.
E' vero, però, che la loro "aspecificità" linguistica risaltava in modo particolare in "questo" Trovatore, perché la direzione di Minkowski era la più "specifica" (e artisticamente esaltante) che sia possibile sentire.
Non esiste oggi un direttore che possa dirigere quest'opera meglio di così.
Contrariamente alle mie abitudini, spesso mi perdevo a fissarlo, a fissare i violini, i corni, gli ottoni, dimenticando quello che accadeva in scena... tanto ero rapito da quanto si potesse tirare fuori da una musica che pensavo di conoscere a memoria.
Per questo il cast sembrava ancora più sbagliato: era doloroso sentire gli archi rubare con incantevole perizia una certa melodia, e trovarci sopra un soprano che arranca solo per restare a tempo.
O sentire l'orchestra danzare selvaggia sul tema di "Abbietta zingara", come in un valzer di morte, e sopra un basso che non riesce a stargli dietro.
Che senso ha valorizzare l'infinitesimo trillo di "Stride la vampa" o "Ah sì, ben mio" se poi l'Azucena e il Manrico di turno soppiantano i trilli con i soliti gruppetti e mordentini che facevano anche la Barbieri e Corelli!
E' questo l'assurdo!
L'anno scorso, per gli Ugonotti,Cutler o la Petersen o la Lezhneva respiravano col direttore.
Quest'anno invece la parte strumentale si affacciava sul domani, mentre quella vocale restava ancorata a ieri l'altro.
Detto questo, io però non ho sentito prestazioni tanto disastrose.
Sono i soliti verdiani improvvisati come, nella mia vita, ne ho sentiti tanti.
Non in tanti, però, si sono dimostrati attori sensazionali come questi (fa eccezione solo Tiliakos, che dovendo sostituire Hendrics non deve aver provato a sufficienza).
In cima alla lista pongo le due donne.
La Brunet ci regala una composizione scenica fantastica, la migliore che le abbia visto fare a tetro: si resta conquistati dalle sue infinite controscene, fatte di sguardi maliardi e di pose ridicole, o dal suo ondeggiare greve e sensuale sui ritmi ipnotici di Stride la Vampa.
Ma è soprattutto nell'evoluzione dalla prima alla seconda parte che rivela le sue maggiori capacità espressive: quando cioè da vecchia signora petulante diventa una povera pazza, fragile e instupidita, che gli eventi trascinano alla deriva.
Il contrasto è impressionante.
La Poplovskaja è un'altra attrice coi controfiocchi.
Pur senza mai strafare, con una gestualità controllata e sobria, non priva di ironia e di sensualità ha descritto a sua volta un'evoluzione grandiosa, con punte (al quarto atto) veramente trascinanti.
Vocalmente... lo sappiamo! Il suo problema non è di cantare male (anche se non è fatta per questo repertorio, alla fine agilità, trilli, sopracuti, filature li ha fatti), ma di incappare in sonorità bruttissime, sgraziate e stridenti, sparse lungo l'estensione, che talvolta le fanno persino perdere l'intonazione.
Posso solo dire che in generale le sue condizioni vocali alla mia recita erano decisamente migliori che nel video della prima (dove, per inciso, stava male, tanto da non essere nemmeno uscita per gli applausi).
Di tutto il cast, quello più lontano dalle esigenze che oggi attribuiamo al canto Verdiano era Didyk.
Il tenore è talentuoso, valido interprete, ottimo declamatore e di bel timbro nel medium.
Che questo non basti per cantare Manrico è evidente: il settore acuto ha tutte le caratteristiche del declamatore, non del vocalista, per cui ogni volta che varca il passaggio i suoni sono sparati, mai legati, mai funzionali rispetto al decorso melodico. Il ritmo (esercitato su tutt'altro repertorio) qui appare rudimentale.
Non parliamo della dinamica! Ogni tentativo di smorzare un fallimento.
Anche come attore Didyk non è apparso risolutivo come in altre occasioni
Giovanni Furlanetto accusa a sua volta un canto troppo legnoso e declamatorio (ereditato dal fratello?) per questo repertorio.
Però vi confesso che una delle ragioni del mio entusiasmo era fissarlo nelle reazioni e contro-scene. Pur consapevole della marginalità del suo ruolo, quindi senza mai strafare, si è rivelato un animale da palcoscenico che non sospettavo.
Chapeau!
Infine Tiliakos, la cui linea - pur intaccata da varie scorie timbriche - ha finalmente un respiro verdiano.
Come attore ho rimpianto Hendrix, molto più acceso e motivato. Ma come cantante ho ringraziato il cielo di avere lui: il Balen (uno dei vertici musicali e drammaturgici di questa produzione) ha guadagnato moltissimo a essere eseguito con sonorità da vero vocalista.
Tengo per ultimo Tcherniakov, che ha destato i maggiori dibattiti in questo thread.
Quando ho visto, in video, la registrazione della prima, le mie reazioni sono state identiche a quelle di Maugham e Pietro.
A teatro invece mi è parso uno spettacolo bellissimo, trascinante, imperdibile!
Forse perché avevo eliminato le mie attese: già sapevo che l'edificio cammaraniano non sarebbe stato risolto in una clamorosa destrutturazione di quelle a cui Cerniakov ci ha abituato.
Non dovevo più interrogarmi, riflettere, seguire piste, anticipare l'aprosdoketon finale, ma solo godermi l'evolvere coerentissimo e affascinante della nuova fabula.
C'è poi da dire che, alla prima, il tutto non era ancora oliato, anche a livello registico: basta dire che si sono persino dimenticati l'effetto importantissimo di strappa ad Azucena la parrucca alla fine del primo quadro del terzo atto.
Infine mi pare che il video non sia stato fatto particolarmente bene: l'insistenza sui primi piani priva dell'elaboratissimo gioco di sguardi, controscene, disposizioni geometriche dei personaggi che a teatro tenevano continuamente desta l'attenzione.
Venendo al sodo...
Il Trovatore è un'opera sperimentale e audacissima a livello narrativo, per certi versi trionfale, per altri fallimentare.
La vicenda si inerpica tanto a livello verticale (gli antefatti, l'incombere del passato e le sue implicazioni sull'azione visibile) quanto a livello orizzontale (l'incedere narrativo attraverso gli atti).
Sul piano verticale il Trovatore è un fallimento, lo sappiamo tutti.
L'antefatto non si capisce; le piste vengono aperte e non chiuse... Pensiamo solo al fatto che il titolo è "Il Trovatore" ma Manrico (che ci appare solo in veste di zingaro e soldato di ventura) di un Trovatore non ha nulla e non fa nulla (va be', canta una serenata... ma anche Lindoro lo fa).
Il contesto storico, così importante per Gutierrez, qui è rudimentale; delle ragioni politiche che contrappongono gli Aragonesi agli "Urgeliani" non emerge nulla.
Il contesto geografico è ancora più fumoso (che c'entra Pelilla con le guerre civili in Aragona? e Castellor dove diavolo sarebbe? perché i prigionieri di Castellor sono chiusi nell'Aljaferia a Saragozza?). I nessi che dovrebbero collegare il passato al presente non esistono (ad esempio ci si potrebbe chiedere come faccia un povero zingaro della Biscaglia a diventare prima trovatore, poi cavaliere da tornei, poi seguace di Urgel e addirittura comandante, infine corteggiatore di Lenora... a poco più di 15 anni)

Insomma, se dovessimo valutare il Trovatore solo nell'articolazione "verticale" lo potremmo considerare un disastro... che però si riscatta in modo favoloso sul piano "orizzontale" ossia sull'asse spaziale-temporale sul quale si articola la vicenda vera e propria, quella visibile.
E qui il Trovatore è un miracolo! L'architettura narrativa è un prodigio di equilibri e tensioni da far impallidire il 90 % dei libretti d'opera (e tutti quelli di Wagner, almeno da questo punto di vista)!

Mai visto un libretto più complesso, architettonico, euritimico e sperimentale.
Tutti noi in fondo ci aspettavamo che Cerniakov lavorasse sulla parte verticale; se c'è uno che possa darle senso è lui: basta pensare ai prodigi che ha compiuto sul Don Giovanni, dove è riuscito a inventarsi una premessa enorme, un antefatto mille volte più articolato e terribile rispetto a quello di Da Ponte (che in pratica non c'è) e facendolo passare al pubblico con una facilità espositiva che lascia annichiliti.
Ciò che tutti speravamo è che anche nel Trovatore (proprio perché la verticalità narrativa in quest'opera fa acqua) il regista russo costruisse una qualche storia stupefacente, moderna, cinematografica, come sa fare lui, in grado di ricucire i buchi che Cammarano aveva lasciato aperti.
E invece, sorprendendoci (e inizialmente deludendoci) Cerniakov ha fatto tutt'altro.
Se dietro al Don Giovanni (opera quasi priva di antefatto) aveva costruito un edificio immane, sull'antefatto del Trovatore (che sarebbe enorme) ha tirato una riga.
L'antefatto, la parte "verticale" della vicenda del Trovatore, è azzerato senza pietà.
Tutto quello che nell'opera è ricordo, qui diventa elaborazione fantastica, gioco di fantasia, improvvisazione di rancori repressi.
Insomma, pare dirci (e in fondo giustamente) Cerniakov, perché dobbiamo ammattire con ciò che non funziona nel Trovatore?Troviamo il modo di annullarne i difetti e concentriamoci invece su ciò che funziona alla grande: la parte "orizzontale".
Capisco che la sensazione iniziale sia di una scappatoia: Maugham l'ha percepita così e inizialmente anche io.
Poi però, a teatro, ho cambiato idea.
Perché, sia pure rinunciando a tutto il "prima" (o per lo meno riducendolo a un moncherino), Cerniakov ha esaltato come nessuno prima di lui ciò che invece nel Trovatore funziona.
Le tensioni narrative (già strutturatissime nel libretto) con Cerniakov si comprimono ulteriormente in una narrazione ancor più serrata e trascinante, radicalizzandosi in un' Unità di Tempo che contrae tutta l'azione in poche ore, senza soluzione di continuità, dove l'aderenza fra azione descritta e azione reale è perfetta.
Persino i pochi minuti di intervallo (nei quali il pubblico si alza ed esce) corrispondono a qualcosa che avviene... una "mezz'ora" di storia che non vediamo e che intuiamo all'apertura del sipario.
Che poi quella mezz'ora (che non vediamo) corrisponda esattametne al vertice del "climax", alla punta della forcella, rende ancora più emozionante la narrazione di Cerniakov: è in quei minuti che il conte (umilato e distrutto alla fine del secondo atto) prende in pugno la situazione e si trasforma da vittima a carnefice.
Anche l'unità di luogo si condensa in un'unica stanza (un vecchio, elegante appartamento preso in affitto da Azucena, spoglio, con le pareti rosse ricoperte di antiche specchiere e il divano ancora coperto da un telo). Da sede del gioco crudele di Azucena, diventerà prigione da cui non è possibile fuggire.
Ma è soprattutto l'Unità di Azione (che in Cammarano si complicava in due - tesissimi - fili indipendenti) a raggrumarsi in un unico possente arco a cui tutti i personaggi partecipano insieme: una tensione che avanza spasmodica lungo i primi due atti e che esplode nei due successivi, si sfoga e si esaurisce.
Nella prima parte Azucena (col collaboratore Ferrando) accoglie i suoi ospiti, tre persone che si conoscono bene, molto probabilmente parenti: Manrico (personaggio a cui vanno tutte le simpatie di Azucena), il Conte e sua moglie (o fidanzata) Leonora.
I tre si conoscono; che Manrico sia noto alla coppia, lo dimostra il rapido bacio sulla guancia che scambia con Leonora quando essa entra, e la stretta di mano (questa un po' più imbarazzata) che divide col conte.
Anche Azucena deve essere imparentata (altrimenti non sarebbe corsa ad abbracciare Manrico, il quale ricambia con un certo disagio), forse una zia...
In tutti i casi (e questo è l'unico moncherino di antefatto che è rimasto) Azucena sa che tra Manrico e Leonora c'è del tenero.
Un tenero inespresso, nascosto, mai dichiarato, ma c'è.
Lui non può aspirare a confessarlo perché, rispetto al conte, legittimo fidanzato, Manrico si sente perdente.
Il conte è elegantissimo, ricco, di successo. Lui invece sembra un cantante da balera: capelli ossigenati e giacca pitonata.
Leonora è sua e Manrico non ha speranze.
Ma non per Azucena, questa buffa e un po' patetica signora intrigante, dall'eleganza sovraccarica e fuori moda, di quelle tipiche zitelle che cercano di animare la loro noiosa vita facendo le dive e nutrendosi di sogni d'amore altrui.
Qual'è il suo obbiettivo?
Far emergere l'amore fra Manrico e Leonora. Costringerli a dichiararsi e ...naturalmente... umiliare il conte, questo tipo troppo solido, troppo ironico, troppo sicuro di sè, troppo sprezzante.
E così organizza un gioco: li convoca tutti in un appartamento fuori mano, fornisce loro dei copioni.
Il gioco consisterà nel recitare una storia fantastica (di cavalieri, tornei, guerre civili, bambini rapiti e streghe).
In questa storia (ovviamente) i personaggi recitati da Manrico e Leonora si amano e si amano alla faccia del conte.
Lei conta sul fatto che la storia "finta" farà emergere i sentimenti "veri".
E così avviene... nei primi due atti.
Il conte prende il gioco con irritazione, irridendo alle assurdità della vecchia. Ma la sua irritazione va trasformandosi in sgomento quando si accorge della piega che gli eventi (come Azucena aveva previsto) vanno prendendo.
Manrico e Leonora si investono nelle rispettive parti, fino a liberarsi del copione e procedere con dichiarazioni infiammate.
La tensione cresce in modo indescrivibile: siamo tutti dalla parte del povero conte, che beve, si dispera, precipita nel baratro, mentre i due - ignorandolo sempre di più - sono al massimo della gioia per questo sentimento a lungo represso e finalmente dichiarato.
Il vertice emozionale (da grande Cerniakov) è l'aria del conte. Lui sul divano al proscenio canta il suo amore disperato (seduti al suo fianco, Azucena mantiene un sorriso sprezzante e Ferrando si asciuga il sudore); dietro di loro, nell'altra stanza, Manrico e Leonora si baciano avidamente.
E quanto parte il valzerone di "Ma l'amore, l'amore ond'ardo" i due innamorati, lenti e non visti, cominciano a ballare.
Una scena grandiosa.
Azucena trionfa, il Conte esplode, urla la sua disperazione, tenta di fermare il gioco, ma è Manrico che a questo punto ferma lui, mollandogli un paio di ceffoni che fanno precipitare a terra il conte... disperato, distrutto, umilato.
"Ho le furie nel cor" gridato fra i singhiozzi da un conte a terra, mentre Manrico e Leonora si abbracciano davanti a lui è stato il più emozionante che abbia sentito a teatro.
Su questo climax allucinante e sapientemente preparato lungo i due atti, cade il primo intervallo.
Quando riprendiamo posto, capiamo immediatamente cosa è avvenuto nei minuti in cui siamo usciti per fumare.
Il climax insostenibile ha prodotto un effetto che nessuno, nemmeno quella sciocca di Azucena, aveva potuto prevedere.
Nel conte qualcosa si è spezzato: l'umiliazione e il dolore l'hanno fatto esplodere.
Ha sfoderato una pistola, li ha fatti tutti ostaggi e, al limite della pazzia, ha preso in mano il gioco.
Ferrando, il collaboratore di Azucena, tenta di passare dalla parte del nuovo "capo". Verso Azucena non ha ormai che disprezzo: quella vecchia pazza sapeva che Manrico e Leonora si amavano, sapeva quale vaso di pandora stava scoperchiando.
E ha esposto tutti (lui compreso) a questa situazione.
Azucena dal canto suo... reagisce alla svolta da quella stupida vecchietta fragile di testa che è.
Schiacciata dal terrore, si rifugia nella storia assurda che aveva inventato... non è più capace di uscirne.
E quando il conte la interroga... lei continua a farneticare di zingari, di biscaglia, di bambini rapiti!
Dalle sue farneticazioni emerge solo l'amore incontrollato per Manrico che, a questo punto, è divenuto (nella sua testa) veramente suo figlio!
Il conte, ridendo sgangheratamente della vecchia pazza, la fa legare da Ferrando e poi si dedicherà a giocare coi due innamorati. "Vi divertivate a recitare all'amore? Ora continuerete per me". Costringe Manrico a cantare "Ah si ben mio", mentre con la pistola guida la mano di Leonora verso di lui.
Manrico, a sua volta atterrito, si lascia comandare a bacchetta, fino a quando sente la povera Azucena (ormai completamente giù di testa) invocare il suo aiuto. A quel punto ha un attimo di ribellione, se la prende con Leonora e si ferma solo di fronte al conte che, per dimostrargli la sua determinazione, ammazza Ferrando.
Manrico, legato, viene chiuso in uno sgabuzzino. Leonora, allo stremo delle forze, si offre al conte di tornare con lui se lascia scappare Manrico. Il conte accetta.
Il loro duo (sordido, in mezzo al resto di uno spuntino improvvisato, birra e patatine fritte, e concluso dal loro rapporto sessuale sotto gli occhi di Manrico) è un altro dei momenti forti della serata.
Il finale si avvia alla sua conclusione.
Azucena è ormai completamente impazzita; vive nella sua favola e non ne esce. Cantanto "Ai nostri monti" cammina avanti e indietro, come prigioniera di un altro mondo. Leonora indica a Manrico la via di fuga (la porta finalmente aperta da cui entra la luce del giorno), ma questi non accetta di lasciarla lì col "mostro".
Quest'ultimo si sveglia e la tragedia arriva alla sua conclusione. Manrico viene ucciso da una scarica di proiettili, mentre Azucena (suscitando le risate del conte) urla il suo insensato "Sei vendicata o Madre", che - a questo punto - dà più brividi che nella storia originale.
Perché l'enfasi della musica sottolinea solo la frase senza senso di una povera pazza.
Salutoni,
Mat
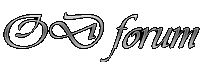
 ,
,  , Ti segnalo che nel 1976 io ancora i giornali non li leggevo e men che meno Isotta (dopo ho cominciato e dopo ancora smesso). Però mi sembra di ricordare che in un libro di quest'ultimo, intitolato se non mi sbaglio "Protagonisti della musica", egli parlasse del Ring del '76 e dicesse di averlo seguito come inviato del Giornale. Ma magari ricordo male: benché non sia ancora così bacucco come te, alla mia età la memoria comincia a fare brutti scherzi...
, Ti segnalo che nel 1976 io ancora i giornali non li leggevo e men che meno Isotta (dopo ho cominciato e dopo ancora smesso). Però mi sembra di ricordare che in un libro di quest'ultimo, intitolato se non mi sbaglio "Protagonisti della musica", egli parlasse del Ring del '76 e dicesse di averlo seguito come inviato del Giornale. Ma magari ricordo male: benché non sia ancora così bacucco come te, alla mia età la memoria comincia a fare brutti scherzi... 