Ebbene, vista la recita del 13 aprile.
Sì, sì... d'accordo. Niente a che fare con gli Ugonotti di Minkowsky, Cutler e la Petersen dell'anno scorso a Bruxelles.
Però io non mi spingo fino alla censura di Beckmesser. "male forte" non è andata affatto, anzi...
Dal mio punto di vista certi aspetti di questa Muette rappresentano un bel passettino avanti nella ridefinizione moderna del Grand-Opéra.
I difetti, ne convengo, ci sono stati e uno di questi era grave: la direzione di Davin.
La rinascita del genere deve passare attraverso una svolta linguistica, come è accaduto nella musica antica o nel Rossini della Renaissance..
Poi si parlerà di contenuti; in questa fase il linguaggio è più importante.
Finché non si elaborerà un nuovo lessico sonoro-figurativo in grado di esaltare la specificità di questo repertorio, ogni speranza di resurrezione è vana.
Patrick Davin non è un cattivo direttore, ma non ha alcuna esperienza di questo repertorio, nè delle sue specificità.
Di fronte alle difficoltà che esso presenta (ad esempio la lunghezza, la qualità della musica, la drammaturgia cappa e spada) reagisce tagliando o assimilando il bandismo della pagine più ruspanti a un Verdi di galera, autore a cui il pubblico è più aduso.
In pratica siamo all'opposto della "svolta creativa" di cui parlavamo: con Davin ricadiamo nel "tagliare il difficile" e omologare il resto alle vecchie abitudini.
E' come se tornassimo agli anni '60, con gli Ugonotti (alla Scala) e il Roberto il Diavolo (a Firenze).
Come Minkowski ha dimostrato a Berlino e a Bruxelles, per ridare vita a questo repertorio occorre risolverne le "difficoltà": non eluderle, snaturarle o ...tagliarle, ma scervellarcisi sopra fino a che non le si è rese moderne, vere, bellissime.
E se in quella musica ci sono forme musicali, armonie, suoni che oggi ci paiono vecchi e ridicoli... se ci sono lungaggini e ingenuità, be' sarà proprio tutto questo a meritare più riflessione da parte del direttore...
Davin non è la risposta giusta (meno ancora lo sarà Daniel Oren, l'anno prossimo a Londra).
L'altro buco nero dello spettacolo è stato il "ruolo Cinti", perno dell'architettura scribiana e contraltare del "ruolo Nourrit".
Nella mia recita la Gutierrez non è stata annunciata malata, non di meno è riuscita a steccare qualche acuto.
Ha imbroccato qualche pianissimo, ha compitato decentemente agilità e picchettati, si è impegnata anche scenicamente (considerato che la Dante non ha ancora imparato a muovere i solisti), nondimeno non ha nulla di un ruolo Cinti.
Su tutt'altro livello il ruolo Nourrit, qui affidato a Michael Spyres che, piaccia o non piaccia, merita un posto fra i nourrittiani del nostro tempo.
Spyres non è nuovo a questo repertorio: dopo aver affrontato Raoul, Arnould e Néocles, si cimenta ora con Masaniello ed è in attesa - pare - di approdare a Heleazar, Amenophis, il Comte Ory e Robert le Diable.
Come era prevedibile, l'estensione e il vocalismo non temono gli spericolati scogli della scrittura. La sua bella e timbratissima voce veleggia per tre ottave di esensione, sciorina agilità, mezzevoci e falsetti anche ad alta quota, il tutto con solidità ritmica e notevole musicalità.
Inoltre, proseguendo sul cammino di Merritt, Spyres accentua nel medium coloriti nettamente baritonali, che gli consentono impressionanti contrasti col registro sopracuto. L'effetto si sposa alla tesi - da noi lungamente difesa - di una vocalità Nourrit più scura e centralizzante di come siamo soliti sentirla, alternata a scalate alla stratosfera in falsetto (che a Spyres viene benissimo... quando gli viene).
Peccato che tenda a osare troppo, dando per scontato che - date le difficoltà a cui si espone - il pubblico debba accettare di buon grado una serie di scivoloni francamente troppo frequenti: non mancano le filature rotte, i sopracuti incerti, fiati talmente lunghi da lasciarlo in debito di ossigeno (e di intonazione)...
Basterebbe un po' meno di esibizionismo e molti di questi problemi potrebbero essere evitati.
Sul piano interpretativo non si può dire che il tenore passi inosservato: anche se la sua istintiva eloquenza sfiora talvolta la cialtroneria, non c'è dubbio che Spyres sappia attirare l'attenzione su di sè e su quel che dice. E questo è un bene: un interprete Nourrit "deve" essere accentratore: poi si potrà discutere sul valore dei suoi argomenti, ma per prima cosa deve sapersi far ascoltare.
Il suo limite è la sfrontatezza guitta e popolaresca (da posteggiatore di buon cuore) che non pare adeguata alla statura intellettuale dei ruoli Nourrit, al loro romanticismo tempestoso e tragico.
I personaggi Nourrit, siano essi monarchi, cavalieri e letterati, oppure popolani o vecchi ebrei, non possono prescindere dalla loro congenita grandezza. E infatti anche Masaniello sarà anche un bandito circondato da Lazzaroni, ma interpretato da Spyres perde l'autorità del grande leader insurrezionale, la pietà di chi sa piangere sulla morte dei propri nemici o la lacerazione di chi assume su di sè il peso di una tragedia storica.
La difesa dell'ospite e il duettone dell'"Amour sacré de la Patrie" sembrano con lui un affare da bulletti.
Quanto poi ai patetici tentativi (voluti dalla Dante) di far crollare mentelmante il personaggio con risate dementi, sono pura comicità involontaria (così come la scena di pazzia... dove esibisce la sua tristissima nudità).
Fra gli altri interpreti, occorre ricordare la ballerina Elena Borgogni, Fenella accentratrice e appassionante (oltre che dalla resistenza fisica incredibile).
Maxim Mironov in Alphonse poteva essere un gran lusso in questa produzione, ma nulla si è fatto per valorizzarlo.
Infine Laurent Alvaro (grande voce da basso profondo) appare in grosse difficoltà a sostenere una tessitura "Dabadie", troppo acuta per lui.
Resta il caso di Emma Dante, la cui Muta non entrerà nel guinnes delle regie più belle della storia, ma segna un nettissimo passo in avanti (tecnico e poetico) rispetto a Carmen e soprattutto rappresenta un importante contributo nella conquista di un nuovo linguaggio per il Grand Opéra.
E' pur vero che la scarsa esperienza operistica della Dante si fa sentire: ad esempio nella difficoltà di emancipare i solisti dallo stereotipo della gestualità melodrammatica, o nel ricorso (che fa molto anni '80) del simbolone "grande così" che sovrasta un palco quasi vuoto (i quadri e il lampadario che scendono per evocare ambienti aristocratici, i tendaggi di lino che invece evocano le spiagge dei pescatori, le onnipresenti porte su ruote).
Altro grosso limite (almeno per il pubblico di oggi) è l'ingenuità del progetto poetico: la solita critica all'ipocrisia del potere contrapposto all'infelicità e alla naturalezza degli umili...
E tuttavia non era questo che ci si aspettava da lei.
Da lei, proprio in virtù della sua singolare esperienza registica e dell'uso spregiudicato della corporeità sviluppato in tanti spettacoli choccanti, ci attendevamo stimoli diversi, eterodossi: proprio ciò di cui abbiamo bisogno per inventarci un'immagine moderna e plausibile del Grand-Opera.
Intanto il personaggio di Fenella (difficilissimo) ha trovato con lei un "gesto" di assoluta efficacia: una mobilità selvaggia, un agitarsi animalesco, istintivo; da chi la aggredisce o la sfotte, Fenella si difende graffiando, sputando, scalciando. Lotta con la vioenza primitiva di una handicappata, abituata a lottare prima ancora di capire cosa sta succedendo.

All'emotività di questo gesticolare arcaico e ferino è stata contrapposta la gestualità altrettanto straordinaria nei mimi-ballerini della compagnia della Dante (impegnati quali soldati del Vicerè). Cattivi, certo, violenti: una decina di energumeni-acrobati da profondo Sud, che provocano, aggrediscono, espongono la loro virilità, ma in modo che non li rende odiosi; anche loro devono adeguarsi alle "regole" di una società che della preistoria ha conservato la necessità della violenza.
Con i loro balli - che incredibilmente si fondono a una musica tanto salottiera - conferiscono un'intensità nuova, moderna a tutta la narrazione.
Questo contributo "coreutico" sarebbe già di per sè una vittoria, anche se la Dante non fosse riuscita a fonderlo al resto.
In realtà spesso c'è riuscita.
Ad esempio la grande aria di sortita di Elvira (risolta in un grande minuetto con la protagonista al centro e i soldati spagnoli attorno a lei, che danzano con bambole di ceramica vestite da aristocratici) trasformava il palcoscenico in un impressionante carillon.
Toccante (oltre che ottimo esempio di "regia musicale") è stata - alla fine del terzo atto - la prière a cappella, dopo che i soldati spagnoli (in una sorta di attacco epilettico) sono caduti a terra morti: avvolta da una luce misteriosa, Fenella cammina in mezzo ai cadaveri dei "nemici" (che a questo punto sono solo vittime, in puro spirito alla Scribe), ne accarezza il volto, ne chiude gli occhi.
Spunti di questo tipo sono stati frequenti (a differenza della Carmen), anche se - obbiettivamente - non sufficienti a tenere in piedi il quarto e il quinto atto. Il progetto drammaturgico e poetico restava troppo fragile.
E tuttavia gli elementi migliori dello spettacolo e soprattutto la relazione scoperta fra questa musica da feuilletton storico e l'impeto rurale e primitivo del ballo meritano di entrare nel vocabolario del rinato Grand-Opéra.
Salutoni,
Mat
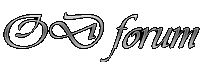
 Certo è che la
Certo è che la 
 !
!