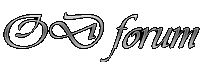Questo Falstaff ha avuto alla prima, in sala, un successo pieno, prolungato e senza ombre con applausi all’intero cast, al direttore e, particolarmente intensi, a Robert Carsen ed al suo team. Parlando con i singoli si riscontravano, invece, fasce differenti di gradimento. Premesso che il gradimento di chi qui scrive è stato alto e dovuto in primo luogo alla “compattezza” complessiva di tutta la proposta, allestimento e musica, proverò a dire la mia.
Questo Falstaff può deludere chi da Robert Carsen si aspetti, ad ogni occasione, la “novità” o il messaggio illuminante. Le garbatissime note di regia disponibili sul programma di sala e sul sito della Scala suggerivano una visione chiara, fondamentalmente semplice, non “sovrapposta” all’opera. La trasposizione in un Inghilterra, diciamo così, protonovecentesca, tocca pochissimo o nulla della vicenda: è Falstaff, letto in maniera ironica, affettuosa, garbata e fondamentalmente sorridente: una lettura scenica nella quale convivono un richiamo all’opera buffa italiana (la recitazione di Mrs Quickly e di Ford, e la scelta, non casuale, di cantanti-interpreti quali Barcellona e Capitanucci, legati a quella scuola) della quale Falstaff è (una fra le mille sfaccettature di un’opera che sfugge alle definizioni) come l’estrema appendice; e l’ambientazione “inglese” che porta a tutta una serie di immagini, di costumi, di modi di esserre. A partire dal divario fra il “gentiluomo” (con tutti i suoi difetti) Falstaff e il più “grossier” Ford: un tema sul quale le note di Carsen – e la realizzazione – sono chiare, divertenti ed esaustive.
La tavola e il cibo sono situazioni di vita nel quale l’essere umano è più autentico. In vino veritas, a tavola si sorride, si vive, si dicono verità o magari ci si racconta qualche bugia: le CORNA – tema fondamentale di Falstaff, che Carsen individua benissimo: alla fine restano in scena, al buio, solo loro, sono il simbolo dell’umanità, quale Verdi ce la propone, quale Falstaff – riflettendo sul mondo e su se stesso – ce la dichiara alla fine dell’opera, con un certo grado di “spleen” (la malinconia nella quale annegano – fra vino e cibo – lo scherzo e la farsa) e con una sostanziale comprensione per il limite della natura umana.
Questo “clima” è stato reso benissimo da Carsen con la recitazione, il “buffo” italiano innestato sull’”inglesità” dell’immagine complessiva: tutta la compagnia ha assorbito e reso bene la “lezione”, in testa a tutti la straordinaria Daniela Barcellona, ma anche lo stesso protagonista, un Ambrogio Maestri-Falstaff ovviamente “identificato” nel personaggio sul piano fisico: vocalità italiana in abito british (Maestri porta alla grande la giubba rossa da caccia alla volpe!). Cito Barcellona e Maestri non a caso perché un’intuizione geniale è stata, qui, la ripetuta identificazione fra Falstaff e Quickly, aiutata sicuramente dalle fisionomie in qualche modo “coincidenti” degli interpreti: l’alta, imponente Barcellona è strepitosa nell’autoironia con la quale gioca in scena con la proria statura e il fisico prorompente e in quella “reverenza” pare davvero che Quickly e Falstaff (anche lei nelle strepitosa cucina dell’atto 2° dà esilarante prova di gradimento del cibo) si identifichino come esponenti di un fondamentale “ben vivere”. Lo “specchio” reciproco fra Quickly e Falstaff si ripete, dopo il bagno di lui nel Tamigi, quando, all’inizio del terz’atto, l’immalinconito, fradicio, ma sempre “filosofo” Sir John, dopo aver esternato le proprie riflessioni di vita… ad un cavallo intento – la testa fuori dal suo box – a mangiare il suo fieno (fra il cavallo, attore strepitoso, e Maestri c’è un evidente feeling: il cantante lo aveva preannunciato nelle interviste di vigilia), riceve l’ulteriore visita di Quickly, che si presenta (altra delizia di Carsen!) vestita da Regina Elisabetta in tenuta equestre: tal quale, fazzolettone e stivaloni. Dal calore del legno della casa, del club, della sala risorante del primo atto (si mangia, quasi ininterrottamente), alla luce abbagliante della cucina di design d’epoca nella quale (con strepitoso caos organizzato) si realizza lo scherzo della cesta, Carsen immette, dall’inizio nel terz’atto nella magia della notte, dalla quale, alla fine , la luce tornerà, anche in sala quando tutti – in scena come in platea – ci ritroveremo “gabbati”, sì, ma anche fratelli in umanità.
Si dirà: ma questo è Falstaff, non c’è niente di nuovo. Va bene, ma – e consiglio ancora di leggere le note di Carsen – non è il “nuovo” a tutti i costi che il regista ha cercato. Quanto la fedeltà “nella” trasposizione: obiettivi a mio avviso centrati benissimo, con considerevole diletto di chi guarda. Che poi, in questo Falstaff, non si respiri un’aura “padana” (ma Maestri e gli altri interpreti vegliano a questo) è un appunto che ho sentito muovere: però torniamo ad un vecchio discorso, non si può “pretendere” da un interprete (in questo caso, il regista) l’aderenza al “modello” che ciascuno di noi ha di un’opera.
La compagnia ha il pregio primo della compattezza. Ribadito che la formidabile Barcellona-Quickly ne è, a mio avviso, la “punta”, è possibile che questa “prima” non abbia colto Ambrogio Maestri nella miglior forma vocale. Ne hanno fatto le spese le parti in “falsetto”: ciò non toglie che la sua aderenza “totale” al ruolo lo renda degno di ammirazione e applauso: e – grande Carsen – “Quando ero paggio” con cosciotto di tacchino in mano, nonchè il “dialogo” con il cavallo colgono in Maestri un “vero” Falstaff. Gli altri su buon livello, Ford impegna forse al limite Capitanucci, che è peraltro strepitoso nell’aderenza scenica alla figura “grossier” voluta dal regista. L’Alice della Giannattasio ha bel timbro, “pieno”, è forse un filo meno precisa “sulla parola” rispetto ai compagni di viaggio. Bene i due ragazzi, in particolare il Fenton di Demuro. Al di là delle qualità – o limiti – soggettivi,si coglie in tutti – ed è merito non da poco – l’adesione ad un progetto scenico-musicale.
La direzione di Daniel Harding si inserisce dialetticamente nel contesto. Ho letto e sentito affermazioni contraddittorie: c’è chi ha trovato la direzione “lenta” chi “vorticosa”. A mio parere è né l’una né l’altra cosa, o meglio è entrambe: ovvero, può essere rapido o posato, ma sempre secondo esigenza drammatica. (la problematica dei tempi in Falstaff vanta esempi di vario genere: si pensi a quello “lento” di Giulini). Di migliorabile (ma era la prima: andrà riascoltato nelle repliche) c’era qualche sincronia nei – peraltro difficilissimi: è uno degli ostacoli da superare, in Falstaff – concertati a tempo doppio, o “sfasato” . Ma è il primo Falstaff di un direttore – di grande valore – poco più che trentenne. E, tanto per cominciare: ogni esecuzione di Daniel Harding è, comunque, come minimo, “segnata” dalla scintilla dell’intelligenza e dello studio, e questo Falstaff non fa eccezione. Harding è ancor giovane e (come da lui stesso dichiarato, ricordando colloqui con Abbado sull’argomento) Falstaff è opera da far tremare i polsi. Una certa cautela d’approccio (destinata a sciogliersi, penso, nelle recite) si coglie e non va a demerito del direttore: Falstaff, a trenta e rotti anni (saranno 38 in agosto, mi risulta), non si affronta con incoscienza, semmai con rispetto. Ma il concertatore Daniel Harding ha fin d’ora, in Falstaff, frecce ottime a disposizione. Il suono, innanzi tutto, anzi due suoni: caustico, appuntito, tutto in rilievo nei primi due atti, che disegnano un Falstaff quasi “novecentesco”, con formidabili sortite dei solisti scaligeri, non una delle quali – va detto – è separata dalla parola e dall’esigenza scenica. A questo proposito: dalla galleria – e ripeto dalla galleria – non si perde una parola: impressioni di amici (di provata competenza) dalla platea erano differenti, ma qui entra in gioco l’acustica scaligera sconvolta dal(la)… Botta ristrutturatrice. Messaggio ai critici: bene fareste a non ascoltare più le opere dalle poltrone di platea. Io mi ci ero abbonato fino a un paio d’anni or sono, sono felicemente tornato ai piani superiori, gli unici dai quali si ascolti in maniera soddisfacente.
Dicevo dei due suoni di Harding: dal caustico-duro-cristallino (e travolgente nella scansione del finale 2) dei primi due atti, il direttore ci immerge (in piena consonanza con quanto avviene in scena) nello “spleen” e nella notte del terzo atto. C’è un momento chiave di trapasso d’atmosfera, stupendamente colto e realizzato da Harding: allorché Quickly (seguita da Alice) intona “Quando il rintocco della mezzanotte” , Harding tiene rilevatissimo, quasi spettrale l’accompagnamento di corno, dando vita ad un impressionante clima di minaccia (giustissimo, in quel momento) che immerge l’opera e noi nella “notte” conclusiva e risolutiva. Altra meraviglia di Harding: la leggerezza volante dell’orchestra nel concertato finale, un velluto baluginante nel quale al direttore non sembra interessare tanto l’esattezza meccanica quanto il “colore”, il “clima”, di questa finale “dichiarazione” d’umanità in cui lo scherzo si scioglie in comprensione, salvo poi… Carsen lasciare in scena solo le corna (prima portate mirabilmente da Maestri: la sua apparizione cornuta sullo sfondo del nero cielo stellato è memorabile); e Harding chiudere con il ritorno, proprio alle ultime battute, del suono “acido-caustico” (c’è, molto in rilievo, il famoso colpo di piatti): direttore e regista – e Verdi – ci lasciano con amore per l’umanità, non senza il “marameo” d’uno sberleffo conclusivo. La vita, in fondo, è un fatto di corna.
marco vizzardelli
Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Moderatori: DocFlipperino, DottorMalatesta, Maugham
14 messaggi
• Pagina 1 di 1
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Si è trattato di un Falstaff deludente a cominciare dalla direzione.
Harding è caduto anche lui nella trappola del sinfonismo applicato al tardoverdi; equivoco micidiale che -la discografia lo dimostra- ha tarpato le ali a edizioni che come questa promettevano meraviglie. Vedi Jurovsky a Glyndebourne o lo stesso Abbado. Abbiamo quindi ascoltato una bella prova di calligrafia musicale, a volte originale e a volte no, ma che quasi mai è riuscita a dialogare con il palcoscenico.
Mi spiego meglio.
La struttura orchestrale (e soprattutto ritmica) del Falstaff non è un esercizio di stile; Verdi da vecchio non voleva fare il primo della classe; ogni soluzione agogica di questa partitura, ogni trovata dinamica per quanto originale e curiosa sia, ha una sua precisa giustificazione legata a quanto succede sul palcoscenico. Possiamo dire che il passo orchestrale nel Falstaff -e in pochissime altre opere- coincide al 99% con il passo teatrale. Non si può prescindere da questo rapporto strettissimo; altrimenti tutto si sgonfia e perde significato.
Le meraviglie dell'orchestra del Falstaff non sono "belle di per sè", ma sono belle in quanto significanti di un preciso momento teatrale.
E questo Harding forse l'ha capito ma non è riuscito a trasmetterlo.
Esempi se ne posso fare tanti; ne bastano due.
La gavotta che prepara l'uscita di Ford e Falstaff nel I quadro del II atto. Non è un valzerone del Rosenkavalier nè un riscrittura settecentesca di Respighi. E' una miniatura, uno sberleffo femmineo e capriccioso di Verdi che prende per il culo due presunti maschi-alfa persi in moine settecentesche. Che senso ha sottolineare i rubati, insistere sulle dinamiche, magnificare il legato (lo sappiamo che sei bravo, ma pure noi siamo bravi a capire i dettagli anche senza l'evidenziatore ) che senso ha tutto questo se poi copri le voci, le costringi a scegliere ritmiche faticose e quindi sgonfi il momento teatrale?
) che senso ha tutto questo se poi copri le voci, le costringi a scegliere ritmiche faticose e quindi sgonfi il momento teatrale?
Cosa simile nel Finale II.
Qui il direttore dovrebbe diventare un automa, scomparire come interprete e scatenarsi solo come micidiale macchina ritmica; Harding invece, nel tantativo di mettere in evidenza tutto, di sottolineare anche il più remoto inciso dei legni, il controcanto più nascosto delle viole ha sgonfiato tutto. Al punto che il "patatrac" finale era lento, arrivato troppo tardi, quasi -come si dice in gergo- "telefonato".
A questo si è aggiunta una strana mancanza di tecnica nella gestione del palcoscenico. In molti momenti le voci erano fuori tempo. Capitanucci poi, nel monologo delle corna, ha rischiato di perdersi per strada.
Non a caso Harding ha firmato una sensazionale fuga finale. Guarda un po' l'unico pezzo chiuso dell'opera dove il suo innegabile virtuosismo ha trovato sfogo. E ci ha fatto dimenticare un monologo dell'onore tra i più sfilacciati che mi sia mai capitato di sentire.
Si è trattato di un Falstaff deludente anche per la regia.
Già d'oltremanica erano arrivate notizie non proprio incoraggianti; dobbiamo ammettere che non avevano tutti i torti.
E' un Falstaff tutto costruito su due poli-ossessione; il cibo e la differenza di classe. Già qui ci sarebbe qualcosa da obiettare; non mi pare che questi elementi -senza dubbio presenti- siano così fondamentali per la drammaturgia dell'opera. Lo sono, è vero, nelle Comari di Shakespeare; ma il Falstaff di Boito è un altra cosa.
Comunque, non è questo il punto.
Il fatto è che questo Falstaff traboccava di tutti i luoghi comuni e le buffonate dei Falstaff di tradizione però in un'ambientazione curiosa anche se non originale (Jones l'aveva ambientata pochi anni prima).
Falstaff era il solito ciccione simpatico/antipatico, la cui pancia si blocca contro quello di Ford quando devono uscire dalla porta e rimangono incastrati (roba da film con Carotenuto e la Fenech), che tenta di stuprare Alice sul tavolo della cucina (roba da film con Carotenuto e la Fenech), che durante il "quando ero paggio" affetta un tacchino con due fettine per Alice e per lui -ciccione simpatico e mangione- una cosciona intera (roba da film con Carotenuto e la Fenech)... a parte questo nient'altro di più o di meno di quanto abbiamo sempre visto nella caratterizzazione del personaggio.
Micidiale poi la scena con Quickly: Carsen la vede come una milfona in calore e Falstaff un laido vecchiaccio che ama farsi sedurre; non mi pare che il "reverenza" abbia delle finalità piccanti o dei sottotesti maliziosi. E nemmeno vedo nessuna ragione nè teatrale nè drammaturgica per suggerire una qualche finalità seduttiva da parte di Quickly nei confronti del Cavaliere. Mah.
Il fondo però lo si tocca nel Finale. Tutti fanno una passerella camminando su un tavolo da pranzo perpendicolare al proscenio e poi, seguendo il consiglio di Ford, tutti a cena.
Ma sapete cosa succede durante le ultime battute delle fuga? Io non volevo crederci. Si accendono le luci e al "Tutti Gabbati" i cantanti prima e Falstaff poi con il ditino indicano il pubblico nella sala illuminata. Nooooooo! Carsen?
Carsen?  Carsen che svacca in questa maniera? Ormai visto anche nel Falstaff dell'oratorio.
Carsen che svacca in questa maniera? Ormai visto anche nel Falstaff dell'oratorio.
Vabbè.
Comunque belle luci, una caciara meravigliosamente orchestrata ma anche meravigliosamente inutile nel finale II (perchè per cercare Falstaff i signori spaccano tutti i piatti della cucina, lanciano le tazze e rovesciano gli scaffali?), piccole scorciatoie da Michieletto e non da Carsen nelle scene Fenton/Nannetta (sospensione della scena, tutti fermi tipo un-due-tre per le vie di Roma, e luce blu mentre i giovani amanti amoreggiano) e un cavallo in scena durante il monologo del III atto. Nemmeno Zeffirelli ce l'aveva messo.
Bravissimo Maestri. Forse l'unica autentica ragione d'interesse di questo Falstaff. Dizione perfetta, ritmica eccellente, acuti tonanti. Qualche difficoltà nelle tessiture alte da affrontare a mezza voce (alfin t'ho colto raggiante fior...) non hanno comunque scalfito una prova ottima sia a livello vocale che interpretativo. Soprattutto era l'unico del cast a capire come articolare sotto il profilo ritmico una frase senza cantarsi addosso.
Nella scena con Capitanucci -purtroppo a disagio proprio nel ritmo- Maestri lo sosteneva con micidiale mestiere.
Le migliori tra le donne erano la Barcellona e la Lungu.
Successone.
WSM
Harding è caduto anche lui nella trappola del sinfonismo applicato al tardoverdi; equivoco micidiale che -la discografia lo dimostra- ha tarpato le ali a edizioni che come questa promettevano meraviglie. Vedi Jurovsky a Glyndebourne o lo stesso Abbado. Abbiamo quindi ascoltato una bella prova di calligrafia musicale, a volte originale e a volte no, ma che quasi mai è riuscita a dialogare con il palcoscenico.
Mi spiego meglio.
La struttura orchestrale (e soprattutto ritmica) del Falstaff non è un esercizio di stile; Verdi da vecchio non voleva fare il primo della classe; ogni soluzione agogica di questa partitura, ogni trovata dinamica per quanto originale e curiosa sia, ha una sua precisa giustificazione legata a quanto succede sul palcoscenico. Possiamo dire che il passo orchestrale nel Falstaff -e in pochissime altre opere- coincide al 99% con il passo teatrale. Non si può prescindere da questo rapporto strettissimo; altrimenti tutto si sgonfia e perde significato.
Le meraviglie dell'orchestra del Falstaff non sono "belle di per sè", ma sono belle in quanto significanti di un preciso momento teatrale.
E questo Harding forse l'ha capito ma non è riuscito a trasmetterlo.
Esempi se ne posso fare tanti; ne bastano due.
La gavotta che prepara l'uscita di Ford e Falstaff nel I quadro del II atto. Non è un valzerone del Rosenkavalier nè un riscrittura settecentesca di Respighi. E' una miniatura, uno sberleffo femmineo e capriccioso di Verdi che prende per il culo due presunti maschi-alfa persi in moine settecentesche. Che senso ha sottolineare i rubati, insistere sulle dinamiche, magnificare il legato (lo sappiamo che sei bravo, ma pure noi siamo bravi a capire i dettagli anche senza l'evidenziatore
Cosa simile nel Finale II.
Qui il direttore dovrebbe diventare un automa, scomparire come interprete e scatenarsi solo come micidiale macchina ritmica; Harding invece, nel tantativo di mettere in evidenza tutto, di sottolineare anche il più remoto inciso dei legni, il controcanto più nascosto delle viole ha sgonfiato tutto. Al punto che il "patatrac" finale era lento, arrivato troppo tardi, quasi -come si dice in gergo- "telefonato".
A questo si è aggiunta una strana mancanza di tecnica nella gestione del palcoscenico. In molti momenti le voci erano fuori tempo. Capitanucci poi, nel monologo delle corna, ha rischiato di perdersi per strada.
Non a caso Harding ha firmato una sensazionale fuga finale. Guarda un po' l'unico pezzo chiuso dell'opera dove il suo innegabile virtuosismo ha trovato sfogo. E ci ha fatto dimenticare un monologo dell'onore tra i più sfilacciati che mi sia mai capitato di sentire.
Si è trattato di un Falstaff deludente anche per la regia.
Già d'oltremanica erano arrivate notizie non proprio incoraggianti; dobbiamo ammettere che non avevano tutti i torti.
E' un Falstaff tutto costruito su due poli-ossessione; il cibo e la differenza di classe. Già qui ci sarebbe qualcosa da obiettare; non mi pare che questi elementi -senza dubbio presenti- siano così fondamentali per la drammaturgia dell'opera. Lo sono, è vero, nelle Comari di Shakespeare; ma il Falstaff di Boito è un altra cosa.
Comunque, non è questo il punto.
Il fatto è che questo Falstaff traboccava di tutti i luoghi comuni e le buffonate dei Falstaff di tradizione però in un'ambientazione curiosa anche se non originale (Jones l'aveva ambientata pochi anni prima).
Falstaff era il solito ciccione simpatico/antipatico, la cui pancia si blocca contro quello di Ford quando devono uscire dalla porta e rimangono incastrati (roba da film con Carotenuto e la Fenech), che tenta di stuprare Alice sul tavolo della cucina (roba da film con Carotenuto e la Fenech), che durante il "quando ero paggio" affetta un tacchino con due fettine per Alice e per lui -ciccione simpatico e mangione- una cosciona intera (roba da film con Carotenuto e la Fenech)... a parte questo nient'altro di più o di meno di quanto abbiamo sempre visto nella caratterizzazione del personaggio.
Micidiale poi la scena con Quickly: Carsen la vede come una milfona in calore e Falstaff un laido vecchiaccio che ama farsi sedurre; non mi pare che il "reverenza" abbia delle finalità piccanti o dei sottotesti maliziosi. E nemmeno vedo nessuna ragione nè teatrale nè drammaturgica per suggerire una qualche finalità seduttiva da parte di Quickly nei confronti del Cavaliere. Mah.
Il fondo però lo si tocca nel Finale. Tutti fanno una passerella camminando su un tavolo da pranzo perpendicolare al proscenio e poi, seguendo il consiglio di Ford, tutti a cena.
Ma sapete cosa succede durante le ultime battute delle fuga? Io non volevo crederci. Si accendono le luci e al "Tutti Gabbati" i cantanti prima e Falstaff poi con il ditino indicano il pubblico nella sala illuminata. Nooooooo!
Vabbè.
Comunque belle luci, una caciara meravigliosamente orchestrata ma anche meravigliosamente inutile nel finale II (perchè per cercare Falstaff i signori spaccano tutti i piatti della cucina, lanciano le tazze e rovesciano gli scaffali?), piccole scorciatoie da Michieletto e non da Carsen nelle scene Fenton/Nannetta (sospensione della scena, tutti fermi tipo un-due-tre per le vie di Roma, e luce blu mentre i giovani amanti amoreggiano) e un cavallo in scena durante il monologo del III atto. Nemmeno Zeffirelli ce l'aveva messo.
Bravissimo Maestri. Forse l'unica autentica ragione d'interesse di questo Falstaff. Dizione perfetta, ritmica eccellente, acuti tonanti. Qualche difficoltà nelle tessiture alte da affrontare a mezza voce (alfin t'ho colto raggiante fior...) non hanno comunque scalfito una prova ottima sia a livello vocale che interpretativo. Soprattutto era l'unico del cast a capire come articolare sotto il profilo ritmico una frase senza cantarsi addosso.
Nella scena con Capitanucci -purtroppo a disagio proprio nel ritmo- Maestri lo sosteneva con micidiale mestiere.
Le migliori tra le donne erano la Barcellona e la Lungu.
Successone.
WSM
Mae West: We're intellectual opposites.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
-

Maugham - Site Admin
- Messaggi: 1331
- Iscritto il: gio 31 gen 2008, 19:04
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Beh, miei cari, mettetevi d'accordo. Oppure (meglio) litigate.
Sangue vuolsi!
AM
PS: però, Divino, il cavallo nel Falstaff Zeffirelli ce l'ha messo! Ci arrivava sopra Alice nel terz'atto...
Sangue vuolsi!
AM
PS: però, Divino, il cavallo nel Falstaff Zeffirelli ce l'ha messo! Ci arrivava sopra Alice nel terz'atto...

Twitter: @MattioliAlberto
- mattioli
- Messaggi: 1100
- Iscritto il: mer 09 dic 2009, 19:09
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Se il Divino boccia il Falstaff scaligero (che almeno sulla carta é l´unico spettacolo scaligero verdiano con un po´ di sex appeal) c´é davvero da piangere!

Ciao!
DM

Ciao!
DM
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
mattioli ha scritto:
PS: però, Divino, il cavallo nel Falstaff Zeffirelli ce l'ha messo! Ci arrivava sopra Alice nel terz'atto...
Nello spettacolo del Met? La Freni a cavallo?
WSM
Mae West: We're intellectual opposites.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
-

Maugham - Site Admin
- Messaggi: 1331
- Iscritto il: gio 31 gen 2008, 19:04
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
DottorMalatesta ha scritto:Se il Divino boccia il Falstaff scaligero (che almeno sulla carta é l´unico spettacolo scaligero verdiano con un po´ di sex appeal) c´é davvero da piangere!

Ciao!
DM
Però non è che a Londra avessero gridato al miracolo. Secondo me Carsen certi titoli non li sente. La sua cultura mainstream (favolosa, magica e entusiasmante quando applicata a certi titoli) mostra la corda con quelli verdiani. Ammetto però di aver visto -oltre a Falstaff- solo Traviata e Trovatore... e non mi hanno entusiasmato.
Anche Harding aveva già fatto un'interlocutoria Traviata ad Aix.
WSM
Mae West: We're intellectual opposites.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
-

Maugham - Site Admin
- Messaggi: 1331
- Iscritto il: gio 31 gen 2008, 19:04
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Mi sapete dire se si tratta di una nuova edizione (in coproduzione con Londra) o se è un riallestimento di una edizione precedente (se non ricordo male Carsen ha giá diretto in passato un Falstaff?).
A (parziale) attenuante per Carsen il fatto che, IMHO, Falstaff è opera insidiosissima per il regista. Difficile non “svaccare”. Sempre IMHO ho dovuto aspettare la rivelazione dello spettacolo di Jones prima di trovare un Falstaff davvero convincente (eppure anche in questo caso gli animi si divisero, basta ricordare quanto scrissero il sempre-ottimo Mattioli da una parte e lo spesso-ottimo Giudici dall´altra… ).
).
Ciao!
DM
P.S.: By the way, anch´io proprio non mi so spiegare perché il “reverenza” di Quickley sia occasione di gigionate gratuite a sfondo erotizzante…

A (parziale) attenuante per Carsen il fatto che, IMHO, Falstaff è opera insidiosissima per il regista. Difficile non “svaccare”. Sempre IMHO ho dovuto aspettare la rivelazione dello spettacolo di Jones prima di trovare un Falstaff davvero convincente (eppure anche in questo caso gli animi si divisero, basta ricordare quanto scrissero il sempre-ottimo Mattioli da una parte e lo spesso-ottimo Giudici dall´altra…
Ciao!
DM
P.S.: By the way, anch´io proprio non mi so spiegare perché il “reverenza” di Quickley sia occasione di gigionate gratuite a sfondo erotizzante…
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Dunque, sembra che Carsen abbia diretto il Falstaff di Verdi nel 1997 a Colonia.
All'epoca ero un adolescente e, per quanto amassi già l'opera, ero perso dietro al gonnellino di una che amava... l'hip hop
Però forse l'onnipresente, onniscente e ubiquitario Mattioli era presente (non fosse altro "pel piacer di porle in lista"! o se non lui... qualche altro wanderer
o se non lui... qualche altro wanderer  ) e ci sa riferire se la zeffirellata scaligera di cui parla Maugham è espressione di demenza incipiente o era già un errore di gioventù...
) e ci sa riferire se la zeffirellata scaligera di cui parla Maugham è espressione di demenza incipiente o era già un errore di gioventù...

Ciao!
DM
All'epoca ero un adolescente e, per quanto amassi già l'opera, ero perso dietro al gonnellino di una che amava... l'hip hop
Però forse l'onnipresente, onniscente e ubiquitario Mattioli era presente (non fosse altro "pel piacer di porle in lista"!

Ciao!
DM
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
DottorMalatesta ha scritto:wanderer) e ci sa riferire se la zeffirellata scaligera di cui parla Maugham è espressione di demenza incipiente o era già un errore di gioventù...

Ciao!
DM
Frena frena!
Calma con le sintesi veloci.
Non mi sono mai permesso di accusare Carsen di zeffirellismo. Anche perchè non saprei come motivare questa bizzarria.
La mia era solo una battuta (forse riuscita male) circoscritta a un cavallo in scena.
Ancor meno mi permetto di accusare di demenza un genio come Carsen.
Ho detto solo di essere rimasto deluso da questo Falstaff. E ho cercato di motivare il perchè.
Detto questo, a prescindere dal mio parere che conta quel che conta, continuo ad amare incondizionatamente Carsen e a prendere degli aerei -quando posso- per un suo nuovo allestimento.
Altro che zeffirelli e demenza senile o peccati di gioventù.
WSM
Mae West: We're intellectual opposites.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
Ivan: What do you mean?
Mae West: I'm intellectual and you are the opposite.
-

Maugham - Site Admin
- Messaggi: 1331
- Iscritto il: gio 31 gen 2008, 19:04
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Scusami, hai ragione  . Il fatto è che Carsen e Carsen, e da un genio ci si aspetta sempre il massimo (e in effetti anch'io quando posso mi muovo per vedere un suo spettacolo
. Il fatto è che Carsen e Carsen, e da un genio ci si aspetta sempre il massimo (e in effetti anch'io quando posso mi muovo per vedere un suo spettacolo  ). Comunque mi farò un'idea di persona il 2 febbraio.
). Comunque mi farò un'idea di persona il 2 febbraio.
Ciao!
Malatesta
 ). Comunque mi farò un'idea di persona il 2 febbraio.
). Comunque mi farò un'idea di persona il 2 febbraio. Ciao!
Malatesta
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
No, non litigo. Non con Maugham che argomenta, quindi è degno di rispetto e di attenzione, anche laddove, come in questo caso, io non ne condivida le opinioni. Di... nulla, invece, è degno l'articolo su Falstaff sortito sul Corriere della Sera, nel quale - oh, profondità - l'unico accenno "critico" sarebbe la lode a Maestri, concessa IN QUANTO ha imparato la parte di Falstaff con... (l'imbrattacarte del Corriere salta viscidamente l'ostacolo scrivendo "Siciliani"). Più tutta una serie di improperi francamente insultanti dei quali, fossi il Teatro alla Scala, comincerei a pensare di chiedere garbatamente ragione al giornale.
Noi qui ci danniamo ad argomentare, ciascuno secondo il suo gusto e sensibilità. Ma è avvilente che il quotidiano milanese più diffuso, che è un servizio destinato ad un pubblico, insista a fare un pessimo servizio alla musica in particolare e alle cronache di un luogo comunque importante per la città, dando in pasto ai lettori folli elucubrazioni ed esibizioni di personali turbe, amicizie-inimicize, di totale inutilità per chi acquisti e legga il quotidiano. Ad ogni sortita scritta di tale personaggio, il Corriere della Sera dà di sé - scientemente, è da credere - un'immagine di inattendibilità (il peggio, per un giornale), fa del male alla musica ed elude nell'esibizione retribuita di una follia personalistica il suo ruolo di servizio destinato ad un pubblico.
Sarebbe tempo (come è già stato tentato anni fa, invano, con una richiesta firmata da diversi esponenti del mondo del teatro e della musica) che tutto l'ambiente (i teatri, gli artisti fatti oggetto di volta in volta di viscida adulazione o pesanti insulti, i lettori) chiedessero esplicitamente ad un giornale comunque diffuso ed importante un trattamento diverso della materia.
marco vizzardelli
Noi qui ci danniamo ad argomentare, ciascuno secondo il suo gusto e sensibilità. Ma è avvilente che il quotidiano milanese più diffuso, che è un servizio destinato ad un pubblico, insista a fare un pessimo servizio alla musica in particolare e alle cronache di un luogo comunque importante per la città, dando in pasto ai lettori folli elucubrazioni ed esibizioni di personali turbe, amicizie-inimicize, di totale inutilità per chi acquisti e legga il quotidiano. Ad ogni sortita scritta di tale personaggio, il Corriere della Sera dà di sé - scientemente, è da credere - un'immagine di inattendibilità (il peggio, per un giornale), fa del male alla musica ed elude nell'esibizione retribuita di una follia personalistica il suo ruolo di servizio destinato ad un pubblico.
Sarebbe tempo (come è già stato tentato anni fa, invano, con una richiesta firmata da diversi esponenti del mondo del teatro e della musica) che tutto l'ambiente (i teatri, gli artisti fatti oggetto di volta in volta di viscida adulazione o pesanti insulti, i lettori) chiedessero esplicitamente ad un giornale comunque diffuso ed importante un trattamento diverso della materia.
marco vizzardelli
- vivelaboheme
- Messaggi: 292
- Iscritto il: ven 09 dic 2011, 20:08
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
E dire che Mattioli, profetico, l´aveva detto: "Sangue vuolsi"!
Mai peró avrei detto che saremmo arrivati a chiedere il sangue di... un critico musicale!
Ciao,
DM
P.S.: Marco, potresti postare un link all´articolo famigerato del critico criticato?
Mai peró avrei detto che saremmo arrivati a chiedere il sangue di... un critico musicale!
Ciao,
DM
P.S.: Marco, potresti postare un link all´articolo famigerato del critico criticato?
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Ne puoi prendere uno a caso, fra i recenti o meno recenti. Dalla morte della Schwarzkopf a quella di Pavarotti, a... mille altre occasioni. Sempre quella minestra è: gli amici, i nemici, i conoscenti, le devote prosternazioni e gli insulti. Questo articolo su Falstaff non è diverso dagli altri suoi.
Il problema è che il tutto avviene sulla pagina di un quotidiano di massima diffusione milanese e nazionale: questa roba finisce in mano a milioni di potenziali lettori, dei quali i più ignari possono pensare che tale roba sia verità. E non è un bel servizio fatto ai lettori, né alla musica.
La sintesi del problema è questa (che l'attendibilità del giornale ne risulti squalificata, è invece un problema del giornale medesimo, o forse non è sentito come tale, visto che avallano regolarmente il tutto. Contenti loro... echissenefrega dei lettori. Be'....).
marco vizzardelli
Il problema è che il tutto avviene sulla pagina di un quotidiano di massima diffusione milanese e nazionale: questa roba finisce in mano a milioni di potenziali lettori, dei quali i più ignari possono pensare che tale roba sia verità. E non è un bel servizio fatto ai lettori, né alla musica.
La sintesi del problema è questa (che l'attendibilità del giornale ne risulti squalificata, è invece un problema del giornale medesimo, o forse non è sentito come tale, visto che avallano regolarmente il tutto. Contenti loro... echissenefrega dei lettori. Be'....).
marco vizzardelli
Ultima modifica di vivelaboheme il ven 18 gen 2013, 21:43, modificato 1 volta in totale.
- vivelaboheme
- Messaggi: 292
- Iscritto il: ven 09 dic 2011, 20:08
Re: Falstaff-Harding-Carsen-Scala
Concordo appieno, sai come la penso sul personaggio in questione 


Ma che possiamo fare?
Una raccolta firme anche noi di Operadisc?
DM



Ma che possiamo fare?
Una raccolta firme anche noi di Operadisc?
DM
Un solo punto di vista è la vista di un solo punto
-

DottorMalatesta - Moderator
- Messaggi: 2696
- Iscritto il: gio 12 lug 2012, 13:48
14 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti