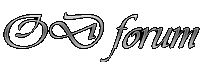Caro Marazzi, scusami se rispondo con molto ritardo. E scusami ancora di più se ho usato un tono un po' brusco, che oltretutto non è il mio abituale. Dunque. Tu dici che l'opera è un insieme di segni che ogni epoca interpreta diversamente, dal momento che essa è una manifestazione umana la cui ricezione non è stabilita una volta per sempre, ma si evolve nel tempo. L'opera naturalmente non invecchia, ma il modo in cui viene proposta sì. Ecco, io sono d'accordo con te sul fatto che l'opera viene interpretata sempre diversamente; in caso contrario, l'invecchiamento e la scomparsa sarebbero il suo destino necessario. Tu però dici qualcosa di più. Vale a dire, che questa diversità di ricezione obbedisce a una dialettica di vecchio e di nuovo, di arroccamento e superamento. Da qui viene naturale dedurre il corollario di una gerarchia di valori; ogni epoca ha una sua interpretazione fondamentale al di fuori della quale sembra non esserci salvezza. Il Settecento di Muti è invecchiato, superato dai vari Jacobs, Gardiner e Minkowsky, ben più aderenti ai valori dell'oggi. Ora, lasciando da parte il rapporto fra questi interpreti, un rapporto la cui valutazione può essere del tutto soggettiva (e questo è bene non dimenticarlo mai, riponendo in un cassetto da non aprire in nessun caso ogni pretesa di verità), è proprio sul problema di fondo che non posso essere d'accordo con te. Sembra infatti che tu definisca ogni epoca attraverso una caratteristica egemonica, la quale dona all'epoca la sua omogeneità e la sua coerenza. Questa attitudine si rivolge anche al passato. Infatti anche le epoche passate soffrono di questa sorta di omogeneizzazione forzata. Ho letto in un post su Barenboim che tu attribuivi caratteristiche omogenee di interprete wagneriano a Klemperer, Karajan e Kleiber. Ora questi tre direttori non hanno nulla di comune. Anche teo.emme metteva in un mazzo Furtwaengler, Klemperer e Knappertsbusch; altra eterogeneità assoluta. Io per parte mia preferisco vedere in un'epoca la compresenza di atteggiamenti diversi, senza essere costretto a stabilire una gerarchia fra di loro, secondo una visione prestabilita della storia. Una interpretazione, quando riesce a parlare al proprio tempo, attesta apoditticamente la plausibilità di se stessa come espressione del momento storico da cui nasce. Quindi Muti e Gardiner e Minkowsky e Jakobs, senza pretese egemoniche. Ricordiamo quanto male hanno fatto le pretese egemoniche sulla storia della musica del Novecento. Io sono abbastanza vecchio da ricordare il tempo in cui sembrava che al di fuori della tecnica seriale non ci fosse salvezza, perché lei e solo lei rappresentava il nuovo. Shostakovich e Britten emarginati in quanto compositori legati a stilemi vecchi; anzi, decrepiti. Abbiamo visto tutti come la storia è andata a finire. Ciò consiglia prudenza; nessuno di noi può essere sicuro su chi sia in futuro destinato a interpretare la macchietta del soldato giapponese nella giungla.
Saluti
Marco Ninci
Demofoonte (Jommelli)
Moderatori: DocFlipperino, DottorMalatesta, Maugham
39 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Anch’io rispondo un po’ in ritardo, dato che ero stato tirato in ballo. Su Cherubini: fin da quando ho iniziato ad ascoltare opera, la grandezza (teatrale, non solo musicale) di due autori mi è sempre parsa penosamente sottovalutata, Cherubini e Berlioz. Su Berlioz (almeno per i Troyens) le cose stanno cambiando, su Cherubini purtroppo no, e confesso che mentre vago per i siti dei teatri di tutta Europa una delle mie principali speranze è di imbattermi in una messinscena rivelatrice di Médée: spero che la recente pubblicazione dell’edizione critica della partitura (la prima da quella di Huguet del 1801! Ricordo la fatica che avevo fatto per procurarmene una copia anastatica…) possa cambiare le cose. Ero intervenuto solo per specificare, appunto, che il “reazionario” poteva riferirsi solo all’aspetto politico, non musicale, come del resto Rodrigo ha confermato essere quello che anche lui intendeva (e del resto, credo che ben pochi potessero non avere idee restauratrici dopo aver passato a Parigi il periodo della rivoluzione e del terrore…).
Su Muti. Anche qui, io sono stato un suo grande ammiratore e credo di aver perso al massimo 3 o 4 dei suoi spettacoli del “ventennio” scaligero. Tuttavia, non posso non notare un incancrimento penoso della sua autorefernzialità. Per quanto riguarda il ‘700, non ne faccio affatto un problema di suono. Gli piace un legato sontuoso, un’eleganza un filo marmorea, ecc.? Benissimo: ma vorrei che tutto ciò fosse rivolto a qualcosa di specifico, che si organizzasse in un quadro complessivo in grado di fornire un profilo preciso a quanto esegue, mentre ultimamente si accentua ad ogni ascolto il sospetto che in fondo della teatralità di un’opera non gli importi molto, ma solo della sua resa musicale. Qualunque sia la concezione che porta avanti, non la può realizzare da solo, con cantanti mediocri (dietro la solita scusa dei “giovani”) e regie inesistenti, perché una cosa la prassi moderna ha reso (a mio parere) inequivocabile: la vitalità di un certo repertorio operistico (qualunque sia, da Monteverdi a Britten) la si dimostra solo se si è in grado di trovare una chiave per esprimere la sua specifica teatralità. Per questo le opere di Handel fino a qualche decennio fa erano considerate al massimo una miniera di bella musica, e le si riesumava solo a favore dei gorgheggi di qualche fuoriclasse (con tagli feroci, ovviamente, perché se no la noia insita in quell’approccio diventava evidente). Oggi, certi “famigerati” registi e certi direttori hanno scoperto e trovato la via di dimostrare che c’è molto di più, e Handel è diventato uno degli autori più rappresentati (non in Italia, ovviamente). E lo stesso vale per Rameau. E lo stesso non vale, guarda caso, per il ‘700 italiano cui si dedica Muti, le cui riesumazioni cadono nel dimenticatoio 10 minuti dopo l’ultima recita. Colpa delle opere che valgono poco? O dell’approccio usato?
Torniamo per un esempio al mio amatissimo Cherubini. Io sono grato a Muti di avermi dato l’occasione di ascoltare per una volta dal vivo Lodoiska. Risultato: una manciata di recite e poi nulla, il mondo teatrale non se ne è accorto e uno come Giudici, recensendo la registrazione, scrive che l’opera (non l’esecuzione, l’opera in sé) non va oltre un certo freddo accademismo formale. Freddo accademismo formale Lodoiska? Un’opera che trasuda da ogni croma la tragedia di un mondo che stava cambiando a colpi di ghigliottina? O non è forse che l’impressione di freddo accademismo formale era la conseguenza di una direzione bella ma come sempre (quando Muti è alle prese con questo repertorio) distaccata e come inerte; del fatto di avere messo la Devia (che io pure ammiro) in un ruolo concepito per una prima interprete che vocalmente era discutibilissima ma una specie di torcia umana quanto ad espressività (ossia l’esatto opposto della Devia); di quella specie di cartone animato cui Ronconi aveva ridotto una storia di oppressione e terrore? Posso sbagliare, ma io sono convinto che se oggi un teatro riprendesse Lodoiska e, anziché a Muti/Devia/Ronconi la affidasse, che so, a Gardiner o Jacobs, Dessay o Pendatchanska, McVicar o Carsen nessuno parlerebbe di “freddo accademismo formale”, e non perché Gardiner o Jacobs dirigano meglio di Muti (ci mancherebbe), ma perché si pongono il problema di andare al di là del “fare bella musica”.
Il tutto, naturalmente, come mia modesta opinione.
Beck
Su Muti. Anche qui, io sono stato un suo grande ammiratore e credo di aver perso al massimo 3 o 4 dei suoi spettacoli del “ventennio” scaligero. Tuttavia, non posso non notare un incancrimento penoso della sua autorefernzialità. Per quanto riguarda il ‘700, non ne faccio affatto un problema di suono. Gli piace un legato sontuoso, un’eleganza un filo marmorea, ecc.? Benissimo: ma vorrei che tutto ciò fosse rivolto a qualcosa di specifico, che si organizzasse in un quadro complessivo in grado di fornire un profilo preciso a quanto esegue, mentre ultimamente si accentua ad ogni ascolto il sospetto che in fondo della teatralità di un’opera non gli importi molto, ma solo della sua resa musicale. Qualunque sia la concezione che porta avanti, non la può realizzare da solo, con cantanti mediocri (dietro la solita scusa dei “giovani”) e regie inesistenti, perché una cosa la prassi moderna ha reso (a mio parere) inequivocabile: la vitalità di un certo repertorio operistico (qualunque sia, da Monteverdi a Britten) la si dimostra solo se si è in grado di trovare una chiave per esprimere la sua specifica teatralità. Per questo le opere di Handel fino a qualche decennio fa erano considerate al massimo una miniera di bella musica, e le si riesumava solo a favore dei gorgheggi di qualche fuoriclasse (con tagli feroci, ovviamente, perché se no la noia insita in quell’approccio diventava evidente). Oggi, certi “famigerati” registi e certi direttori hanno scoperto e trovato la via di dimostrare che c’è molto di più, e Handel è diventato uno degli autori più rappresentati (non in Italia, ovviamente). E lo stesso vale per Rameau. E lo stesso non vale, guarda caso, per il ‘700 italiano cui si dedica Muti, le cui riesumazioni cadono nel dimenticatoio 10 minuti dopo l’ultima recita. Colpa delle opere che valgono poco? O dell’approccio usato?
Torniamo per un esempio al mio amatissimo Cherubini. Io sono grato a Muti di avermi dato l’occasione di ascoltare per una volta dal vivo Lodoiska. Risultato: una manciata di recite e poi nulla, il mondo teatrale non se ne è accorto e uno come Giudici, recensendo la registrazione, scrive che l’opera (non l’esecuzione, l’opera in sé) non va oltre un certo freddo accademismo formale. Freddo accademismo formale Lodoiska? Un’opera che trasuda da ogni croma la tragedia di un mondo che stava cambiando a colpi di ghigliottina? O non è forse che l’impressione di freddo accademismo formale era la conseguenza di una direzione bella ma come sempre (quando Muti è alle prese con questo repertorio) distaccata e come inerte; del fatto di avere messo la Devia (che io pure ammiro) in un ruolo concepito per una prima interprete che vocalmente era discutibilissima ma una specie di torcia umana quanto ad espressività (ossia l’esatto opposto della Devia); di quella specie di cartone animato cui Ronconi aveva ridotto una storia di oppressione e terrore? Posso sbagliare, ma io sono convinto che se oggi un teatro riprendesse Lodoiska e, anziché a Muti/Devia/Ronconi la affidasse, che so, a Gardiner o Jacobs, Dessay o Pendatchanska, McVicar o Carsen nessuno parlerebbe di “freddo accademismo formale”, e non perché Gardiner o Jacobs dirigano meglio di Muti (ci mancherebbe), ma perché si pongono il problema di andare al di là del “fare bella musica”.
Il tutto, naturalmente, come mia modesta opinione.
Beck
- beckmesser
- Messaggi: 332
- Iscritto il: gio 03 mag 2007, 9:10
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Non ho molto da rispondere a ciò che dice Beckmesser. Io ho un'opinione molto diversa dalla sua, ma questi sono casi in cui le virtù della dimostrazione sono nulle. Però un'osservazione voglio farla. Ciò che dice il mio predecessore sulla mancanza di teatralità e sull'accademismo delle esecuzioni mutiane è ormai diventato un tale luogo comune, con l'annesso dei nomi che gli vengono contrapposti, sempre gli stessi,che forse la stanchezza del ripetere potrebbe consigliare di trovare altri argomenti. C'è di più. Io vengo da Firenze e ho sentito Muti tantissime volte. Ho parlato spesso con lui e l'ho trovato di un'intelligenza vivida e affascinante, niente affatto autoreferenziale. Mi stupisce quindi un po' vederlo trattare con un'aria di grande sufficienza, come una sorta di talentoso pachiderma, sempre attardato e in affanno. E' però una cosa veramente divertente pensare che per moltissimi anni il rimprovero che gli veniva fatto era quello di essere troppo teatrale, di una teatralità talmente immediata che ogni opera da lui diretta si trasformava per questo solo fatto nei "Pagliacci". Adesso accade l'esatto contrario. Sic transit gloria mundi, e così sia.
Marco Ninci
Marco Ninci
- Ninci
- Messaggi: 28
- Iscritto il: sab 27 giu 2009, 16:28
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Ninci ha scritto: Mi stupisce quindi un po' vederlo trattare con un'aria di grande sufficienza, come una sorta di talentoso pachiderma, sempre attardato e in affanno. E' però una cosa veramente divertente pensare che per moltissimi anni il rimprovero che gli veniva fatto era quello di essere troppo teatrale, di una teatralità talmente immediata che ogni opera da lui diretta si trasformava per questo solo fatto nei "Pagliacci". Adesso accade l'esatto contrario
Non so, Marco.
A Milano Egli ha dettato legge per un ventennio: tantissimo, forse troppo per un direttore musicale fisso che, probabilmente, a partire da un certo momento in avanti esaurisce le motivazioni.
Sono in parte d'accordo con te: negli anni fiorentini, da quello che si percepisce a riascoltare le sue registrazioni di allora, appare sicuramente più contrastato e dotato di un sound più ricco, movimentato, anche se già si percepiscono in pieno i presupposti di quello che verrà dopo: penso, per esempio, al Guglielmo Tell che non differisce tantissimo nelle premesse e nella realizzazione da quello che otterrà a Milano.
Sul talentoso non si discute: è un grandissimo professionista con un amore quasi ossessivo-compulsivo per la precisione esecutiva. E' capace di estenuare gli esecutori con prove lunghissime. Non ho mai parlato con lui, ma ne chiacchierai con uno dei suoi uomini di forza, Bob Kettelson, che ne ammirava il grandissimo rigore. Oddìo, a stare a guardare i cantanti con lui sono spesso in difficoltà per i tempi sempre serratissimi (ricordo Leo Nucci che arrancava sul Balen con un'orchestra che faceva le corse).
Ma sulla teatralità, almeno per quello che ho visto a Milano in vent'anni, scusa ma eccepisco proprio. Probabilmente a pesare in tal senso è la percettibile assenza di chiaroscuri però, perdonami, con direttori di estrazione diversa - che, guarda caso, a Milano non abbiamo mai sentito, tanto in più in certo repertorio - abbiamo fatto un grosso salto di qualità.
Un esempio? L' Armide. Nelle mani di Muti, Gluck è sempre un bel monumentone neoclassico che ti si appoggia addosso con la grazia di un macigno; nelle mani di un Minkowski diventa un dramma vivo, palpitante, ricco di teatralità.
E io questa "teatralità da Pagliacci" in Muti, almeno nel Muti milanese, proprio non l'ho mai sentita...
"Dopo morto, tornerò sulla terra come portiere di bordello e non farò entrare nessuno di voi!"
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
(Arturo Toscanini, ai musicisti della NBC Orchestra)
-

pbagnoli - Site Admin
- Messaggi: 4006
- Iscritto il: mer 04 apr 2007, 19:15
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Caro Pietro, la mia era naturalmente una battuta. Io trovo che il Gluck di Muti non abbia questa monumentalità opprimente, ma possieda una sua forza interna estremamente differenziata, anche se questa non ha quell'evidenza un po' esteriore che caratterizza ad esempio Minkowsky. Non parliamo poi della tecnica direttoriale, in Minkowsky sempre un po' approssimativa; vedere le Nozze di Figaro che ho ascoltato questo inverno a Parigi; con tutti quei cambiamenti di tempo i cantanti gli scappavano continuamente di mano; ho seri dubbi che se la cavarebbe con l'Agnes von Hohenstaufen, per la quale Minkowsky era prima invocato. Comunque, mi ricordo che i detrattori di Muti dicevano che il suo terreno di elezione era, se non i Pagliacci (ripeto: la mia era una battuta) la drammaturgia del primo Verdi. Siamo passati sul terreno opposto oppure ci siamo sempre stati? Non so. So soltanto che devo a Muti l'ammirazione che si deve a un autentico fuoriclasse, coerente con se stesso e proprio per questo capace di respingere. In fondo, il più grande direttore che io abbia mai sentito dal vivo (e l'ho sentito decine di volte) è stato Herbert von Karajan; è forse il direttore cui ho sentito rivolgere le critiche più feroci, soprattutto a partire dalla sua morte. Comincio a pensare che proprio questo sia segno di grandezza.
Saluti
Marco Ninci
Saluti
Marco Ninci
- Ninci
- Messaggi: 28
- Iscritto il: sab 27 giu 2009, 16:28
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Come Pietro, di Muti ho vissuto da vicino solo la "dittatura perpetua" in Milano. Oggi capisco benissimo e condivido le critiche mosse a Lissner, ma mai per un istante ho rimpianto il passato. Scadendo nell'aneddotica: il Macbeth l'ho visto ormai un bel po' di volte. Per quanto vocalmente l'ultima edizione fosse la più disastrata, Ono, rispetto a Muti, ha diretto un'altra opera: molto più bella, a parer mio.
-

Alberich - Messaggi: 693
- Iscritto il: gio 12 apr 2007, 19:09
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Alberich ha scritto:Come Pietro, di Muti ho vissuto da vicino solo la "dittatura perpetua" in Milano. Oggi capisco benissimo e condivido le critiche mosse a Lissner, ma mai per un istante ho rimpianto il passato. Scadendo nell'aneddotica: il Macbeth l'ho visto ormai un bel po' di volte. Per quanto vocalmente l'ultima edizione fosse la più disastrata, Ono, rispetto a Muti, ha diretto un'altra opera: molto più bella, a parer mio.
Questo post potrebbe essere scritto da me, talmente sono d'accordo su tutto.
Nemmeno noi siamo d'accordo con il gobbo, ma il gobbo è essenziale! Guai se non ci fosse!
-

VGobbi - Messaggi: 2455
- Iscritto il: gio 05 apr 2007, 20:49
- Località: Verano Brianza
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Caro Ninci,
grazie della tua bella risposta a cui cercherò di rispondere punto per punto, non per convincerti delle mie idee naturalmente - che sono decisamente diverse dalle tue - ma perché questi confronti risultano comunque arricchenti.
Partiamo dalla questione del Zeitgeist, lo spirito del tempo.
è vero che per me esiste una sintesi culturale del tempo, un genius saeculi, e non solo per me.
Lo si individua nelle tendenze "dominanti", nelle evoluzioni destinate a imporsi sulle altre, nella pratiche culturali che più significativamente incidono e si diffondono in una determinata epoca. ...anche nel mondo in cui si fa musica.
Ma nè io, nè quanti parlano di Zeitgeist abbiamo mai affermato che gli uomini di una determinata epoca siano come automi, uguali fra loro, inscatolati in tendenze a cui non possono opporsi .
Dire che il proto-cristianesimo abbia plasmato di sè la cultura romano-imperiale (fin nelle rivoluzioni sintaticche della scrittura di Seneca) non vuole dire che tutti i romani dell'Impero fossero Cristiani, nè che avessero assorbito quella cultura.
Lo spirito del tempo nasce proprio da una dialettica ricca, contraddittoria e persino aspra fra ancoraggi e rivolte: da questa dialetteica si forma una sintesi, anzi mille sintesi che a loro volta saranno sintetizzate.
Non ci sarebbe spirito del tempo se non vi fossero in campo le mille visioni individuali dei singoli uomini, che si raggrumano in "visioni condivise" fra le quali si fanno largo quelle dominanti, identificiative di un secolo, di una regione, di una comunità..
Spesso (quando nel forum parliamo di queste cose) faccio il paragone con la lingua parlata.
Ognuno di noi parla l'italiano in modo diverso; ognuno trasferisce sulla sintassi e sul lessico una parte grande del proprio mondo interiore, della sua cultura, delle sue esperienze, persino della sua personalità.
Sia pure attraverso sfumature impercettibili, ognuno di noi contribuisce a confermare o modificare l'asse semantico di una parola.
Eppure nessuno di noi incarna individualmente "la lingua italiana del nostro tempo".
Essa non è questione di individui, ma di masse, o per lo meno di "maggioranze", di comunità vaste e vastissima, ed è estrapolabile dalle tendenze più comuni, fossero anche "errori".
Fra cinquecento anni, gli studiosi della lingua non si scandalizzeranno più perché nel 2009 i conduttori televisivi sbagliavano il congiuntivo: vi scorgeranno probabilmente, la prova del lungo logorio del congiuntivo alla nostra epoca e rifletteranno sulle ragioni di questa evoluzione linguistica.
Al contrario, il fatto che singoli individui come me e te (si spera) non sbagliassero a coniugarlo non interesserà a nessuno.
Al più ci qualificheranno come le normali "resistenze" di fronte a qualsiasi evoluzione.
In base a quanto ho già scritto, ti sarai reso conto che nessuno ha mai detto che Furtwaengler e Knappertbusc fossero uguali.
E' lecito affermare che un cane e un gatto sono vertebrati e mammiferi: questo non vuol dire che cane e gatto siano uguali.
Il fatto che, pur nelle diversità di approdi e personalità, Klemperer, Furtwaengler e Kanppertbusch fossero molto vicini allo spirito del loro tempo, non vuol dire che non ci fossero differenze. Non sarebbe nemmeno possibile...
Concordo assolutamente, ma temo che l'esempio non calzi con quanto ho affermato io.
Lo spirito del tempo è dettato dalle masse, ossia da vaste comunità di individui (anzi, vastissime).
Le "egemonie culturali" di cui parlavi tu non erano espressione di alcuna massa, quanto di potenti élité collegate ad ancor più potenti interessi politici.
Perniciose minoranze, che impongo dall'alto le loro finte rivoluzioni.
Lo spirito del tempo nasce sempre dal basso.
Concludo sulla questione della svolta "critica" che a te pare Muti abbia subito nel corso dei decenni: da fin troppo teatrale a troppo poco teatrale.
Quello che dici è giusto, ma io non vi scorgo alcuna contraddizione.
Il problema, secondo me, è squisitamente terminologico. E' il termine "teatralità" che, in questo contesto, ci fa scorgere una contraddizione che secondo me non c'è.
Se per teatralità si intende esuberanza e vivacità passionale (fatta anche di slanci ed effetti) è un conto.
Se per teatralità si intende la capacità di raccontare una storia non accontentandosi dell'emozione diretta, bensì scavando oltre i segni, scendendo nei nodi irrisolti, nelle ambiguità, nelle contraddizioni, svelando ponti e contatti con le inquietudini del nostro tempo... allora è tutt'altra cosa.
Cos'era la "teatralità" che si rimproverava al giovane Muti?
Era forse quel tipo di profondità che ho appena descritto? Non direi: a me pareva piuttosto esuberanza, vivacità, entusiasmo, forza di reazioni, molte delle quali appassionate e semplici.
Cosa ci ha svelato Muti di Abigaille e delle sue ragioni (tanto per fare un esempio)?
Cosa ci ha svelato di Violetta che già non sapessimo?
Che è "gggiovane", perché quello descritto dalla Traviata è "un amore ggggiovane". (scusa le tante g, ma ricordo bene l'intervista di Muti prima del debutto con la Fabbricini).
(scusa le tante g, ma ricordo bene l'intervista di Muti prima del debutto con la Fabbricini).
E la tragedia di Violetta, la sua scandalosa contestualizzazione, l'evidenza della sua "professione", l'ossessione di Piave per la diversità fisico/sociale dei suoi maledetti...? Tutto ridotto all'amore "gggiovane"?? (su cui per altro ci sarebbe da riflettere, anche in considerazione delle sottili allusioni di Germont?)
Cosa ci ha svelato Muti di Macbeth, delle sue truculente simbologie discese dalle radici stesse del Teatro occidentale?
Bel ritmo... belle atmosfere... begli schianti sonori: le streghe hanno da essere streghe... ( e se fossero qualcos'altro?).
Il "teatralissimo" Verdi di Muti può descrivere un tipo di narrazione anche efficace, convincente, persino trascinante, ma non profonda, secondo me.
Come non profondo - eccola per me la coerenza - è stato ed è il suo approccio al '700.
Se mi passi il paragone (che non vuole essere irriguardoso, ma solo esplicativo) il Verdi di Muti mi ricorda un poco i Western di De Mille: sì, divertenti, sì godibilissimi, sì ben fatti, sì brillanti... sì vivacità narrativa, sì dominio della forma, sì consapevolezza tecnica... Però non è che ti lasciassero poi tanto, una volta visti...
In compenso... come reagiva il povero De Mille - con la sua teatralità da Western per famiglie, fatta di effetti e di slanci - quando lo costringevano a volgersi al mondo classico o biblico?
...I dieci comandamenti, il Re dei Re...
Semplice. Non avendo strumenti migliori, reagiva con feste di pepli, templi, scalinate, marmi e gigantismi, colonne sonore a "grande orchestra" dal sapore modale, attori imbalsamati nel "fare grande" (come si conviene al colossal), lo sguardo che volge lontano.
Quella non era il mondo classico. E nemmeno il mondo biblico.
Era solo una raffigurazione pomposa e ingessata, frutto non di letture o riflessioni approfondite, nè di intuizioni sconcertanti e nuove (ciò che io intendevo per "teatralità") ma solo di una certa ingenuità di fondo da parte di De Mille, la stessa ravvisabile nei suo Western, benchè questi ultimi risultassero più freschi e vivaci, anche troppo...
Non mi stupirei che i critici americani che contestarono De Mille per i suoi Western "troppo carichi" ed effettistici, fossero gli stessi che lo rimproverano di essere bolso, statico e pomposo nei "Dieci comandamenti".
Vorrei infine aggiungere, a proposito di Minkowski, che evidentemente tu sei stato sfortunato con le Nozze di Figaro.
Io l'ho sentito innumeri volte (da Carmen alla Grand Duchesse di Gerolstein, dalle Nuits d'été all'Ifigenia in Aulide, dalla Platée al Dido and Aeneas). La sua perfezione formale mi è sempre parsa tanto più incredibile, quanto più egli osava effetti e soluzioni audacissimi.
Sinceramente il suo Orfeo mi pare talmente sconvolgente che non credo si possa ridurre a esteriorità.
Magari ne parleremo più nel dettaglio.
Lo spero, perché se è vero che i gusti sono soggettivi e nessuno ha il diritto di ergersi a divulgatore di verità, è anche vero che la musica e l'interpretazione si costituiscono di segni, identificabili fisicamente e decifrabili in base al codice che tutti noi, fruitori di musica o musicisti, condividiamo.
Un caro saluto e grazie dei bellissimi spunti che ci hai offerto.
Matteo Marazzi
grazie della tua bella risposta a cui cercherò di rispondere punto per punto, non per convincerti delle mie idee naturalmente - che sono decisamente diverse dalle tue - ma perché questi confronti risultano comunque arricchenti.
Partiamo dalla questione del Zeitgeist, lo spirito del tempo.
Ninci ha scritto:Sembra infatti che tu definisca ogni epoca attraverso una caratteristica egemonica, la quale dona all'epoca la sua omogeneità e la sua coerenza.
Io per parte mia preferisco vedere in un'epoca la compresenza di atteggiamenti diversi, senza essere costretto a stabilire una gerarchia fra di loro, secondo una visione prestabilita della storia. Una interpretazione, quando riesce a parlare al proprio tempo, attesta apoditticamente la plausibilità di se stessa come espressione del momento storico da cui nasce. Quindi Muti e Gardiner e Minkowsky e Jakobs, senza pretese egemoniche.
è vero che per me esiste una sintesi culturale del tempo, un genius saeculi, e non solo per me.
Lo si individua nelle tendenze "dominanti", nelle evoluzioni destinate a imporsi sulle altre, nella pratiche culturali che più significativamente incidono e si diffondono in una determinata epoca. ...anche nel mondo in cui si fa musica.
Ma nè io, nè quanti parlano di Zeitgeist abbiamo mai affermato che gli uomini di una determinata epoca siano come automi, uguali fra loro, inscatolati in tendenze a cui non possono opporsi .
Dire che il proto-cristianesimo abbia plasmato di sè la cultura romano-imperiale (fin nelle rivoluzioni sintaticche della scrittura di Seneca) non vuole dire che tutti i romani dell'Impero fossero Cristiani, nè che avessero assorbito quella cultura.
Lo spirito del tempo nasce proprio da una dialettica ricca, contraddittoria e persino aspra fra ancoraggi e rivolte: da questa dialetteica si forma una sintesi, anzi mille sintesi che a loro volta saranno sintetizzate.
Non ci sarebbe spirito del tempo se non vi fossero in campo le mille visioni individuali dei singoli uomini, che si raggrumano in "visioni condivise" fra le quali si fanno largo quelle dominanti, identificiative di un secolo, di una regione, di una comunità..
Spesso (quando nel forum parliamo di queste cose) faccio il paragone con la lingua parlata.
Ognuno di noi parla l'italiano in modo diverso; ognuno trasferisce sulla sintassi e sul lessico una parte grande del proprio mondo interiore, della sua cultura, delle sue esperienze, persino della sua personalità.
Sia pure attraverso sfumature impercettibili, ognuno di noi contribuisce a confermare o modificare l'asse semantico di una parola.
Eppure nessuno di noi incarna individualmente "la lingua italiana del nostro tempo".
Essa non è questione di individui, ma di masse, o per lo meno di "maggioranze", di comunità vaste e vastissima, ed è estrapolabile dalle tendenze più comuni, fossero anche "errori".
Fra cinquecento anni, gli studiosi della lingua non si scandalizzeranno più perché nel 2009 i conduttori televisivi sbagliavano il congiuntivo: vi scorgeranno probabilmente, la prova del lungo logorio del congiuntivo alla nostra epoca e rifletteranno sulle ragioni di questa evoluzione linguistica.
Al contrario, il fatto che singoli individui come me e te (si spera) non sbagliassero a coniugarlo non interesserà a nessuno.
Al più ci qualificheranno come le normali "resistenze" di fronte a qualsiasi evoluzione.
Questa attitudine si rivolge anche al passato. Infatti anche le epoche passate soffrono di questa sorta di omogeneizzazione forzata. Ho letto in un post su Barenboim che tu attribuivi caratteristiche omogenee di interprete wagneriano a Klemperer, Karajan e Kleiber. Ora questi tre direttori non hanno nulla di comune. Anche teo.emme metteva in un mazzo Furtwaengler, Klemperer e Knappertsbusch; altra eterogeneità assoluta.
In base a quanto ho già scritto, ti sarai reso conto che nessuno ha mai detto che Furtwaengler e Knappertbusc fossero uguali.
E' lecito affermare che un cane e un gatto sono vertebrati e mammiferi: questo non vuol dire che cane e gatto siano uguali.
Il fatto che, pur nelle diversità di approdi e personalità, Klemperer, Furtwaengler e Kanppertbusch fossero molto vicini allo spirito del loro tempo, non vuol dire che non ci fossero differenze. Non sarebbe nemmeno possibile...
Ricordiamo quanto male hanno fatto le pretese egemoniche sulla storia della musica del Novecento. Io sono abbastanza vecchio da ricordare il tempo in cui sembrava che al di fuori della tecnica seriale non ci fosse salvezza, perché lei e solo lei rappresentava il nuovo.
Concordo assolutamente, ma temo che l'esempio non calzi con quanto ho affermato io.
Lo spirito del tempo è dettato dalle masse, ossia da vaste comunità di individui (anzi, vastissime).
Le "egemonie culturali" di cui parlavi tu non erano espressione di alcuna massa, quanto di potenti élité collegate ad ancor più potenti interessi politici.
Perniciose minoranze, che impongo dall'alto le loro finte rivoluzioni.
Lo spirito del tempo nasce sempre dal basso.
Concludo sulla questione della svolta "critica" che a te pare Muti abbia subito nel corso dei decenni: da fin troppo teatrale a troppo poco teatrale.
E' però una cosa veramente divertente pensare che per moltissimi anni il rimprovero che gli veniva fatto era quello di essere troppo teatrale, di una teatralità talmente immediata che ogni opera da lui diretta si trasformava per questo solo fatto nei "Pagliacci". Adesso accade l'esatto contrario. Sic transit gloria mundi, e così sia.
Quello che dici è giusto, ma io non vi scorgo alcuna contraddizione.
Il problema, secondo me, è squisitamente terminologico. E' il termine "teatralità" che, in questo contesto, ci fa scorgere una contraddizione che secondo me non c'è.
Se per teatralità si intende esuberanza e vivacità passionale (fatta anche di slanci ed effetti) è un conto.
Se per teatralità si intende la capacità di raccontare una storia non accontentandosi dell'emozione diretta, bensì scavando oltre i segni, scendendo nei nodi irrisolti, nelle ambiguità, nelle contraddizioni, svelando ponti e contatti con le inquietudini del nostro tempo... allora è tutt'altra cosa.
Cos'era la "teatralità" che si rimproverava al giovane Muti?
Era forse quel tipo di profondità che ho appena descritto? Non direi: a me pareva piuttosto esuberanza, vivacità, entusiasmo, forza di reazioni, molte delle quali appassionate e semplici.
Cosa ci ha svelato Muti di Abigaille e delle sue ragioni (tanto per fare un esempio)?
Cosa ci ha svelato di Violetta che già non sapessimo?
Che è "gggiovane", perché quello descritto dalla Traviata è "un amore ggggiovane".
E la tragedia di Violetta, la sua scandalosa contestualizzazione, l'evidenza della sua "professione", l'ossessione di Piave per la diversità fisico/sociale dei suoi maledetti...? Tutto ridotto all'amore "gggiovane"?? (su cui per altro ci sarebbe da riflettere, anche in considerazione delle sottili allusioni di Germont?)
Cosa ci ha svelato Muti di Macbeth, delle sue truculente simbologie discese dalle radici stesse del Teatro occidentale?
Bel ritmo... belle atmosfere... begli schianti sonori: le streghe hanno da essere streghe... ( e se fossero qualcos'altro?).
Il "teatralissimo" Verdi di Muti può descrivere un tipo di narrazione anche efficace, convincente, persino trascinante, ma non profonda, secondo me.
Come non profondo - eccola per me la coerenza - è stato ed è il suo approccio al '700.
Se mi passi il paragone (che non vuole essere irriguardoso, ma solo esplicativo) il Verdi di Muti mi ricorda un poco i Western di De Mille: sì, divertenti, sì godibilissimi, sì ben fatti, sì brillanti... sì vivacità narrativa, sì dominio della forma, sì consapevolezza tecnica... Però non è che ti lasciassero poi tanto, una volta visti...
In compenso... come reagiva il povero De Mille - con la sua teatralità da Western per famiglie, fatta di effetti e di slanci - quando lo costringevano a volgersi al mondo classico o biblico?
...I dieci comandamenti, il Re dei Re...
Semplice. Non avendo strumenti migliori, reagiva con feste di pepli, templi, scalinate, marmi e gigantismi, colonne sonore a "grande orchestra" dal sapore modale, attori imbalsamati nel "fare grande" (come si conviene al colossal), lo sguardo che volge lontano.
Quella non era il mondo classico. E nemmeno il mondo biblico.
Era solo una raffigurazione pomposa e ingessata, frutto non di letture o riflessioni approfondite, nè di intuizioni sconcertanti e nuove (ciò che io intendevo per "teatralità") ma solo di una certa ingenuità di fondo da parte di De Mille, la stessa ravvisabile nei suo Western, benchè questi ultimi risultassero più freschi e vivaci, anche troppo...
Non mi stupirei che i critici americani che contestarono De Mille per i suoi Western "troppo carichi" ed effettistici, fossero gli stessi che lo rimproverano di essere bolso, statico e pomposo nei "Dieci comandamenti".
Vorrei infine aggiungere, a proposito di Minkowski, che evidentemente tu sei stato sfortunato con le Nozze di Figaro.
Io l'ho sentito innumeri volte (da Carmen alla Grand Duchesse di Gerolstein, dalle Nuits d'été all'Ifigenia in Aulide, dalla Platée al Dido and Aeneas). La sua perfezione formale mi è sempre parsa tanto più incredibile, quanto più egli osava effetti e soluzioni audacissimi.
Sinceramente il suo Orfeo mi pare talmente sconvolgente che non credo si possa ridurre a esteriorità.
Magari ne parleremo più nel dettaglio.
Lo spero, perché se è vero che i gusti sono soggettivi e nessuno ha il diritto di ergersi a divulgatore di verità, è anche vero che la musica e l'interpretazione si costituiscono di segni, identificabili fisicamente e decifrabili in base al codice che tutti noi, fruitori di musica o musicisti, condividiamo.
Un caro saluto e grazie dei bellissimi spunti che ci hai offerto.
Matteo Marazzi
-

MatMarazzi - Messaggi: 3182
- Iscritto il: gio 05 apr 2007, 12:34
- Località: Ferrara
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Condivido in pieno il discorso sullo Zeitgeist, l'unico giudice delle umane cose, non solo artistiche.
Ovviamente, questo non significa che tutto ciò che succede, solo perché avviene, sia condivisibile. Ogni individuo può, anzi deve, valutare in base al proprio gusto, reagendo più o meno positivamente all'evoluzione del proprio tempo.
Il congiuntivo, è vero, sta vivendo una fase di stanca nella lingua italiana, per altro in ritardo in questa semplificazione rispetto ad altre lingue neolatine come il francese, che l'ha relegato a pochi usi da tempo. E' vero anche che l'italiano, essendo fra le lingue romanze una delle più "fedeli" al latino, è fra le più coriacee ai tentativi di cambiamento e semplificazione.
Questo però non toglie che sia perfettamente legittimo che un locutore italiano speri che il congiuntivo non cada, e si ribelli alla tendenza. Poi, forse sarà uno sconfitto della storia, ma certo deve portare avanti la propria linea.
Su Muti, io ho un'idea personale: secondo me, egli è stato un notevole interprete, e non certo superficiale, ma negli anni '70, o comunque prima di diventare Nume tutelare della Scala.
E' possibile che le sue direzioni siano "semplici", ma di quella semplicità che è anche grandezza. I suoi Pagliacci e la sua Cavalleria rusticana incisi per la Emi, al di là di certe sciagurate scelte di cast, sono illuminanti. FInalmente non si sente l'orchestrona sgargiante che dipinge la Calabria e la Sicilia come battute dal sole, pervase dall'olezzo di arance e popolate di persone focose e dal "sangre caliente". Si sente invece un aria come ferma, immobile, tersa, assolutamente nuova, finalmente libera dal desiderio di fare cartolina.
Si dice, lo dicono un po' tutti, che Karajan fu il primo a sgravare il Dittico verista dalle ipoteche di elefantiasi e turgore sonoro: a dire il vero, pur trovando magnifiche le direzioni di Karajan in quei dischi DGG, io non ho trovato mai una vera, totale innovazione nella sua visione direttoriale di queste opere.
In Muti sì, eccome. Ma nei bruttissimi Pagliacci in disco Philips del 1992 con Pavarotti e la Dessì, Muti sembra un altro. Mantiene le stesse premesse, ma qualcosa è cambiato. Manca la teatralità che nel disco EMI è palpabile. Abbastanza maramaldamente, la critica si è intestardita a far notare che Muti toglie gli acuti nel Prologo dei Pagliacci, che non fa fare gli acuti fuori ordinanza a Carreras (e meno male!), deridendolo perché si sarebbe trattato di falsa filologia. Invece, a mio modo di vedere, la grandezza di questa direzione è proprio nella teatralità, nella visione innovativa. Acuti in più o in meno? Ma chi se ne...?
Ma di questa personalità, ho trovato poche tracce nel Muti "Re dei Re" alla Scala.
Ovviamente, questo non significa che tutto ciò che succede, solo perché avviene, sia condivisibile. Ogni individuo può, anzi deve, valutare in base al proprio gusto, reagendo più o meno positivamente all'evoluzione del proprio tempo.
Il congiuntivo, è vero, sta vivendo una fase di stanca nella lingua italiana, per altro in ritardo in questa semplificazione rispetto ad altre lingue neolatine come il francese, che l'ha relegato a pochi usi da tempo. E' vero anche che l'italiano, essendo fra le lingue romanze una delle più "fedeli" al latino, è fra le più coriacee ai tentativi di cambiamento e semplificazione.
Questo però non toglie che sia perfettamente legittimo che un locutore italiano speri che il congiuntivo non cada, e si ribelli alla tendenza. Poi, forse sarà uno sconfitto della storia, ma certo deve portare avanti la propria linea.
MatMarazzi ha scritto:Il problema, secondo me, è squisitamente terminologico. E' il termine "teatralità" che, in questo contesto, ci fa scorgere una contraddizione che secondo me non c'è.
Se per teatralità si intende esuberanza e vivacità passionale (fatta anche di slanci ed effetti) è un conto.
Se per teatralità si intende la capacità di raccontare una storia non accontentandosi dell'emozione diretta, bensì scavando oltre i segni, scendendo nei nodi irrisolti, nelle ambiguità, nelle contraddizioni, svelando ponti e contatti con le inquietudini del nostro tempo... allora è tutt'altra cosa.
Cos'era la "teatralità" che si rimproverava al giovane Muti?
Era forse quel tipo di profondità che ho appena descritto? Non direi: a me pareva piuttosto esuberanza, vivacità, entusiasmo, forza di reazioni, molte delle quali appassionate e semplici.
Cosa ci ha svelato Muti di Abigaille e delle sue ragioni (tanto per fare un esempio)?
Cosa ci ha svelato di Violetta che già non sapessimo?
Che è "gggiovane", perché quello descritto dalla Traviata è "un amore ggggiovane".(scusa le tante g, ma ricordo bene l'intervista di Muti prima del debutto con la Fabbricini).
E la tragedia di Violetta, la sua scandalosa contestualizzazione, l'evidenza della sua "professione", l'ossessione di Piave per la diversità fisico/sociale dei suoi maledetti...? Tutto ridotto all'amore "gggiovane"?? (su cui per altro ci sarebbe da riflettere, anche in considerazione delle sottili allusioni di Germont?)
Cosa ci ha svelato Muti di Macbeth, delle sue truculente simbologie discese dalle radici stesse del Teatro occidentale?
Bel ritmo... belle atmosfere... begli schianti sonori: le streghe hanno da essere streghe... ( e se fossero qualcos'altro?).
Il "teatralissimo" Verdi di Muti può descrivere un tipo di narrazione anche efficace, convincente, persino trascinante, ma non profonda, secondo me.
Come non profondo - eccola per me la coerenza - è stato ed è il suo approccio al '700.
Su Muti, io ho un'idea personale: secondo me, egli è stato un notevole interprete, e non certo superficiale, ma negli anni '70, o comunque prima di diventare Nume tutelare della Scala.
E' possibile che le sue direzioni siano "semplici", ma di quella semplicità che è anche grandezza. I suoi Pagliacci e la sua Cavalleria rusticana incisi per la Emi, al di là di certe sciagurate scelte di cast, sono illuminanti. FInalmente non si sente l'orchestrona sgargiante che dipinge la Calabria e la Sicilia come battute dal sole, pervase dall'olezzo di arance e popolate di persone focose e dal "sangre caliente". Si sente invece un aria come ferma, immobile, tersa, assolutamente nuova, finalmente libera dal desiderio di fare cartolina.
Si dice, lo dicono un po' tutti, che Karajan fu il primo a sgravare il Dittico verista dalle ipoteche di elefantiasi e turgore sonoro: a dire il vero, pur trovando magnifiche le direzioni di Karajan in quei dischi DGG, io non ho trovato mai una vera, totale innovazione nella sua visione direttoriale di queste opere.
In Muti sì, eccome. Ma nei bruttissimi Pagliacci in disco Philips del 1992 con Pavarotti e la Dessì, Muti sembra un altro. Mantiene le stesse premesse, ma qualcosa è cambiato. Manca la teatralità che nel disco EMI è palpabile. Abbastanza maramaldamente, la critica si è intestardita a far notare che Muti toglie gli acuti nel Prologo dei Pagliacci, che non fa fare gli acuti fuori ordinanza a Carreras (e meno male!), deridendolo perché si sarebbe trattato di falsa filologia. Invece, a mio modo di vedere, la grandezza di questa direzione è proprio nella teatralità, nella visione innovativa. Acuti in più o in meno? Ma chi se ne...?
Ma di questa personalità, ho trovato poche tracce nel Muti "Re dei Re" alla Scala.
Il mondo dei melomani è talmente contorto che nemmeno Krafft-Ebing sarebbe riuscito a capirci qualcosa...
-

Tucidide - Messaggi: 1699
- Iscritto il: mar 02 ott 2007, 1:01
- Località: Faenza
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Cari amici, ora non ho tempo per rispondere. Dico solo che se Muti fosse quello che voi descrivete, non ci sarebbe nessun interesse ad ascoltarlo, diviso fra teatralità ruspante e accademismo formale, negato per sempre ad ogni profondità; prima un giovanotto di belle speranze, poi un bolso ripetitore di cose risapute e vecchie. Anche la lode al dittico verista ha il sottinteso che con altre opere ben diversa sarebbe la questione. E comunque, Jedes Ding ha seine Zeit, dice la Marescialla; perfino con i Pagliacci il bel tempo è durato poco. Mah..
Marco Ninci
Marco Ninci
- Ninci
- Messaggi: 28
- Iscritto il: sab 27 giu 2009, 16:28
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Caro Matteo, rispondo meglio non tanto su Muti quanto sulla questione di fondo. Vale a dire, sullo spirito del tempo. Tu dici che lo spirito del tempo si forma dal basso, come prevalenza di una linea egemonica su altre mille sintesi che sono possibili all'interno di un determinato periodo. All'interno di questa dialettica si forma l'alternanza di vecchio e di nuovo. Tucidide dice addirittura che lo spirito del tempo è l'unico che giudica delle cose umane. Ora, io confesso di non essere tanto sicuro di conoscere questa autorità così insindacabile, gelosa ed esclusiva. Avere una simile sicurezza significa sapere dove va la storia, essere sicuri di distinguere i vicoli ciechi dalle autostrade a sei corsie. Il che, perdonami se te lo dico, è una bella presunzione. Per stare soltanto al caso dell'interpretazione musicale, sono compresenti in un'epoca voci così discordanti ed ugualmente valide che è impossibile imporre loro la differenza fra il vecchio ed il nuovo. Bruno Walter nel 1936 incideva a Vienna un primo atto della Walkuere che non aveva nulla di comune con la scuola storica di Furtwaengler o Abendroth. Questi ultimi erano invecchiati? Era troppo giovane Walter? Nulla di tutto questo. Erano possibilità insite in quell'epoca, semplicemente. Perché il rapporto che tu fai fra espressione estetica e storia va completamente rovesciato. Non è ciò che noi pensiamo di un'epoca a dover indirizzare le nostre scelte fra vecchio e nuovo. E' invece la riuscita estetica di un'esperienza, il fatto che quest'esperienza parli a un gran numero di persone (da lì bisogna sempre partire) a dirci qualcosa di importante sulla storia, a farci capire che la molteplicità di prospettive è sempre dietro l'angolo. Il fatto che ci potessero essere negli anni Trenta del Novecento dei Wagner così divergenti ci dice una cosa importante e fondamentale: che in quell'epoca non tutti condividevano il mito del germanesimo, anche se il germanesimo di Furtwaengler non era certo quello di Goering e Goebbels, ma quello dei grandi archeologi, dei grandi filologi classici e dei grandi storici della musica. E le scuole di canto? Cosa aveva di comune la linea limpida di Voelker con quella stentorea di Max Lorenz? Eppure erano contemporanei; ma servivano ideali diversi. E Clemens Krauss? E' contemporaneo di Furtwaengler, ma è tutto un altro mondo, pur nello stesso repertorio (oltretutto, ambedue pesantemente compromessi col nazismo). Tutto questo per dire che secondo me la dialettica di nuovo e di vecchio non ha alcun fondamento nella dimensione estetica e lo Zeitgeist, soprattutto quando possiamo contemplarlo da una certa distanza temporale, si polverizza in una molteplicità di orizzonti complementari che, loro sì, ci danno un'informazione autentica sulla storia che hanno incarnato.
Marco Ninci
Marco Ninci
- Ninci
- Messaggi: 28
- Iscritto il: sab 27 giu 2009, 16:28
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Il discorso è molto interessante. Credo sia corretto tenere presente che si può essere cronologicamente contemporanei e artisticamente appartenere a generazioni diverse: Leonardo da Vinci (nato nel 1452) è più o meno coetaneo di Botticelli (nato nel 1445) e Perugino (nato nel 1450), ma la sua pittura è molto più vicina a quella di Raffaello (nato nel 1483) che a quella dei primi due!
Inoltre ritengo, ed è un paradosso che mi affascina, che si può giungere ad un risultato artisticamente rilevante anche muovendo da presupposti estetici "incongrui". Si può fare l'esempio di tanti Fidelio letti in un ottica wagneriana o -perchè no- di Carreras alle prese con l'Otello rossiniano. Siamo tutti d'accordo che la parte assolutamente non va cantata così, che mancano le fioriture ad libitum, le riprese variate, gli acuti in falsettone. Eppure il timbro così carnale, che non ha nulla di neoclassico, la dizione scolpita rendono (almeno a me) l'ascolto tutt'altro che ingrato anche se il ruolo Nozzari viene affrontato come se fosse un ruolo romantico... Il monologo di inizio del III, letto in un ottica così sbagliata, diventa una scena da thriller psicologico (mi pare di avere davanti l'Harrison Ford stranito di Frantic)!
D'altra parte prima di Carreras il ruolo era stato ben più sfigurato da tenorini dalla voce chiara e dal registro basso inesistente (vedasi Agostino Lazzari).
Inoltre ritengo, ed è un paradosso che mi affascina, che si può giungere ad un risultato artisticamente rilevante anche muovendo da presupposti estetici "incongrui". Si può fare l'esempio di tanti Fidelio letti in un ottica wagneriana o -perchè no- di Carreras alle prese con l'Otello rossiniano. Siamo tutti d'accordo che la parte assolutamente non va cantata così, che mancano le fioriture ad libitum, le riprese variate, gli acuti in falsettone. Eppure il timbro così carnale, che non ha nulla di neoclassico, la dizione scolpita rendono (almeno a me) l'ascolto tutt'altro che ingrato anche se il ruolo Nozzari viene affrontato come se fosse un ruolo romantico... Il monologo di inizio del III, letto in un ottica così sbagliata, diventa una scena da thriller psicologico (mi pare di avere davanti l'Harrison Ford stranito di Frantic)!
D'altra parte prima di Carreras il ruolo era stato ben più sfigurato da tenorini dalla voce chiara e dal registro basso inesistente (vedasi Agostino Lazzari).
- Rodrigo
- Messaggi: 280
- Iscritto il: gio 18 set 2008, 21:13
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Su Muti poi, caro Matteo, cosa posso dirti? Tu ti definisci in un altro luogo di questo sito un antimutiano. Ecco, io non mi definisco per antitesi a nessuno e a nulla. Di Muti ho sentito cose splendide, altre mediocri, altre brutte. Come da Karajan, come da Ozawa, come da Abbado, come da Boulez. Lo stimo un musicista in grado di dire cose importanti, in grado di portare la sua coerenza anche nelle cose meno riuscite. Ma non userei per lui, come per nessuno, il termine "miracoloso" che tu usi per Minkowsky. Un musicista notevole (almeno a giudicare dai dischi); ma forse neppure lui è in grado di camminare sul lago di Tiberiade. Credo che sia necessario non essere "anti"; quest'ultimo sa troppo di pregiudizio e antipatia personale, del resto confermati dallo sbalorditivo tono di sufficienza con cui tu, e non solo tu, tratti questo direttore. Del resto, quando non c'è mai nulla che pienamente convinca in una carriera di oltre quarant'anni alla testa dei più prestigiosi comp'lessi mondiali, qualche pensierino in questo senso la mente lo formula. Sarebbe come chiedere di Muti ai due conduttori della "Barcaccia". Ma è mai possibile che neppure un pezzettino infinitesimale quella bacchetta sia stata in grado di dirigere con una sufficiente decenza?
Ciao
Marco Ninci
Ciao
Marco Ninci
- Ninci
- Messaggi: 28
- Iscritto il: sab 27 giu 2009, 16:28
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Demofoonte, 7 luglio 2009 - Ravenna
E così ho visto anch'io questo Demofoonte, con il secondo cast, composto da Mario Zeffiri (Demofoonte), Barbara Bargnesi (Dircea), Giacinta Nicotra (Timante), Nicola Marchesini (Matusio), Auxiliadora Toledano (Creusa), Irini Kirakidou (Cherinto) e Pamela Lucciarini (Adrasto).
L'opera è un drammone a lieto fine, dove l'elemento politico-pubblico si mescola a quello privato-affettivo con dinamiche un po' elementari ma nel complesso efficaci. La musica si intuisce di buona fattura, con alcuni momenti davvero belli, anche se per diversi motivi non li ho potuti apprezzare al meglio.
Muti, tanto per cominciare, non mi è piaciuto per niente, e così ribalto almeno parzialmente quello che avevo detto in precedenza. Con il suo suono monocromatico, con quella pappa sonora che ha ottenuto dalla "Cherubini" (orchestra molto precisa, va detto) ha fatto scomparire ogni colore, ogni peculiarità, ogni teatralità dell'opera, riducendola sovente ad una noia mortale. La sua direzione è stata assimilabile ad un omogeneizzato per bambini. Per farci digerire Jommelli, il Maestro ha ritenuto di dover sminuzzare ogni componente cromatica ed ottenere una purea che scivolasse via senza lasciare tracce. Sì, ho ascoltato il Demofoonte, l'altra sera. Ma non l'ho gustato.
Per onestà devo ricordare due cose: per prima cosa, com'è ovvio, non avevo mai sentito prima quest'opera, dunque non so quanto una direzione diversa possa rendere più bella e convincente la musica di Jommelli. In secondo luogo, la difficoltà estrema delle parti vocali esige un cast di grandi cantanti, che non era purtroppo presente il 7 luglio all'"Alighieri": di certo, questa tara ha penalizzato la riuscita dello spettacolo.
Dei cantanti, infatti, solo la Bargnesi mi è davvero piaciuta, nei panni di una Dircea piuttosto volitiva ed accorata. Un personaggio un po' convenzionale, realizzato però con garbo e senza clamorosi problemi alle prese con la scrittura vocale. Zeffiri male, per conto mio: voce bianchiccia, scarso nei passi di coloratura, discreto però nei recitativi. Il Timante della Nicotra era un po' troppo isterico, spesso parlava nei recitativi, un po' per foga, un po' per carenze tecniche, un po' perché la cantante ha voce da soprano e si trovava a cantare un ruolo mediosopranile. La Toledano non è stata male in alcune scene, mostrando una Creusa all'inizio egocentrica ed anche un po' civettuola, poi trasformatasi in una generosa interceditrice: peccato per la voce un po' asprigna in alto. La Kirakidou invece è stata assai pallida nei panni del giovane ed idealista Chreinto, così come Marchesini come Matusio. A questo controtenore va però dato il merito di possedere una voce assai sonora, anche se piuttosto bruttarella.
Due parole sulla regia, molto convenzionale e priva di idee originali. Ad ogni modo, per una prima assoluta non è dalla regia che si deve cercare il "qualcosa in più", ma dall'esecuzione musicale.
E così ho visto anch'io questo Demofoonte, con il secondo cast, composto da Mario Zeffiri (Demofoonte), Barbara Bargnesi (Dircea), Giacinta Nicotra (Timante), Nicola Marchesini (Matusio), Auxiliadora Toledano (Creusa), Irini Kirakidou (Cherinto) e Pamela Lucciarini (Adrasto).
L'opera è un drammone a lieto fine, dove l'elemento politico-pubblico si mescola a quello privato-affettivo con dinamiche un po' elementari ma nel complesso efficaci. La musica si intuisce di buona fattura, con alcuni momenti davvero belli, anche se per diversi motivi non li ho potuti apprezzare al meglio.
Muti, tanto per cominciare, non mi è piaciuto per niente, e così ribalto almeno parzialmente quello che avevo detto in precedenza. Con il suo suono monocromatico, con quella pappa sonora che ha ottenuto dalla "Cherubini" (orchestra molto precisa, va detto) ha fatto scomparire ogni colore, ogni peculiarità, ogni teatralità dell'opera, riducendola sovente ad una noia mortale. La sua direzione è stata assimilabile ad un omogeneizzato per bambini. Per farci digerire Jommelli, il Maestro ha ritenuto di dover sminuzzare ogni componente cromatica ed ottenere una purea che scivolasse via senza lasciare tracce. Sì, ho ascoltato il Demofoonte, l'altra sera. Ma non l'ho gustato.
Per onestà devo ricordare due cose: per prima cosa, com'è ovvio, non avevo mai sentito prima quest'opera, dunque non so quanto una direzione diversa possa rendere più bella e convincente la musica di Jommelli. In secondo luogo, la difficoltà estrema delle parti vocali esige un cast di grandi cantanti, che non era purtroppo presente il 7 luglio all'"Alighieri": di certo, questa tara ha penalizzato la riuscita dello spettacolo.
Dei cantanti, infatti, solo la Bargnesi mi è davvero piaciuta, nei panni di una Dircea piuttosto volitiva ed accorata. Un personaggio un po' convenzionale, realizzato però con garbo e senza clamorosi problemi alle prese con la scrittura vocale. Zeffiri male, per conto mio: voce bianchiccia, scarso nei passi di coloratura, discreto però nei recitativi. Il Timante della Nicotra era un po' troppo isterico, spesso parlava nei recitativi, un po' per foga, un po' per carenze tecniche, un po' perché la cantante ha voce da soprano e si trovava a cantare un ruolo mediosopranile. La Toledano non è stata male in alcune scene, mostrando una Creusa all'inizio egocentrica ed anche un po' civettuola, poi trasformatasi in una generosa interceditrice: peccato per la voce un po' asprigna in alto. La Kirakidou invece è stata assai pallida nei panni del giovane ed idealista Chreinto, così come Marchesini come Matusio. A questo controtenore va però dato il merito di possedere una voce assai sonora, anche se piuttosto bruttarella.
Due parole sulla regia, molto convenzionale e priva di idee originali. Ad ogni modo, per una prima assoluta non è dalla regia che si deve cercare il "qualcosa in più", ma dall'esecuzione musicale.
Il mondo dei melomani è talmente contorto che nemmeno Krafft-Ebing sarebbe riuscito a capirci qualcosa...
-

Tucidide - Messaggi: 1699
- Iscritto il: mar 02 ott 2007, 1:01
- Località: Faenza
Re: Demofoonte (Jommelli) - Muti
Ninci ha scritto:Non è ciò che noi pensiamo di un'epoca a dover indirizzare le nostre scelte fra vecchio e nuovo. E' invece la riuscita estetica di un'esperienza, il fatto che quest'esperienza parli a un gran numero di persone (da lì bisogna sempre partire) a dirci qualcosa di importante sulla storia, a farci capire che la molteplicità di prospettive è sempre dietro l'angolo.
Caro Marco Ninci, la tua disamina sull'estetica è assai interessante. Condivido l'importanza che tu attrbuisci al "successo" che un'esperienza artistica ottiene, al quale aggiungerei il Fortleben, la "fortuna" di essa nella posterità. Si deve parlare al pubblico presente, ma indice di vera grandezza è altresì il tracciare nuove vie, farsi ammirare anche a decenni, perfino secoli di distanza.
In questo senso parlavo del Tempo come dell'unico giudice delle cose umane.
Quando sento dire, ad esempio di un libro, che è semplicemente un "caso editoriale", che vende tanto solo per l'abile marketing che sta dietro, un po' sorrido amaro come Democrito (l'idea di un pubblico pecorone che non capisce niente e che compra i libri come se fosse in trance mi fa sorridere
 ), un po' rifletto e lascio al Tempo la decisione. Non mi permetterei mai di ergermi a giudice dell'Arte, io che ne sono consumatore. Non sarebbe male se anche i critici facessero altrettanto.
), un po' rifletto e lascio al Tempo la decisione. Non mi permetterei mai di ergermi a giudice dell'Arte, io che ne sono consumatore. Non sarebbe male se anche i critici facessero altrettanto.Non c'è pubblicità, isteria collettiva, stategia di marketing, sinarchia occulta che possa veramente decretare il successo imperituro, dunque lo statuto di "grandezza", ad un'espressione artistica.
Leyla Gencer non aveva le case discografiche alle spalle, ma è riuscita a rimanere nella Storia. A trent'anni dal suo ritiro dalle scene, è ancora un'icona, e penso che lo rimarrà.
Di Di Stefano dicevano che era un caso montato dalla EMI, che faceva presa sul pubblico incompetente e sulla critica compiacente e "cioccolataia"
 ... Sì, certo, come no? Vallo a dire alle centinaia, migliaia di suoi fan sfegatati, giovani e non giovani.
... Sì, certo, come no? Vallo a dire alle centinaia, migliaia di suoi fan sfegatati, giovani e non giovani. Di Kathleen Battle, invece, non parla quasi più nessuno (un po' in America, ma poco), a pochi anni dal suo graduale ritiro. E aveva alle spalle la DGG, contratti con il MET, la stima di Herbert von Karajan... Ma se al pubblico piacicchi appena, ti sopportano e magari applaudono finché duri, poi ti lasciano andare al tuo destino, e ti dimenticano.
Il mondo dei melomani è talmente contorto che nemmeno Krafft-Ebing sarebbe riuscito a capirci qualcosa...
-

Tucidide - Messaggi: 1699
- Iscritto il: mar 02 ott 2007, 1:01
- Località: Faenza
39 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti