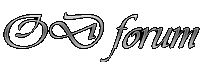Beck ha ragione: si tratta di un argomento tosto.
Ma penso sia giusto parlarne perchè lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti (dell'opera, ovviamente, la prosa se la passa meglio, di poco, ma se la passa meglio).
Allora.
Provo a mettere insieme un po' di fatti a prescindere dagli intendimendi di ciascuno di noi.
Sono del parere che discutere se lo stato italiano debba o meno sovvenzionare lo spettacolo sia un esercizio molto interessante ma puramente speculativo.
E' lo è per due motivi.
Il primo è di carattere legislativo.
Nel 2003 il decreto La Loggia ha modificato il titolo V della Costituzione.
Semplifico senza riportarvi tutti i ghirigori giuridici e i vari rimpalli tra organismi centrali e periferici.
Il succo è questo: a seguito di questa modifica lo spettacolo viene equiparato ai beni culturali e di conseguenza appartiene a quella fetta di patrimonio che lo Stato ha il dovere di tutelare e sostenere.
In termini pratici questo significa che la collettività non può più scegliere se sovvenzionare lo spettacolo, ma ha il dovere di farlo; come ha il dovere di farlo per il Colosseo o il Ponte di Rialto.
Questo riconoscimento, nella realtà dei fatti, si è mostrato puramente formale.
Infatti non si è tradotto nè in un incremento dei fondi stanziati per lo spettacolo nè -cosa che auspicavo e a quanto ho letto auspicate anche voi- in un graduale processo di revisione di strumenti gestionali ormai obsoleti.
L'unico modo quindi per dare una sterzata con finalità chiaramente "educative"a un settore visto, si da destra sia da sinistra, come un malato terminale è stato quello della riduzione dei fondi e delle privatizzazioni (finte, fintissime, come dice Beck) di molte strutture teatrali.
La riduzione de fondi (operata da questo governo ma anche da quelli precedenti) ha portato -visto che i finanziamenti venivano elargiti a pioggia- a un taglio altrettanto a pioggia del FUS e del passaggio dei conferimenti in danaro da parte dello Stato ai Comuni senza nessun comprensibile criterio di scelta nel merito.
Anche la percentuale dgli investimenti del PIL nella cultura si è abbassata di molto.
Non so quali siano gli ultimi dati ma dovremmo essere di gran lunga sotto al 2% il che ci pone ultimi dopo Francia, Spagna e Germania. Lasciamo il Nord nel suo empireo.
E se gli investimenti di questi paesi in percentuale non sono significativamente superiori, nella realtà lo sono visto che il PIL di Francia e Germania è superiore al nostro.
Il secondo motivo è di carattere storico.
Che, almeno nel nostro paese, il teatro -d'opera in particolare- non possa sopravvivere privo di finanziamenti esterni è un dato di fatto che risale ormai a duecento anni fa.
Istruttivo è tal fine lo splendido libro di Rosselli "L'impresario d'opera" edito dalla EDT nel 1985. Si tratta di un libro scritto all'anglosassone, ovvero praticamente privo di opinioni personali ma precisissimo nelle fonti, ricco di tabelle, di dati e di raffronti riferiti particolarmente al siglo de oro dell'impresariato operistico italiano, ovvero l'ottocento.
Lo lessi all'epoca per la mia tesi di laurea e lo trovai sorprendente.
Ero convinto che il sostegno di stato all'opera fosse una cosa relativamente recente e che per tutto l'Ottocento vigesse invece un imprendotoria artistica privata e coraggiosa di cui si era persa traccia.
Insomma, ero convinto che l'opera funzionasse con le sue gambe senza bisogno di nessun puntello pubblico.
In parte era vero; in parte no.
L'impresario era principalmente un intermediario tra i cantanti, i compositori e una città. Il suo rischio - sempre notevole - era più calcolato di quanto si può pensare.
Mi spiego meglio. Quando si organizzava la stagione di Carnevale (di solito la più importante che partiva da Santo Stefano e arrivava a Quaresima) si formava grosso modo un tavolo a tre posti attorno cui si sedevano diversi soggetti.
Uno era ovviamente l'impresario che mirava ad ottenere l'appalto per organizzare la stagione. E faceva in modo di ottenerlo in quelle citta in cui, sono parole del Lanari, il teatro fosse meglio "sovvenzionato".
Gli altri due soggetti, i "sovvenzionatori", erano da un lato, le società di palchettisti (i cittadini più abbienti) che vagliavano le proposte e a loro volta lottavano per aggiudicarsi l'impresario più potente, quello con i nomi di cartello, dall'altro il Podestà e il consiglio comunale oppure l'Intendente regio (a seconda dei luoghi) incaricati di gestire i fondi con cui sostenere parte delle spese della stagione nonchè quelle manutentive delle strutture.
C'erano varianti, ma grosso modo i costi erano così suddivisi: l'impresario si accollava le spese dei cantanti, del compositore, delle sartorie e delle scene. I palchettisti contribuivano a queste spese in misura variabile tramite contributi a seconda della capacità contrattuale o meno dell'impresario e dei nomi che metteva sul piatto. La città provvedeva, a sua volta con danaro pubblico o fornendo esenzioni o riducendo i proventi derivanti dalle sale da gioco annesse al teatro, al finanziamento della stagione (personale di sala, tecnici, falegnami), alla manutenzione della struttura. In alcuni casi si accollava anche il costo dell'orchestra che poteva essere stabile (i famosi accademici) oppure messa insieme per l'occasione.
In pratica -e con le dovute eccezioni, sto generalizzando- già allora la collettività si prendeva carico dei cosiddetti "costi fissi".
L'incasso dei biglietti -almeno per la prima metà dell'ottocento- era una voce non particolarmente significativa.
Gli introiti dell'impresario stavano quindi nella differenza tra quanto danaro una città poteva affidargli (appalto appunto) e quanto lui riusciva a "risparmiare" nei costi di allestimento. A questo si deve aggiungere la percentuale sui proventi della sala da gioco che era divisa, a suon di coltello, tra amministrazione cittadina, palchettisti e impresario.
Ovvio che, con questo sistema, la bancarotta era dietro l'angolo. Bastava, non dico un fiasco, ma anche una malattia di un cantante, o una gravidanza -di solito si componeva l'opera durante le ultime due settimane di prova, ovvero a ridosso della prima- per far saltare tutte le trattative. Ma quando le cose andavano bene facevi soldi a palate, la tua fama cresceva, e l'anno dopo avevi grandi teatri ben sovvenzionati, con cittadini facoltosi pronti a investire cifre da capogiro per assicurarsi gli spettacoli che producevi. Se poi eri potente come Barbaja non conoscevi limiti in quanto gestore di quasi tutte le bische "teatrali" della città.
In pratica era come se la premiata ditta Marazzi-Beck decide di allestire Ugonotti. Ha sotto contratto i cantanti giusti, lo scenografo giusto e il regista giusto. Comincia a proporsi e sceglie ovviamente il teatro che possa co-finanziare questa impresa. La città x decide che non può fare a meno di questi Ugonotti e quindi mette sul piatto da una lato cospicue sponsorizzazioni (i palchettisti) nonchè copre con danaro pubblico tutti i costi delle maestranze artistiche e tecniche (coro o orchestra compresi). Poi ci si mette d'accordo su come spartire un eventuale indotto collaterale, se c'è.
Questo sistema cominciò a incrinarisi all'alba dell'Unità. E la figura dell'impresario, a metà strada tra l'avventuriero e lo scaltro imprenditore, a tramontare.
I tempi erano cambiati.
Attorno al tavolo di cui parlavo prima cominciarono a sedersi anche nuovi soggetti come gli editori, i cantanti e i compositori.
Tutti volevano essere retribuiti. La concorrezna con le grandi paghe dell'estero era molto forte.
Di conseguenza cominciarono a levitare i costi degli spettacoli e -cito Montecchi- "i disavanzi dei teatri non furono più colmabili".
Dopo aver censito i teatri della penisola (circa un migliaio) il neonato governo decise di rifiutare qualunque sostegno stabilendo che i teatri appartenenti al demanio passassero sotto la gestione dei comuni che, in maniera esclusiva, potevano scegliere o meno se sovvenzionarli.
In pratica se ne liberò.
Ne derivò una crisi finanziaria pesantissima con potenti contraccolpi. Rosselli mostra di "come l'Opéra di Parigi potesse contare su finanziamenti due o tre volte superiori a quelli del San Carlo e della Scala che erano i teatri più lautamente sovvenzionati d'Italia". Nel 1876 il governo Depretis isituì una tassa del 10% sugli introiti del teatro e, demandando ormai quasi esclusivamente ai comuni il compito di sostenere le spese sempre più ingenti degli allestimenti portò ad una crisi che non ha nulla da invidiare a quella attuale. Riporto i dati di Rosselli: negli anni Settanta il San Carlo saltò tre stagioni, la Fenice rimase chiusa dal 72 al 97, il Carlo Felice dal 79 al 1883. Nel 1897 fa la volta della Scala che venne chiusa per una delibera del Comune che non riteneva opportuno spendere denaro della collettività per il divertimento dei ricchi.
Quindi, come si vede, il sostegno pubblico maggiore o minore è sempre esistito e, purtroppo o per fortuna, è parte della storia del nostro teatro.
Secondo me è necessario trasformarlo.
Non più soldi dati alla rinfusa o con criteri feudali (come succede adesso) ma esenzione di tributi, detassazione di sponsor e donazioni, azzeramento di utenze.
In parallelo però occorre anche cominciare a selezionare "cosa" tutelare evitando lo sbriciolamento dei contributi in attività che, palesemente, nascono morte o, ancora peggio, nascono per tutelare interessi di bottega non propriamente "alti" e "nobili".
Credetemi, il FUS è solo la punta dell'iceberg, tra l'altro una miseria se rapportata ai mille rivoli di piccoli e microscopici finanziamenti dati a questa o quella iniziativa, finanziamenti che, al di là del merito, non soddisfano nessuno; nè chi li elargisce nè, soprattutto, chi li riceve che continua a lamentarne l'esiguità.
Purtroppo, anche di fronte a crisi pesanti come quelle che affliggono il nostro mondo dell'opera, si continua a praticare la politica del "precederà dibattito", si evitano scelte drastiche per non scontentare nessuno e intanto si è arrivato a paradossi simili a quelli di un ente lirico di medio livello che, conti alla mano, anche se tenuto chiuso e sigillato avrebbe prodotto lo stesso 3 milioni di euro di disavanzo per la sproporzione dei costi fissi...
Salutoni e grazie per gli spunti
WSM
P.S. Il mio pippone è più grosso di quello di Beck