pbagnoli ha scritto:Per entrambi: classico è tutto ciò che - ragionevolmente - ci sembra esserlo.
Il concetto di Classico implica qualcosa - un insieme, o un singolo elemento - che fa sì che ci ricordiamo di quel determinato disco (poiché di questo stiamo parlando) ancora a distanza di anni.
Benedetto Croce, filosofo idealista, diceva che l´arte è ciò che da sempre gli uomini hanno chiamato arte. In una prospettiva più operodischina

mi sembra invece opportuno domandarci cosa faccia di un´incisione un “grande classico”. Di certo, comunque, ha ragione Pietro nel dire che un grande classico resta tale nel tempo (purchè lo si consideri in una prospettiva storica, tenendo cioè conto del suo contesto, e non solo di come oggi verrebbe recepito). Cosí potrebbe essere considerato un grande classico anche un´incisione che oggi ci appare polverosa, ma che ha cristallizzato un certo modo (legato ad una determinata epoca) di interpretare una data opera.
Per esempio, la Tosca De Sabata/Callas/Gobbi/Di Stefano è di certo un “grande classico” (ancorché probabilmente con qualche ruga di troppo), ma – per cosí dire – più perché rappresenta un punto fermo della storia dell´interpretazione che un nuovo vettore di forza. E questo anche (ma certo, Vit!) per l´interpretazione di Scarpia datane da Gobbi. Che per un paio di decenni (almeno) è stato lo Scarpia di riferimento. Certo, discutibile fin che si vuole, ma indiscutibile il fatto che avesse un grandissimo successo in questo ruolo. Segno che gli ascoltatori d´opera di allora si riconoscevano (ed amavano) un´interpretazione che, a noi ascoltatori di oggi, appare forse grandguignolesca, caricata, sopra le righe.
Se andiamo a cercare le sole incisioni che cambiano drasticamente il corso delle interpretazioni, forse non arriviamo a 10...
Beh... non la penso così. Per ogni opera ci sono edizioni che dicono qualcosa di nuovo o che rappresentano dei punti fermi di un determinato modo di intendere l´opera. Per Tosca, tanto per dire, penserei subito a quella di De Sabata, alla prima di Karajan e a quella di Sinopoli. Per Turandot a quella live Gavazzeni, Corelli, Nillsson e a quella di Mehta (con la Sutherland). Per Trovatore alla seconda edizione in studio diretta da Karajan con Bonisolli, etc… Lunga ora giustificare il perché. Ma mi sembrano tutte edizioni che spiccano per una concezione profondamente originale oppure perché emblematiche di un certo modo di intendere un´opera.
Riguardo alla tua recensione...
Trovo davvero estremamente interessante il rapportare il Tristan di Karajan II all´atmosfera dell´esistenzialismo. Sono d´accordissimo. Il “bel suono” di questa incisione ha in effetti l´odore inebriante e quasi nauseante di certi fiori recisi, che emanano il loro profumo più intenso proprio prima di morire. E´un profumo che sa di morte, una bellezza “velenosa”, per così dire. Di fatto, è la prima incisione che colga le ansie e le angosce del mondo contemporaneo (mentre il live da Bayreuth, nella sua bruciante immediatezza, mi sembra l´espressione di un romanticismo non vissuto come esaltazione del mito come in Furtwängler, ma come gigantesche passioni che si scontrano su un fondale alla Caspar David Friedrich).
Che dite?
DM
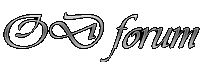
 )!
)!